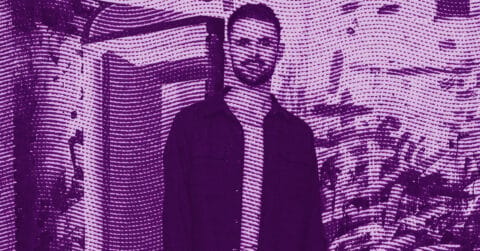Ascoltatemi bene, banda di snob : Bianca Bondi non è di quelle che vi lasciano indifferenti. Questa artista sudafricana e italiana, nata nel 1986, sviluppa da oltre un decennio un universo dove la materia vivente dialoga con l’invisibile, dove gli armadi carbonizzati si affiancano ai cristalli di sale, dove l’architettura della memoria si fonde con i vestigi delle civiltà antiche. Studiosa alla Villa Medici nel 2024 e finalista del Premio Marcel-Duchamp 2025, Bondi si impone come una figura imprescindibile dell’arte contemporanea, nonostante, anzi proprio grazie all’insolenza tranquilla della sua pratica. Infatti, laddove altri cercherebbero di domare la natura, lei le rende i suoi diritti; dove alcuni vorrebbero fissare il tempo, lei celebra il suo scorrere inevitabile.
L’architettura come teatro dell’assenza
Il lavoro di Bondi si sviluppa prima di tutto in una meditazione sull’abitare, su quelle strutture che costruiamo per proteggerci dal mondo e che finiscono per riportare le stigmate del nostro passaggio effimero. La sua installazione Silent House, presentata al Musée d’Art Moderne de Paris, incarna questa riflessione in modo toccante: una casa intera svuotata dei suoi abitanti ma saturata della loro presenza spettrale. Questa casa non è semplicemente uno spazio domestico abbandonato; è la mappatura sensibile di un’intimità perduta, un rilievo topografico di ciò che rimane dopo la partenza. I mobili logori, la vasca da bagno su piedi, la struttura del letto metallica arrugginita compongono una geografia della desolazione che non ha nulla di miserabile. Al contrario, questi oggetti emanano una dignità paradossale, quella dei testimoni silenziosi che hanno visto passare corpi e anime.
L’artista non si limita a disporre mobili in uno spazio espositivo. Organizza una vera e propria drammaturgia architettonica dove ogni elemento gioca un ruolo preciso nella narrazione dell’assenza. L’armadio carbonizzato, fissato verticalmente al muro, non è più un semplice mobile per riporre ma diventa un portale verso un altrove indeterminato, reliquiario carbonizzato di una memoria che rifiuta di spegnersi. Questo gesto di verticalizzazione trasforma l’uso orizzontale della domesticità in un’elevazione quasi religiosa, suggerendo che l’architettura non è mai solo funzionale ma sempre simbolica. Bondi lo afferma lei stessa: “Ho sempre adorato guardare gli altari, quegli spazi pensati per qualcosa di più grande di noi, per gli dèi” [1]. Questa dichiarazione illumina tutta la sua pratica: ogni installazione diventa un altare laico dedicato alle forze misteriose che animano la materia.
L’architettura in Bondi non è mai statica. È processo, metamorfosi e decomposizione. Le vasche saline che integra nelle sue installazioni funzionano come orologi chimici che segnano il passare del tempo non con il movimento delle lancette ma con la lenta cristallizzazione del sale sulle superfici. Il sale, materiale ricorrente nella sua opera, possiede questa duplice proprietà di essere al contempo agente di conservazione e vettore di corrosione. Preserva e distrugge simultaneamente, come la memoria umana che deforma ciò che pretende di salvaguardare. In Silent House, il sale riveste progressivamente gli oggetti con una pellicola biancastra, come se la casa stessa secernesse la propria materia funeraria, il proprio lenzuolo minerale.
Questa attenzione rivolta agli armadi, alle vetrine, agli scaffali rivela un’ossessione per le architetture dell’intimo, quegli micro-spazi di conservazione dove si concentra il nostro rapporto con gli oggetti. Bondi colleziona mobili antichi, in particolare quei mobili farmaceutici di cui ormai non si sa più se contenessero spezie o medicinali, rimedi o veleni. Questa indecisione semiologica le piace: confonde i confini tra cura e pericolo, tra cucina e laboratorio, tra domesticità e scienza. Gli armadi diventano allora camere d’eco dove risuonano tutte le possibili storie degli oggetti che hanno ospitato. La loro aura, per riprendere un concetto che Bondi maneggia con abilità, non deriva dalla loro bellezza formale ma dalla loro capacità di essere stati testimoni muti di gesti ripetuti, di mani che cercavano una boccetta nell’oscurità.
La casa secondo Bondi non è mai chiusa su se stessa. Trabocca, si espande, contamina lo spazio espositivo. Le installazioni creano paesaggi interni in cui il visitatore non sa più bene se stia entrando in una stanza, un giardino o un santuario. Questa confusione di generi è voluta: mira a ricostruire l’esperienza primordiale dell’abitazione prima che l’architettura si codifichi in stanze distinte e funzioni separate. Quando Bondi installa tre tonnellate di sale sul pavimento, non crea un semplice effetto visivo; trasforma il pavimento in una spiaggia minerale, in un deserto domestico dove il piede affonda come nella neve chimica. Il suolo diventa instabile, inquietante, e questa instabilità fisica si doppia di un’instabilità temporale: siamo prima o dopo il disastro? In uno spazio in rovina o in gestazione?
L’architetto italiano Carlo Scarpa diceva che “l’architettura è l’arte di costruire rovine”. Bondi sembra prendere questa massima alla lettera: costruisce rovine contemporanee, spazi che portano già in sé i segni della loro futura decomposizione. Ma queste rovine non sono malinconiche. Vibrano di un’energia particolare, quella delle metamorfosi in corso, dei processi chimici che trasformano lentamente i materiali. L’umidità si infiltra, il rame si copre di verdigris, le piante si seccano per poi rigenerarsi. La casa vive, nel senso più letterale del termine, e questa vita autonoma dei materiali sfugge parzialmente al controllo dell’artista. Bondi lo riconosce volentieri: “I materiali vivono la loro vita. Mi piace dire che stabilisco le condizioni nelle quali ho un’idea di ciò che accadrà, ma poi i materiali fanno il loro corso” [2].
Le stratificazioni della storia e i rituali dimenticati
Se l’architettura domestica fornisce a Bondi il quadro spaziale delle sue installazioni, è la storia antica che le offre la profondità temporale necessaria all’elaborazione delle sue mitologie personali. L’artista non si limita a riferirsi al passato; lo chiama, lo riattiva, lo fa dialogare con il presente in una temporalità non lineare dove l’Egitto faraonico affianca la Roma imperiale e il Sudafrica post-apartheid. Questa polifonia storica non è mai gratuita: risponde a un bisogno di situare la pratica artistica in una genealogia lunga che supera le mode contemporanee e si inscrive nella durata delle civiltà.
La residenza alla Villa Medici ha intensificato questa meditazione sulla storia. Roma, con i suoi strati archeologici e i suoi testimoni architettonici, offriva un terreno ideale per un’artista preoccupata dai cicli di vita e di morte. Bondi vi ha sviluppato un progetto di “reinselvatichimento” del Bosco, quel bosco di querce misterioso dell’Académie de France a Roma. Il concetto di rewilding, preso in prestito dalla biologia della conservazione, assume in lei una dimensione simbolica: non si tratta solo di restituire la natura a se stessa, ma di riconnettere le pratiche artistiche contemporanee con rituali ancestrali che sono stati progressivamente dimenticati o repressi. Gli alveari abbandonati che ha riattivato installandovi un polittico del XIX secolo impregnato di feromoni ed essenze antiche testimoniano questa volontà di creare ponti tra epoche, tra pratiche spirituali ed ecologia.
Le anfore romane che integra nelle sue installazioni non sono semplici riferimenti classici. Funzionano come contenitori simbolici che hanno attraversato i millenni portando a turno vino, olio, miele, profumi. Questi vasi testimoniano una civiltà che attribuiva una considerevole importanza alle sostanze, ai fluidi, alle essenze. Bondi riattiva questa attenzione rivolta alle materie liquide creando le proprie soluzioni colorate che evolvono nel tempo. Il blu vira al lilla, il lilla tende al porpora, in un cromatismo lento che evoca tanto le tinture antiche quanto le reazioni chimiche di laboratorio. Questi bacini di colore non sono semplici elementi decorativi: sono orologi biologici che segnano il passaggio del tempo alla scala molecolare.
L’antico Egitto costituisce un altro riferimento maggiore nel lavoro di Bondi, particolarmente attraverso l’uso dell’amaranto. Questa pianta, che lei apprezza “per il suo ruolo nelle cerimonie funebri dell’antico Egitto e per le sue qualità estetiche”, incarna questa continuità tra pratiche rituali e sensibilità contemporanea. Gli amaranti cadono e scorrono come lacrime, creando una poesia vegetale della malinconia che ricorda che la bellezza si trova spesso nella decadenza e nel deperimento. Scegliendo piante cariche di simbolismo storico, Bondi rifiuta la neutralità asettica di alcune pratiche artistiche contemporanee per assumere pienamente la dimensione spirituale e cultuale del suo lavoro.
Il sale, ancora lui, possiede una dimensione storica e antropologica considerevole. Utilizzato per la conservazione degli alimenti fin dall’Antichità, presente in tutte le religioni e pratiche spirituali come agente di purificazione e protezione, il sale attraversa le civiltà come un filo rosso. Bondi sfrutta questa ubiquità simbolica associandola alle sue proprietà chimiche contemporanee: il cloruro di sodio come conservante ma anche come agente corrosivo che altera e trasforma. Nelle sue installazioni, il sale non è mai innocente; porta in sé tutta la storia dei corpi che ha preservato, delle ferite che ha disinfettato, delle alleanze che ha sigillato. Quando ricopre uno scheletro di balena in resina di cristalli salini, non fa che illustrare un processo naturale; riattiva un rito funebre arcaico in cui il mare riprende ciò che gli appartiene.
La storia in Bondi non è mai accademica né distante. Si incarna in gesti concreti: bruciare un armadio per purificarlo, ricoprire un crocifisso di cera d’api per trasformarlo in un reliquiario pagano, piantare vegetali endemici per ancorare l’opera al territorio. Questi gesti appartengono a un repertorio antropologico universale che si ritrova in tutte le culture: il fuoco come agente di trasformazione e rigenerazione, la cera come materia sacra prodotta dalle api, le piante come mediatrici tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Mobilitando questi elementi, Bondi non fa folklore né esotismo: riattiva conoscenze ancestrali che sono state marginalizzate dalla razionalità moderna ma che continuano a risuonare al livello più profondo del nostro psichismo collettivo.
La pratica della magia Wicca che rivendica sin dall’infanzia non è aneddotica nel suo approccio. Spiega: “Penso che sia stata la mia pratica della magia a permettermi di scoprire l’arte, che è poi diventata un’estensione della magia e ha preso il sopravvento. Ma oggi sento questo bisogno di riportare la magia nell’arte” [3]. Questa dichiarazione potrebbe sembrare ingenua o provocatoria se non fosse supportata da una pratica rigorosa e da una conoscenza approfondita dei materiali. Bondi non fa la strega: applica all’arte contemporanea metodologie provenienti da tradizioni spirituali che attribuiscono un’agentività agli oggetti e alle sostanze. Questo approccio la avvicina paradossalmente ad alcune teorie filosofiche recenti, in particolare a quelle sviluppate da Bruno Latour intorno agli “oggetti attanti”, anche se Bondi arriva a queste conclusioni attraverso un percorso radicalmente diverso, quello dell’esperienza sensibile piuttosto che della speculazione teorica [4].
La storia secondo Bondi non è dunque mai una scenografia né un serbatoio di riferimenti eruditi. È una materia viva, porosa, che continua ad agire sul presente. Le civiltà antiche non sono scomparse: persistono nei nostri gesti quotidiani, nel nostro rapporto con gli oggetti, nei nostri rituali inconsci. Facendo dialogare anfore romane con mobili da farmacia del XIX secolo e piante contemporanee, Bondi rifiuta la linearità del progresso per proporre una visione ciclica e stratificata del tempo in cui passato e presente coesistono e si contaminano reciprocamente.
Verso una poetica dell’instabilità
Ciò che colpisce in Bondi, al di là della bellezza indiscutibile delle sue installazioni, è il rifiuto del controllo totale. In un mondo artistico spesso ossessionato dal controllo e dalla perfezione tecnica, lei assume l’imprevedibilità dei processi che avvia. Questa umiltà di fronte ai materiali, questa accettazione che l’opera possiede una vita autonoma che sfugge parzialmente al suo creatore, costituisce forse il suo contributo più radicale all’arte contemporanea. Ereditando certamente dall’Arte Povera italiano questa attenzione dedicata ai materiali poveri e questa volontà di lasciare che la materia si esprima autonomamente, vi aggiunge una dimensione temporale e spirituale a lei propria. Dove gli artisti dell’Arte Povera spesso lavoravano con materiali inerti, Bondi privilegia sostanze vive, organiche, volatili che si trasformano sotto i nostri occhi.
Questa instabilità costitutiva della sua opera interroga il nostro rapporto con la perennità e la conservazione. In un sistema dell’arte che tradizionalmente valorizza l’opera come oggetto stabile destinato a attraversare i secoli, Bondi propone pezzi che cambiano, si degradano, si rigenerano. Esistono meno come oggetti fissi che come processi in corso, come stati transitori di una materia in perpetuo mutamento. Questo approccio pone ovviamente questioni pragmatiche ai collezionisti e alle istituzioni, ma riflette anche una visione filosofica profonda sulla natura stessa dell’esistenza: tutto è flusso, tutto è trasformazione, e desiderare di fissare la vita in forme permanenti è un’illusione mortifera.
L’attenzione che Bondi dedica alle piante endemiche testimonia una coscienza ecologica che non si limita al discorso ma si incarna nella pratica. Usando sistematicamente vegetali locali nelle sue installazioni, lei inscrive il suo lavoro nel territorio dove si sviluppa e rifiuta l’universalismo astratto di alcune pratiche artistiche contemporanee. Ogni installazione diventa così una celebrazione della biodiversità locale, un omaggio agli ecosistemi specifici che costituiscono la vera ricchezza del mondo di fronte all’uniformazione globalizzata. Questo approccio risuona particolarmente oggi, in un’epoca in cui la crisi ecologica ci costringe a ripensare i nostri modi di abitare e produrre.
Bondi si colloca all’incrocio di diverse tradizioni e influenze. Il suo percorso biografico, nata a Johannesburg, formata in Sudafrica poi in Francia, residente in Italia, la rende un’artista transculturale che rifiuta appartenenze uniche. Questa molteplicità identitaria si riflette nella sua opera che convoca simultaneamente le tradizioni africane, europee e universali senza mai ridursi a una sola di esse. Ella incarna quella generazione di artisti per cui i confini nazionali sono diventati porosi e che costruiscono il loro vocabolario plastico a partire da prestiti assunti e riappropriati.
La sua nomination al Prix Marcel-Duchamp, accanto a Eva Nielsen, Lionel Sabatté e Xie Lei, consacra un percorso ascendente notevole. Ma al di là del riconoscimento istituzionale, ciò che conta in Bondi è la coerenza di una visione che si afferma da più di un decennio con rara costanza. Dalla cucina coperta di sale presentata alla Biennale di Lione nel 2019 a Silent House esposta al Musée d’Art Moderne di Parigi nel 2025, ritroviamo le medesime ossessioni: l’architettura domestica come scena dell’assenza, i materiali organici come agenti di trasformazione, la storia antica come serbatoio simbolico, la spiritualità come modo di conoscere il mondo.
Alcuni potrebbero rimproverare a Bondi una forma di esoterismo che sfiora l’oscurantismo. Sarebbe tuttavia non riconoscere la rigorosità del suo approccio e la precisione del suo lavoro con i materiali. Se si distacca progressivamente dalle collaborazioni con gli scienziati, è proprio perché la terminologia scientifica e la metodologia sperimentale non corrispondono al suo modo intuitivo di comprendere i processi chimici. Ma questa intuizione non è ignoranza: deriva da una conoscenza sensibile accumulata nel corso degli anni, da una familiarità intima con i comportamenti del sale, della cera, delle piante. Qui si potrebbe parlare di una scienza vernacolare, di un sapere artigianale che non passa per i protocolli accademici ma che rimane comunque rigoroso nella sua applicazione.
La questione del rinnovato incanto del mondo, centrale per Bondi, non deriva da una nostalgia regressiva per un’età dell’oro mitica in cui l’umanità viveva in armonia con la natura. Si tratta piuttosto di riconoscere che la razionalità strumentale moderna, nonostante tutti i suoi indiscutibili benefici, ha impoverito il nostro rapporto sensibile con il mondo riducendo gli oggetti al loro semplice valore d’uso. Rincantare gli oggetti quotidiani significa restituire loro questo spessore simbolico, questa capacità di portare un senso che va oltre la loro funzione immediata. Un armadio non è mai solo un armadio: è anche il contenitore degli abiti che hanno toccato la nostra pelle, degli odori che vi si sono accumulati, dei segreti che vi abbiamo nascosto. Bondi ci ricorda questa evidenza che tendiamo a dimenticare.
Al termine di questo percorso attraverso l’opera di Bianca Bondi, un’evidenza si impone: ci troviamo di fronte a un’artista di grande rilievo il cui lavoro continuerà a svilupparsi e a sorprenderci negli anni a venire. La sua installazione Silent House non è un punto d’arrivo ma una tappa in una ricerca che non smette di approfondirsi. Questa casa silenziosa parla però eloquentemente della nostra condizione contemporanea: abitiamo luoghi che ci sopravvivranno, manipoliamo oggetti che porteranno traccia del nostro passaggio, apparteniamo a una catena storica che ci precede e ci supera infinitamente. Di fronte a questa consapevolezza acuta della nostra finitezza, Bondi non propone né facili consolazioni né disperazione compiacente. Ci invita semplicemente ad osservare con attenzione le lente metamorfosi che ci circondano, ad accettare l’instabilità come condizione fondamentale dell’esistenza e a celebrare la bellezza paradossale che emana dai processi di trasformazione e di degrado. Forse è proprio questo, in fondo, il senso profondo del suo lavoro: insegnarci a contemplare la rovina non come una fine ma come una promessa, quella di una rigenerazione possibile a partire dalle rovine. In un mondo che corre verso la propria distruzione con una precipitazione inquietante, questa lezione di umiltà e resilienza risuona con un’urgenza particolare.
- Centre Pompidou, “Quando la magia incontra l’arte; l’universo incantevole di Bianca Bondi”, Pompidou+, 2025.
- Art Basel, “Premio Marcel Duchamp 2025: Bianca Bondi”, settembre 2025.
- Ibid.
- CRAC Occitanie, “Mostre Alexandra Bircken & Bianca Bondi”, Sète, 2022.