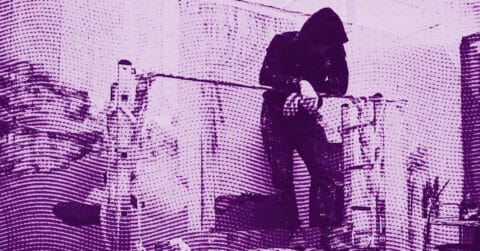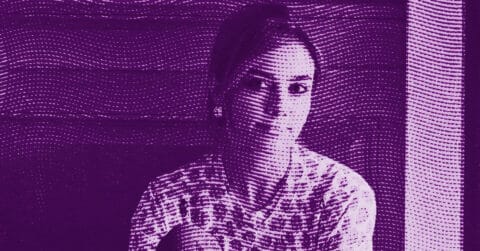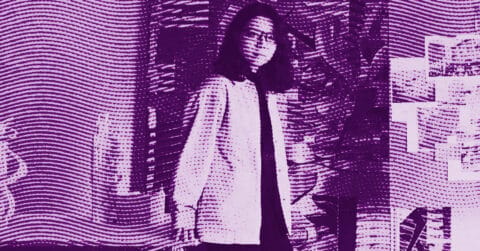Ascoltatemi bene, banda di snob: mentre voi vi estasiate davanti alle ultime installazioni concettuali dove tre patate dialogano con un neon lampeggiante, un uomo dipinge. Dipinge veramente, con olio, tela, tempo e silenzio. Bilal Hamdad, nato a Sidi Bel Abbès nel 1987, non chiede né la vostra benedizione né la vostra indulgenza. Si limita a catturare quel Parigi che attraversate senza vederlo, quei volti che incrociate senza guardarli, quegli istanti che cancellate non appena vissuti. Il suo pennello non è uno strumento di riproduzione ma un bisturi che disseziona l’invisibile presente delle nostre metropoli.
La pittura di Hamdad disturba perché rifiuta le facilità del discorso convenzionale. Si vorrebbe rinchiuderlo nella comoda gabbia dell””iperrealismo””, quella categoria contenitore che dispensa dal pensare. È molto più di questo. Guardate davvero le sue tele: i corpi si dissolvono nell’ombra, i volti diventano spettri dietro i vetri, la materia pittorica pulsa e vibra lontano da ogni imitazione servile. Hamdad non copia la realtà, la ricompone partendo da decine di fotografie per estrarne una verità che l’occhio frettoloso non potrebbe percepire. Le sue grandi composizioni, di due metri, a volte di più, ci obbligano a rallentare, a rimanere, ad accettare il disagio della contemplazione.
L’ermeneutica urbana
Il metodo di Hamdad trova un’eco singolare nel pensiero del sociologo tedesco Siegfried Kracauer, figura intellettuale di rilievo della Repubblica di Weimar. Kracauer sviluppò quella che chiamò un’ermeneutica della superficie, metodo d’analisi che considera che “il luogo che un’epoca occupa nel processo storico si determina in maniera più pertinente a partire dall’analisi delle sue manifestazioni discrete di superficie, che dai giudizi che essa stessa dà su di sé” [1]. Questo approccio, radicalmente opposto alle grandi sintesi teoriche astratte, privilegia l’osservazione minuziosa dei dettagli apparentemente insignificanti della vita urbana. Il cinema, l’architettura, gli spostamenti nella metropolitana, le posture corporee: tutto diventa materiale di comprensione sociologica.
Hamdad procede esattamente così. I suoi dipinti non cercano di illustrare concetti prestabiliti sulla solitudine o l’alienazione contemporanea. L’artista stesso lo precisa: non definisce mai un soggetto prima di iniziare una tela, parte da un desiderio di dipingere piuttosto che da un discorso. Le sue tele costituiscono un archivio visivo delle manifestazioni superficiali della nostra epoca: la maschera sanitaria, il cellulare, il pittogramma wifi, il venditore ambulante di mais davanti a Barbès-Rochechouart. Questi elementi non sono simboli aggiunti artificialmente, ma le tracce autentiche di un momento storico preciso. Come Kracauer scrutava le hall degli hotel berlinesi o gli spettacoli di varietà per scorgere le strutture profonde della modernità capitalista, Hamdad ausculta le banchine della metropolitana e le uscite degli scale mobili per rivelare le configurazioni contemporanee dell’esistenza urbana.
La stazione Arts et Métiers in Le Mirage, con le sue pareti di rame che evocano il Nautilus, diventa così più di una semplice scenografia. Incorpora quegli spazi non luogo teorizzati dall’antropologo Marc Augé, spazi intercambiabili della surmodernità dove l’individuo resta anonimo. Ma Hamdad va oltre: attraverso il gioco dei riflessi sulle superfici metalliche, moltiplica gli angoli di visione, svelando ciò che l’osservazione diretta nasconde. La passante si rivela di profilo, mascherata, assorbita dal suo schermo. Questa moltiplicazione del visibile dal visibile stesso costituisce un mise en abyme del metodo sociologico di Kracauer. Le superfici riflettenti non mentono; espongono ciò che lo sguardo abituato non si prende più la briga di notare.
Il metodo di Hamdad condivide con quello di Kracauer un’attenzione ossessiva ai ritmi e ai gesti della vita quotidiana metropolitana. In Escale II o L’Attente, i personaggi sono colti in questi momenti di sospensione temporale caratteristici dell’esperienza urbana: si aspetta, si transita, si esiste nell’intervallo. Questi istanti vuoti, che la filosofia classica giudicherebbe indegni di attenzione, diventano in Hamdad rivelatori sociali di primaria importanza. Espongono i rapporti dell’individuo con lo spazio pubblico, le strategie di ritiro o presenza, i micro-comportamenti che strutturano la vita collettiva senza mai divenire oggetto di consapevolezza esplicita.
Rive droite, questo vasto affresco dell’uscita della metro Barbès-Rochechouart, porta questa logica al suo parossismo. Hamdad qui dispiega un vero e proprio campionamento sociologico della metropoli contemporanea: il venditore africano, i passanti frettolosi, gli agenti con pettorina gialla, la coppia che si tiene per mano. Ogni dettaglio conta, ogni presenza parla. La targa commemorativa che ricorda l’attentato del colonnello Fabien contro l’occupante nazista rimane imbrattata di graffiti, come se la memoria collettiva avesse abdicato davanti all’urgenza del presente. Questa giustapposizione del memoriale e dell’attuale, dello storico e del banale, costituisce precisamente ciò che Kracauer chiamava l’analisi delle “manifestazioni discrete di superficie”. L’epoca si rivela in ciò che trascura quanto in ciò che celebra.
La poetica del fuggevole
L’opera di Hamdad richiama inoltre, per una necessità interna piuttosto che per vanità culturale, l’universo poetico di Charles Baudelaire. Il poeta delle Fleurs du mal fu il primo a teorizzare la modernità come esperienza del transitorio, del fugace, del contingente. Il suo sonetto “À une passante”, spesso citato in relazione a Hamdad, riassume questa estetica dell’istante: “Un éclair… puis la nuit ! Fugitive beauté / Dont le regard m’a fait soudainement renaître / Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?” [2]. Questo incontro abortito, questa presenza che emerge e svanisce, struttura tanto la poesia baudelairiana quanto la pittura di Hamdad.
Le Mirage ne è l’esempio più eclatante. La donna di spalle nella metro, rivelata dai suoi riflessi, incarna perfettamente questa “fugitive beauté” baudelairiana. Esiste per lo spettatore solo in quell’istante sospeso, quel corto circuito temporale in cui il visibile si sdoppia e si sottrae simultaneamente. Non la rivedremo mai più, eppure rimane fissata sulla tela, eternata nella sua fuga stessa. Questa dialettica baudelairiana del fugace e dell’eterno attraversa tutta l’opera di Hamdad. I suoi personaggi sono sempre in transito, mai veramente qui, già altrove nella loro testa o sul loro schermo. Abitano questo tempo specificamente moderno che Baudelaire fu il primo a nominare: un presente senza spessore, diviso tra la memoria e l’anticipazione.
La nozione baudelairiana del “peintre de la vie moderne” illumina anche l’approccio di Hamdad. Baudelaire celebrava Constantin Guys per la sua capacità di cogliere “l’effimero, il fugace, il contingente, metà dell’arte, di cui l’altra metà è l’eterno e l’immutabile”. Hamdad procede esattamente così nelle sue grandi composizioni urbane. Cattura l’effimero, quel passante, quella luce, quel gesto, ma li carica di una densità pittorica che li fa oscillare in una temporalità altra, quella dell’opera d’arte. Le tende Quechua dei senza tetto, i gilet blu del Samu social, le uniformi della polizia: tanti dettagli contingenti che, sotto il pennello di Hamdad, acquisiscono una gravità quasi archeologica. Questi oggetti testimoniano, costituiscono i fossili ancora caldi di un’epoca che si osserva senza comprendersi.
La malinconia di Baudelaire impregna anche le tele di Hamdad, quella “melancolia gloriosa” che il poeta associava alla modernità. Patrick Modiano, la cui citazione apre il catalogo della mostra Solitudes croisées, prosegue questo affetto baudelairiano nella Parigi contemporanea: “Esistevano a Parigi zone intermedie, zone di nessuno dove si era al confine di tutto, in transito, o addirittura in sospensione” [3]. Queste zone, Hamdad le dipinge incessantemente. Sono i suoi territori d’elezione: i parcheggi, i corridoi della metropolitana, i marciapiedi deserti di Saint-Rémy-de-Provence. Spazi di passaggio che diventano, sotto il suo sguardo, luoghi di una strana poesia urbana, allo stesso tempo familiari e inquietanti.
La folla solitaria, tema centrale della modernità baudelairiana, trova in Hamdad una traduzione pittorica impressionante. In Rive droite, ogni personaggio è solo nella folla, rinchiuso nella sua bolla percettiva. Si sfiorano senza vedersi, si accostano senza toccarsi realmente. Questa prossimità senza contatto, questa copresenza senza relazione, definisce l’esperienza metropolitana sin da Baudelaire. Hamdad non vi aggiunge nessun pathos superfluo, nessun commento morale. Mostra, semplicemente, e questo mostrare basta a rivelare l’architettura affettiva del nostro tempo. Volti abbassati, sguardi distolti, assorbimento negli schermi: tante strategie di ritiro che trasformano lo spazio pubblico in un arcipelago di solitudini giustapposte.
La pittura come atto politico
Sarebbe comodo ma falso ridurre l’opera di Hamdad a un triste bilancio sull’alienazione contemporanea. La sua pittura porta una carica politica che non dice il proprio nome, che rifiuta il militantismo chiassoso preferendo l’efficacia discreta del mostrare. Quando Hamdad dipinge le tende dei migranti in architetture dismesse, quando rappresenta i senzatetto rannicchiati nei loro sacchi a pelo, quando coglie i lavoratori precari e i venditori ambulanti, compie un gesto politico importante: rende visibile ciò che la società preferisce non vedere. Come scrive Virginie Despentes in una citazione riportata dal catalogo, siamo “vaccinati come molti cittadini, abituati alla miseria degli altri, ma sempre un po’ vergognosi di distogliere lo sguardo”. La pittura di Hamdad ci impedisce di distogliere lo sguardo.
Questa dimensione politica si inscrive in una filiazione rivendicata con Gustave Courbet. Rive droite riprende esplicitamente la struttura di L’Atelier du peintre, trasponendo l’allegoria realista del XIX secolo nella Parigi cosmopolita del XXI secolo. Come Courbet mostrava “la società nel suo alto, nel suo basso, nel suo mezzo”, Hamdad dispiega una cartografia sociale della metropoli contemporanea. Il nudo di Courbet diventa un manifesto pubblicitario, il paesaggio campestre diventa una mappa della metropolitana, ma il principio rimane: la pittura come luogo di rassemblement simbolico di tutti gli strati sociali. Hamdad aggiorna così il progetto realistico di Courbet, mostrando che la grande pittura può ancora raccontare il mondo senza ricorrere alle facilità dell’astrazione o alle acrobazie concettuali.
Le scelte formali di Hamdad partecipano anch’esse a questa postura politica. I suoi grandi formati, utilizza volontariamente le dimensioni della pittura storica, affermano l’importanza dei suoi soggetti. Un senzatetto, un’uscita della metropolitana, un venditore di mais meritano questi due metri di tela che l’accademismo riservava agli eroi e agli dei. Questo gesto di scala costituisce di per sé un atto di resistenza contro la gerarchia dei soggetti che perdura segretamente nel mondo dell’arte. Hamdad proclama con i suoi formati che queste esistenze anonime possiedono una dignità pittorica equivalente a quella dei potenti. C’è qualcosa di profondamente democratico in questo, nel senso più nobile del termine.
La pittura come esercizio dello sguardo
L’opera di Bilal Hamdad si impone oggi come una delle più necessarie della scena artistica francese. Non per virtuosismo tecnico, anche se questo è indiscutibile, né per originalità formale, benché esista. Si impone perché compie ciò che solo la pittura può compiere: ci insegna a guardare ciò che vediamo. Tra Kracauer e Baudelaire, tra sociologia della superficie e poetica del fuggevole, Hamdad costruisce un’archeologia visiva del presente. Le sue tele funzionano come rallentatori temporali, ostacoli salutari opposti alla velocità che ci acceca.
La sua mostra museale intitolata “Paname”, organizzata con il sostegno della galleria Templon, attualmente visibile al Petit Palais e fino all’8 febbraio 2026, segna un meritato riconoscimento istituzionale. Di fronte ai Courbet e ai Lhermitte, le sue tele non fanno brutta figura. Dialogano alla pari con i maestri, dimostrando che la grande pittura figurativa non è morta, che non è nemmeno malata. Essa esige semplicemente pittori capaci di sostenerla, artisti che accettano la lentezza del medium, l’esigenza dello sguardo, il rifiuto delle scorciatoie concettuali. Hamdad è tra questi. Dipinge perché non può non dipingere, perché la pittura rimane lo strumento più preciso per cogliere le infinite sfumature del visibile.
Oltre alle etichette comode, iperrealismo, realismo sociale, pittura urbana, l’opera di Hamdad pone una domanda semplice ma vertiginosa: cosa vediamo quando guardiamo? Le sue tele suggeriscono che non vediamo quasi nulla, che il nostro sguardo scivola sulle superfici senza mai fermarsi veramente. Il pittore, invece, guarda. Guarda con ostinazione, con metodo, anche con amore. Guarda questa città in cui abitiamo senza esserne parte, questi volti che incontriamo senza incontrarli veramente, questi istanti che viviamo senza viverli davvero. E mostrandoci il risultato di questo sguardo paziente, ci offre la possibilità di vedere finalmente, forse, un po’ di ciò che costituisce la nostra condizione contemporanea.
Il futuro dirà se Hamdad entrerà nel pantheon dei grandi pittori della modernità urbana, accanto a un Hopper o a un Hammershøi. Per ora, dipinge. Dipinge questo Parigi del 2025, questa metropoli saturata e solitaria, violenta e fragile, cosmopolita e segregata. Dipinge senza nostalgia per un passato mitizzato, senza cinismo di fronte al presente, senza illusione sul futuro. Dipinge perché dipingere, oggi, costituisce di per sé un atto di resistenza contro l’impero delle immagini usa e getta e dei discorsi vuoti. In un mondo che privilegia la velocità e l’oblio, Hamdad sceglie la lentezza e la memoria. Il suo pennello incide nella materia pittorica frammenti di esistenza che, senza di lui, si sarebbero dissolti nel flusso indifferenziato del tempo. Questo è forse il gesto essenziale dell’arte: strappare all’oblio alcuni frammenti di verità, e offrirli a coloro che accettano ancora di guardare veramente.
- Siegfried Kracauer, citato nel catalogo della mostra Solitudes croisées, 2022, testo di Hélianthe Bourdeaux-Maurin
- Charles Baudelaire, “A una passante”, Les Fleurs du mal, 1857
- Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, citato nel catalogo della mostra Solitudes croisées, 2022