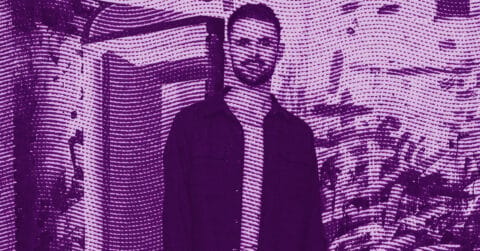Ascoltatemi bene, banda di snob: Calvin Marcus non vi chiederà mai il permesso di dispiacervi. Questo artista californiano, nato a San Francisco nel 1988, costruisce da un decennio un’opera che rifiuta ostinatamente ogni forma di conforto intellettuale. I suoi dipinti di soldati morti, i suoi autoritratti con la lingua penzoloni, i suoi storioni smisurati distesi su tele lunghe come limousine, tutto ciò fa parte di una strategia deliberata di elusione, di un rifiuto sistematico di farsi incasellare in qualche categoria. Marcus lavora in serie stilisticamente distinte, sviluppando per ogni corpus nuove metodologie materiali che sondano soggetti inquietanti, sia psichici che sociali, attraverso una varietà di medium. Come spiega lui stesso senza mezzi termini: “Non provo alcuna lealtà verso un medium particolare, lascio che l’idea detti la forma e parto da lì” [1].
Questa fluidità formale non è una capriccio estetico in cerca di riconoscimento. Al contrario, rivela una posizione filosofica profondamente radicata nel pensiero esistenzialista, quella di un artista che rivendica la libertà come valore cardinale della sua pratica. Interrogato sul suo rapporto con la ragione e la logica, Marcus risponde con una franchezza disarmante: “Il mio rapporto con la ragione è il mio interesse per il cambiamento di sé; riconoscere che la libertà è ciò che voglio veramente per me stesso e per la mia arte” [2]. Questa dichiarazione risuona con particolare acutezza quando viene confrontata con i concetti sviluppati da Jean-Paul Sartre in L’essere e il nulla. Per Sartre, l’esistenza umana è definita dalla sua libertà radicale, da questa capacità, e condanna, di scegliersi costantemente. L’uomo di Sartre è “condannato a essere libero”, gettato in un mondo senza essenza predefinita, costretto a definirsi attraverso le sue azioni. Marcus sembra aver interiorizzato questa lezione con un’intelligenza notevole. Rifiutando di sviluppare un “marchio” riconoscibile, mutando stilisticamente da una mostra all’altra, si inscritto in questa tradizione esistenzialista che fa della libertà non un lusso ma una necessità ontologica.
Eppure, questa libertà rivendicata da Marcus non è mai leggera né spensierata. Porta con sé il peso dell’angoscia esistenziale, quella nausea sartiana che emerge quando si prende coscienza della propria contingenza. Le sue serie, i soldati morti del 2016, i pesci in ceramica sorridenti, i dipinti di erba resi meticolosamente, funzionano come altrettante esplorazioni di situazioni limite dove l’assurdo compete col tragico. La serie Were Good Men, presentata da Clearing nel 2016, offre un esempio particolarmente impressionante di questa tensione. Su trentanove tele monumentali, Marcus dispiega figure di soldati caduti in battaglia, rappresentati in uno stile che ricorda i disegni dei bambini, con linee grossolane e colori primari. Questi corpi contorti dai volti gonfi, tinta di viola, verde o marrone, con occhi sporgenti e lunghe lingue rosa pendenti, giacciono su masse erbose di un verde brillante. La forza dell’installazione risiedeva nella scala smisurata delle tele e nella loro disposizione labirintica, creando un’esperienza spaziale opprimente che intrappolava letteralmente lo spettatore in un universo di morte stilizzata. Queste immagini, paradossalmente silenziose sul piano visivo ed etico, pongono interrogativi vertiginosi sull’identità maschile, la rappresentazione, il potere e l’impulso all’autodistruzione.
L’opera di Marcus trova inoltre un’eco inquietante nel teatro dell’assurdo, e più particolarmente nell’universo di Samuel Beckett. Come i personaggi di Beckett, prigionieri di situazioni incomprensibili e ripetitive, i soggetti di Marcus sembrano sospesi in una temporalità indefinita, tra presenza e assenza, tra essere e nulla. Prendiamo En attendant Godot, questo capolavoro del teatro dell’assurdo in cui Vladimir ed Estragon aspettano indefinitamente un Godot che non arriverà mai. L’attesa, per Beckett, non è orientata a un fine ma costituisce l’essenza stessa dell’esistenza. Allo stesso modo, i soldati morti di Marcus non raccontano una storia di guerra particolare; incarnano la guerra in generale, spogliata di ogni contesto politico o sociale specifico. Sono figure in attesa di significato, corpi sospesi in uno stato che rifiuta sia la glorificazione eroica sia la denuncia militante. Questa apparente neutralità, lungi dall’essere una debolezza, costituisce forse la forza sovversiva di questi dipinti. Ci confrontano con l’assurdità fondamentale della violenza organizzata senza offrirci il conforto morale di una posizione ideologica chiara.
Il parallelo con Beckett si approfondisce esaminando la struttura seriale del lavoro di Marcus. Proprio come Beckett ripete situazioni e motivi nella sua ostinata ricerca di un nucleo di verità sempre sfuggente, Marcus rivisita alcuni temi, l’autoritratto demoniaco, gli oggetti quotidiani esaltati o deformati, in variazioni che non procedono linearmente ma ruotano intorno a un centro assente. In Fin de partie, Beckett mette in scena Hamm, cieco e paralizzato, e il suo servitore Clov, in un rituale quotidiano privo di finalità. Il mondo si disfa lentamente, senza catastrofi, in un’agonia che rifiuta di concludersi. Le ceramiche di pesci sorridenti di Marcus, presentate nei loro diversi contesti (un piatto di spaghetti, un guscio di ostrica), possiedono la stessa qualità di straniamento familiare, quell’oscillazione tra ingenuità e minaccia che caratterizza l’universo di Beckett. Questi piccoli mondi autosufficienti, fragili e al contempo ermetici, sembrano altrettanto privati e universali quanto le profondità brulicanti dell’immaginazione di Marcus.
La questione della scala, ricorrente nel lavoro di Marcus, è particolarmente interessante. Le sue tele possono raggiungere la lunghezza di una limousine per ospitare storioni anormalmente lunghi; i suoi dipinti di erba esaltano dettagli solitamente relegati allo sfondo fino a farne l’unico soggetto di composizioni quadrate ossessive. Questo gioco di scala non è gratuito. Funziona come un dispositivo di attivazione dello spazio espositivo e di perturbazione dell’esperienza dello spettatore. Ingrandendo smisuratamente alcuni elementi, Marcus ci costringe a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo delle apparenze. Ciò che sembrava banale, un filo d’erba, un pesce in miniatura, acquisisce improvvisamente una presenza monumentale che altera la nostra percezione. Questa strategia ricorda i procedimenti del cinema espressionista dove la distorsione spaziale serviva a esternare gli stati psicologici. In Marcus, la scala diventa un linguaggio che esprime l’inquietante estraneità del reale. I cambiamenti di scala inattesi e la stranezza che essi generano costituiscono un tema pronunciato nella sua pratica, creando effetti visivi che oscillano tra incanto e grottesco.
Sarebbe allettante leggere l’opera di Marcus unicamente attraverso il prisma del surrealismo, etichetta che l’artista rifiuta esplicitamente: “No, ma capisco perché qualcuno potrebbe pensare che io mi interessi a questo” [2]. Questa negazione è rivelatrice. Marcus non cerca di accedere a un inconscio collettivo né di liberare le forze del sogno. Il suo approccio è più concreto e, paradossalmente, più destabilizzante. Lavora nel registro del deadpan, quel tono neutro e impassibile che rifiuta l’enfasi pur consegnando contenuti profondamente perturbanti. I suoi quadri “appaiono ingannevolmente riconoscibili a prima vista, sia per il loro soggetto, per la scena o per l’assurdità offerta, ma anche col minimo impegno, il senso cresce spesso fino al punto che l’ambiguità stessa sembra mostruosa” [3]. Questa capacità di rivelare il lato oscuro di un oggetto, di far emergere tramite una magnificazione intensa un terrore reale o immaginato, o un’inquietudine latente, costituisce uno dei talenti distintivi di Marcus.
Torniamo un attimo su questa nozione di libertà che sembra ossessionare il lavoro di Marcus. In un clima artistico contemporaneo in cui esiste “un desiderio di sviluppare qualcosa che abbia quasi lo status iconico di marchio”, Marcus rivendica il diritto all’elusione, alla fluidità, al cambiamento perpetuo [4]. Questa posizione non è senza ricordare la critica che Sartre faceva della “cattiva fede”, questa tendenza umana a fossilizzarsi in ruoli predefiniti per sfuggire all’angoscia della libertà. L’artista che sviluppa una “firma” riconoscibile si condanna alla ripetizione, si rinchiude in un’essenza che precede e limita la sua esistenza. Marcus rifiuta questa facilità con una determinazione feroce. Le sue esposizioni, descritte come “panorami strettamente costruiti” e “presentazioni labirintiche”, amplificano l’effetto inquietante delle sue opere creando al contempo esperienze immersive che intrappolano e disorientano lo spettatore. Questa messa in spazio non è mai banale: partecipa della stessa volontà di perturbazione, della stessa diffidenza verso il comfort percettivo.
Il percorso di Marcus, dalle sue prime mostre a Public Fiction e Peep-Hole fino alla sua partecipazione alla Biennale di Whitney nel 2019 e alle sue recenti esposizioni istituzionali al Museum Dhondt-Dhaenens in Belgio, rivela un’ascesa fulminante nel mondo dell’arte contemporanea. Le sue opere fanno ormai parte delle collezioni permanenti del Museum of Modern Art di New York, del Musée d’Art Moderne di Parigi, del Los Angeles County Museum of Art, tra altre istituzioni importanti. Questo riconoscimento istituzionale potrebbe sembrare in contraddizione con la posizione antisistemica dell’artista. Ma Marcus ha capito che si può giocare secondo le regole senza esserne ingannati, accettare le regole del mercato dell’arte senza rinunciare alla propria libertà creativa. Il suo approccio richiama quello di Philip Guston, una delle sue principali influenze, che abbandonò l’espressionismo astratto al culmine della sua gloria per tornare a una figurazione cartoonesca disturbante. Guston, come Francis Bacon e Paul Thek, gli altri riferimenti citati da Marcus, rifiutava la compiacenza e non esitava a tradire le aspettative del suo pubblico per rimanere fedele alla propria necessità interiore.
Il futuro di Marcus rimane deliberatamente imprevedibile. Ed è proprio questo che rende il suo lavoro così stimolante. In un mondo dell’arte spesso prigioniero dei propri codici, dove il riconoscimento passa dall’identificazione immediata di uno stile, Marcus propone un’alternativa rara: quella di un artista che si reinventa costantemente, che accetta il rischio di dispiacere e disorientare per preservare la sua libertà. Le sue opere non cercano di piacere né di scandalizzare per il semplice piacere della provocazione. Porgono domande scomode sull’identità, la rappresentazione, la violenza, la mascolinità, senza mai imporre risposte definitive. Ci confrontano con l’assurdità fondamentale dell’esistenza rifiutando però il cinismo nichilista. In ciò, si inscrivono pienamente nella tradizione esistenzialista che riconosce l’assurdo non come una fatalità paralizzante ma come il punto di partenza di una libertà autentica.
La pratica di Marcus ci ricorda che l’arte, nella sua forma migliore, non è un prodotto di consumo culturale ma un’esperienza che ci destabilizza e ci costringe a riconsiderare le nostre certezze. I suoi soldati morti non glorificano la guerra ma nemmeno la condannano in modo semplicistico; i suoi autoritratti demoniaci non rivelano alcuna verità psicologica trasparente; i suoi dipinti meticolosi d’erba non celebrano ingenuamente la natura. Tutto nella sua opera resiste all’interpretazione univoca, mantiene una tensione produttiva tra significati contraddittori. Questa ambiguità non è una debolezza ma il segno di un’intelligenza artistica che comprende che il mondo contemporaneo non si lascia afferrare con formule semplici. Di fronte alla complessità del reale, Marcus sceglie la moltiplicazione degli approcci, l’esplorazione senza fine, il rifiuto di fissarsi. Ci invita a fare altrettanto: ad accettare l’incertezza, ad abbracciare la libertà nel suo aspetto più vertiginoso. È una scommessa rischiosa, scomoda, spesso disorientante. Ed è anche ciò che rende il suo lavoro una delle avventure artistiche più stimolanti della sua generazione. L’opera di Calvin Marcus costituisce così un territorio instabile dove la bellezza convive con il disagio, dove l’umorismo sfiora l’orrore, dove ogni certezza viene subito smentita. È proprio in questa instabilità che risiede la sua forza: ci obbliga a rimanere svegli, vigili, incapaci di riposare su abitudini percettive confortevoli. Ci rende, spettatori, complici involontari di una ricerca che non avrà mai fine, di una libertà che non conoscerà mai riposo.
- Sito ufficiale di Karma, biografia di Calvin Marcus.
- Flaunt Magazine, intervista con Ben Noam, “Calvin Marcus: Home is where the undulating, wise, and aquarist scale is”.
- David Kordansky Gallery, testo per Frieze Seoul 2022.
- Louisiana Channel, “Calvin Marcus: I Want to Be Far from Polite”, giugno 2022.