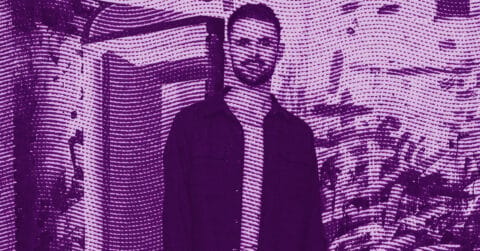Ascoltatemi bene, banda di snob: se credete ancora che la pittura contemporanea si riduca a tele bianche vendute a prezzi d’oro nelle fiere d’arte internazionali, Chase Hall è qui per ricordarvi che alcuni artisti osano ancora porre vere domande. Questo pittore americano di 32 anni, autodidatta dichiarato, costruisce da un decennio un’opera singolare che interroga l’identità meticcia, la costruzione di sé e la rappresentazione della nerezza in un’America che fatica ancora a guardare le proprie contraddizioni. Armato di caffè etiope e tela di cotone grezzo, Hall elabora un linguaggio visivo che rifiuta la facilità del pathos razziale pur assumendo pienamente la violenza storica inscritta nei suoi stessi materiali.
Nato a Saint Paul, Minnesota, da madre bianca e padre nero, Hall è cresciuto in una instabilità permanente, cambiando otto scuole prima dei sedici anni. Questa infanzia nomade, oscillante tra quartieri svantaggiati e zone benestanti, tra Chicago, Las Vegas, Colorado, Dubai e Los Angeles, ha forgiato in lui una coscienza acuta dei meccanismi di classe e razza che strutturano la società americana. Quando arriva a New York nel 2013 con l’ambizione di diventare fotogiornalista, non immagina ancora che la pittura diventerà il suo medium prediletto. Ma un incontro davanti a una tela di Henry Taylor al MoMA lo sconvolge fino alle lacrime. Quel momento di rivelazione estetica gli fa capire che l’arte pittorica può essere uno strumento di sopravvivenza, non solo un ornamento borghese.
La doppia coscienza come fondamento concettuale
Per comprendere l’architettura intellettuale che sostiene il lavoro di Hall, è necessario tornare a un testo fondativo del pensiero afroamericano. Nel 1903, W.E.B. Du Bois pubblica The Souls of Black Folk, opera in cui concettualizza la “doppia coscienza”: quella sensazione di essere sempre guardati attraverso gli occhi dell’altro, di “misurare la propria anima alla luce di un mondo che ti osserva con un disgusto beffardo e una pietà sprezzante” [1]. Du Bois scrive che l’afroamericano “sente sempre questa dualità: un Americano, un Nero; due anime, due pensieri, due aspirazioni inconciliabili; due ideali in guerra in un solo corpo scuro” [1]. Questa teorizzazione della soggettività razzializzata non è una semplice descrizione psicologica, ma un’analisi sociologica profonda di ciò che significa esistere dietro quello che Du Bois chiama il “velo”, questa barriera simbolica che separa i neri americani dal pieno riconoscimento della loro umanità.
Hall, in quanto uomo meticcio, conosce una versione particolarmente complessa di questa doppia coscienza. L’ha espresso senza mezzi termini: “Siete sempre ostracizzati perché non siete al cento per cento bianchi, e siete sempre vilipesi, senza ottenere l’amore completo di quello che sarebbe essere completamente Neri, senza una storia genetica coloniale”. Questa posizione interstiziale, che definisce come “ibridezza”, “dualità”, o addirittura “palindromica”, lo pone in un tra due che la società americana tradizionalmente rifiuta di riconoscere. Le regole storiche come la “one-drop rule” (che definisce come nero ogni persona che ha un antenato africano) o il “compromesso dei tre quinti” (che contava uno schiavo come tre quinti di una persona) hanno sempre funzionato sul principio dell’assoluto bianco: se non sei completamente bianco, allora sei nero. Hall rifiuta questa binarietà impoverente.
La sua pratica artistica diventa allora il luogo di un’indagine visiva di questa “dualità”. L’uso del caffè marrone su tela di cotone bianco non è una semplice scelta estetica: è una materializzazione letterale della doppia coscienza. Il caffè, coltivato principalmente in Africa e in America Latina, porta in sé la storia dello sfruttamento coloniale e del commercio triangolare. Il cotone, raccolto da schiavi nel Sud americano, rimane uno dei simboli più potenti dell’economia schiavista. Lasciando intenzionalmente zone di tela bianca, volti senza tratti, ginocchia bianche e organi genitali non dipinti, Hall crea quelli che chiama “punti di rifiuto”. Questi spazi negativi non sono assenze, ma presenze insistenti della bianchezza nel cuore stesso della rappresentazione della negritudine. È il velo di Du Bois, reso tangibile.
Ma Hall va oltre la semplice illustrazione della teoria di W.E.B. Du Bois. Dove Du Bois descriveva l’esperienza dei Neri americani la cui negritudine era indiscutibile agli occhi della società bianca, Hall interroga una condizione ancora più ambigua: quella dell’individuo meticcio, percepito come “il ragazzo nero” dai suoi amici bianchi e come “il ragazzo schiarito” dalla sua famiglia nera. Questa oscillazione permanente tra due mondi che lo respingono ciascuno parzialmente fa di lui, per usare i suoi termini, un essere “palindromico”, leggibile in entrambe le direzioni, ma mai completamente integrato in nessuno. I suoi personaggi, spesso rappresentati in attività storicamente codificate come bianche, come l’equitazione, il surf, il tennis, sono figure che rifiutano di essere confinate negli “spazi neri stereotipati”. Hall dipinge uomini neri a riposo, surfisti neri sulle spiagge di Malibu, cavalieri neri in abbigliamento da equitazione, perché vuole complicare lo sguardo rivolto alla negritudine e distruggere il monolite.
Questo approccio risuona direttamente con le preoccupazioni di Du Bois riguardo a quelli che chiamava i “Talented Tenth”, il dieci per cento di uomini neri che, attraverso l’educazione e l’impegno civico, dovevano mostrare al mondo la piena capacità intellettuale e culturale del loro popolo. Hall ha inoltre realizzato un’opera intitolata The Talented Tenth (Mixed Doubles) (2025), in cui quattro uomini neri in tenuta da tennis si tengono davanti a un muro di mattoni, racchette in mano. Il titolo funziona su più livelli: fa riferimento al testo di Du Bois del 1903, ma anche al “doppio misto” nel tennis, e naturalmente all’identità mista (“mixed”) che Hall rivendica. I personaggi indossano abiti di ispirazione classica americana, maglioni da tennis, cardigan e pantaloni con pieghe, e sfoggiano acconciature e tratti a volte resi in negativo, questi “punti di rifiuto” caratteristici del suo linguaggio plastico. L’opera funziona simultaneamente come documento storico e sogno futurista, come memoria e proiezione.
La coscienza doppia diventa per Hall una coscienza multipla, stratificata. Non si tratta più solo di navigare tra due identità fisse, ma di riconoscere che l’identità stessa è un processo fluido, un divenire permanente. Come dice lui: “essere e diventare allo stesso tempo”. I suoi dipinti sono “ricevute di questo divenire”, tracce di un interrogarsi ossessivo: chi sono quando nessuno mi guarda? Chi sono quando tutti mi guardano? Come posso esistere al di fuori delle caselle che la società ha preparato per me? Queste domande Du Bois le aveva poste più di un secolo fa. Hall le riformula per il nostro tempo, in cui il meticciato si generalizza ma le strutture mentali ereditarie della segregazione persistono con una sorprendente tenacia.
Gordon Parks e l’eredità dello sguardo documentaristico
Per comprendere l’ambizione formale e politica di Hall, è indispensabile evocare la figura di Gordon Parks, pioniere del foto-giornalismo nero americano. Nato nel 1912 in Kansas, Parks fu il primo fotografo afroamericano assunto dalla rivista Life nel 1948. Per oltre due decenni documentò il movimento per i diritti civili, la povertà urbana, la vita delle gang di Harlem, e divenne anche il primo regista nero a dirigere un grande film hollywoodiano con The Learning Tree (1969), adattamento del suo romanzo semi-autobiografico. Parks dichiarava: “Ho capito che la macchina fotografica poteva essere un’arma contro la povertà, contro il razzismo, contro ogni sorta di ingiustizie sociali” [2].
Quando Hall arriva a New York con la sua macchina fotografica, si riferisce esplicitamente a Parks. Vuole fare del foto-giornalismo alla maniera di Parks, cioè con empatia, dignità e impegno. Per anni percorre la città per quindici-venticinque chilometri al giorno, fotografando volti, situazioni, momenti di vita. Questa formazione dell’occhio attraverso il camminare e l’osservare, che Parks praticava anch’egli trascorrendo settimane accanto ai suoi soggetti, struttura profondamente la sua sensibilità. Quando Hall inizia a dipingere, non si tratta di un abbandono della fotografia ma di una sua estensione attraverso altri mezzi. L’inquadratura, la composizione, l’attenzione rivolta all’abbigliamento come marcatore sociale e identitario, tutto ciò deriva dalla sua formazione fotografica.
Parks aveva come principio quello di saturare il suo sguardo del suo soggetto prima di scattare una singola immagine. Hall procede in modo simile: i suoi dipinti non sono mai illustrazioni affrettate, ma condensati di memorie, osservazioni e riflessioni accumulate. I personaggi che dipinge, musicisti jazz, aviatori di Tuskegee, operai in salopette e giocatori di football americano, hanno tutti questa qualità di essere allo stesso tempo archetipi e individui singolari. Si ritrova in Parks lo stesso approccio: i suoi soggetti, siano essi Red Jackson, giovane capo di una gang di Harlem, o Flavio da Silva, bambino asmatico delle favelas di Rio, sono sempre trattati con un’umanità che rifiuta il sensazionalismo.
La lezione di Parks è duplice. Da un lato, mostrare che l’arte documentaria può essere uno strumento di giustizia sociale. Dall’altro, dimostrare che un artista nero può padroneggiare tutti i medium, fotografia, letteratura, cinema e musica, senza bisogno della convalida delle istituzioni accademiche. Parks, come Hall, è un autodidatta. Questa autodidattia non è un handicap ma un punto di forza: permette di sfuggire agli stampi, alle convenzioni soffocanti, e di creare un linguaggio veramente personale.
Hall ha integrato da Parks il gusto per il vestiario come rivelatore del carattere. I suoi personaggi indossano abiti scelti con cura: pantaloni larghi utilitari degli anni 1940, cardigan classici, camicie bianche impeccabili e cravatte gialle. “Li vesto come mi vesto io stesso”, confida. Questa identificazione tra il pittore e i suoi soggetti non è mai narcisistica, ma deriva da una forma di onestà radicale: Hall dipinge ciò che conosce, ciò che ha vissuto, i mondi tra cui ha oscillato. Gli abiti diventano un’armatura identitaria, un mezzo per significare la propria appartenenza a una comunità elettiva piuttosto che assegnata.
Il legame tra Hall e Parks supera la semplice influenza stilistica. Si inscrive in una filiazione politica. Parks diceva che la macchina fotografica era un’arma. Hall, invece, afferma che la tela di cotone e il caffè sono materiali carichi di una violenza storica che bisogna ribaltare. Usando letteralmente i prodotti dello sfruttamento coloniale e schiavista per rappresentare figure nere in posture di dignità, di svago e contemplazione, compie un gesto di riappropriazione simbolica. Non è più la violenza a definire questi corpi, ma la grazia, lo stile e l’intelligenza. Come Parks rifiutava di ridurre i suoi soggetti alla loro miseria, Hall rifiuta di ridurre la nerozza alla sua sofferenza.
Parks ha anche aperto la strada diventando regista. Il suo film The Learning Tree, girato nella sua città natale Fort Scott, raccontava la sua infanzia nel Kansas segregato. Hall, invece, costruisce un’opera che funziona come un’autobiografia diffusa. Ogni quadro è un frammento di memoria ricomposto, un momento di introspezione materializzato. I titoli delle sue opere, Mama Tried (2025), Momma’s Baby, Daddy’s Maybe (titolo della sua mostra a Vienna nel 2025), Heavy Is The Head That Wears The Cotton (2025), testimoniano una volontà di raccontare storie personali che risuonano universalmente. Parks filmava la sua stessa infanzia; Hall dipinge la sua in frammenti, in allusioni, in criptografie visive.
L’eredità di Parks si manifesta anche nell’attenzione riservata ai momenti di calma. Parks fotografava bambini che giocano nelle strade di Harlem, famiglie riunite intorno a un tavolo, istanti di tenerezza rubati alla durezza del mondo. Hall dipinge surfisti, cavalieri e uomini a riposo nei diner. “Non tutto deve essere performance”, dice lui. Questa insistenza sulla non-performance, sull’essere piuttosto che sul fare, sulla presenza piuttosto che sulla lotta, costituisce una forma di resistenza estetica. In una società che riconosce i corpi neri solo nell’iperfisicità, sport, danza o violenza, mostrare uomini neri semplicemente mentre esistono, pensano, sognano, è un atto profondamente sovversivo.
Una pratica tra materialità e metafora
La tecnica di Hall è particolarmente interessante. Prepara fino a cento espressi per una sola tela, variando le tostature e i rapporti acqua-caffè per ottenere ventisei tonalità di marrone differenti. Questo caffè, ancora bollente, viene versato direttamente sulla tela di cotone grezzo. Hall deve lavorare velocemente, a volte in ginocchio o su impalcature, per controllare i flussi, le macchie e le sfumature. È un processo fisico, quasi coreografico, che trasforma lo studio in un “calderone di confronto”, secondo le sue parole. La pittura acrilica interviene poi per aggiungere tocchi di colore vivace, azzurro cielo, giallo limone e rosso profondo, che contrastano con i toni della terra. Ma ciò che colpisce è la quantità di bianco lasciata visibile: volti senza tratti, mani spettrali, ginocchia pallide, come se la tela resistesse a essere completamente coperta.
Questa resistenza del materiale è voluta. Hall dice di lasciare questi “momenti di vuoto” come “mosaici di identità”, spazi in cui lo spettatore può proiettare la propria storia. Ma questi bianchi non sono neutri: sono la bianchezza letterale del cotone, quella materia che ha strappato milioni di Africani alla loro terra per incatenarli nelle piantagioni. Lasciando il cotone visibile, Hall non lo cancella, non lo nasconde sotto strati di pittura: lo accusa. Ogni tela diventa così un documento giuridico tanto quanto estetico, un pezzo di prova nel processo interminabile della storia americana.
L’uso del caffè non è meno carico di simbolismo. Come il cotone, è una coltura d’esportazione legata allo sfruttamento. Ma è anche una bevanda di convivialità, di socialità, associata ai caffè viennesi dove si riunivano artisti e intellettuali all’inizio del XX secolo. Hall è consapevole di questa doppia iscrizione: violenza coloniale da una parte, spazio pubblico di dibattito dall’altra. Scegliendo specificamente chicchi di origine etiope (l’Etiopia essendo la culla del caffè), radica la sua pratica in una geografia africana. Il marrone del caffè diventa una metafora visiva della oscurità senza essere una imitazione servile. È una “melanina immersa nel cotone”, come la definisce con una poesia brutale.
Alcuni critici hanno accusato Hall di una forma di opportunismo, in particolare quando il suo dipinto The Black Birdwatchers Association (2020), che rappresenta un uomo nero con i binocoli, è diventato virale dopo l’incidente di Central Park in cui una donna bianca aveva chiamato la polizia contro un ornitologo nero. Hall riconosce di aver condiviso lui stesso l’immagine sui social network, ammettendo però: “Mi sono sentito colpevole di aver approfittato della situazione, ma ero anche scioccato. Vedere la mia opera circolare massicciamente, strumentalizzata ora dall’indifferenza mostrata, ora dall’entusiasmo improvviso per Black Lives Matter, mi ha profondamente turbato”. Questo momento di dubbio rivela un’integrità rara. Hall rifiuta di essere strumentalizzato, anche quando questa strumentalizzazione potrebbe servirgli la carriera. Vuole che le sue opere suscettano domande, non applausi prefabbricati.
L’urgenza di un’estetica dell’intermediazione
Ciò che rende indispensabile oggi l’opera di Chase Hall è proprio ciò che essa rifiuta di fare. Rifiuta di scegliere tra oscurità e luce, tra dolore e gioia, tra politica ed estetica, tra documentario e finzione. Assume pienamente di abitare lo spazio scomodo dell’ibridità, questo “intermedio” che la società americana ha sempre voluto cancellare. In un contesto dove l’essenzializzazione identitaria regna sovrana, dove ciascuno deve definirsi mediante categorie fisse, spesso imposte dall’esterno, Hall propone una via alternativa: accettare la molteplicità, abbracciare la contraddizione, fare della confusione una forza creativa piuttosto che una debolezza da nascondere.
Il suo lavoro dialoga con i morti e i vivi. Con Du Bois, che più di un secolo fa diagnosticava la doppia coscienza. Con Parks, che mostrava che un uomo nero poteva maneggiare tutti gli strumenti della rappresentazione. Con Henry Taylor, Kerry James Marshall e Charles White, i cui fantasmi benevoli infestano le sue composizioni. Ma Hall non è un epigono. Costruisce qualcosa di nuovo, una grammatica visiva che gli appartiene in proprio. Questa grammatica non è concettuale né sentimentale, né astratta né documentaria. Si regge solo sulla forza della sua onestà.
Guardare un dipinto di Hall significa confrontarsi con domande senza risposte. Chi sono quegli uomini a riposo, quegli eleganti cavalieri, quei surfisti sospesi nell’aria salata? Sono ricordi, proiezioni, fantasie, documenti? La tela non decide. Lascia aperto. E proprio questa apertura ne costituisce il valore. In un’epoca in cui tutto deve essere immediatamente decifrabile, classificabile, “instagrammabile”, Hall propone immagini che resistono al consumo rapido. I suoi dipinti richiedono tempo, attenzione, uno sforzo di sguardo. Ricompensano questo sforzo offrendo non certezze, ma possibilità.
Si può naturalmente rimproverargli una certa compiacenza formale, un gusto forse eccessivo per gli effetti materici. Si può anche interrogare il mercato che lo circonda: le sue tele si vendono tra i 20.000 e i 90.000 euro all’asta, entrano nelle collezioni del Whitney, del LACMA, del Brooklyn Museum. Tutto questo sa di establishment culturale, di gallerie eleganti, di collezionisti facoltosi. Ma di chi è la colpa? Hall non ha scelto questo sistema; tenta semplicemente di sopravvivere mantenendo intatta la sua voce. E bisogna constatare che ci riesce. Nonostante la macchina mediatica, nonostante le aspettative del mercato, nonostante le contraddittorie imposizioni (“sii autentico ma vendibile”, “sii politico ma non troppo”, “sii nero ma non solo”), Hall continua a porre le sue domande, a versare il suo caffè bollente sul cotone, a lasciare volti incompiuti.
La sua ultima esposizione a Vienna, intitolata Momma’s Baby, Daddy’s Maybe (Il bebè di mamma, forse di papà), affrontava frontalmente la questione della paternità nera, della filiazione spezzata, della trasmissione difficile. Il titolo deriva da una frase che suo padre gli aveva detto durante l’infanzia, frase che “lo ha spezzato” ma anche “costruito”. Diventato padre lui stesso nel 2024, Hall ora riflette su ciò che deve trasmettere a sua figlia Henrietta. Come raccontarle questa storia complicata? Come spiegarle che lei è il prodotto di un meticciato che non è sempre stata una scelta libera, che porta in sé strati di Storia contrastanti? Queste domande attraversano le nuove tele di Hall, che mostrano uomini neri in posa paterna, protettiva, attenta. Non è più solo l’identità che interroga, ma la trasmissione, la genealogia, la possibilità stessa di formare una famiglia nonostante tutto.
In fondo, ciò che salva l’opera di Hall dal nichilismo o dall’autocommiserazione vittimistica, è il suo ottimismo testardo. “Credo davvero nella vita”, dice semplicemente. Questa frase potrebbe sembrare ingenua. Non lo è. È una professione di fede pronunciata da qualcuno che ha visto il rovescio del decoro americano, la povertà, l’incarcerazione parentale e l’instabilità permanente, e che ha scelto comunque di dipingere immagini di grazia, bellezza, possibilità. Questa scelta è etica tanto quanto estetica. Dice: sì, la Storia è violenta, sì, le strutture di dominazione persistono, ma no, non siamo condannati a rigiocare indefinitamente le stesse tragedie. Ci sono vie di fuga, brecce, momenti in cui si può semplicemente essere, senza dover giustificare la propria esistenza.
I dipinti di Chase Hall non cambieranno il mondo. Non rovesceranno il capitalismo, non aboliranno il razzismo, non guariranno le ferite storiche. Ma fanno qualcosa di più modesto e più essenziale: creano uno spazio di respiro. Uno spazio dove la complessità può esistere senza essere immediatamente risolta, dove le contraddizioni possono coesistere senza annullarsi, dove un uomo può essere allo stesso tempo nero e bianco, americano e altro, pittore e pensatore, sopravvissuto e creatore. È già molto. È forse tutto ciò che possiamo chiedere all’arte oggi: che ci aiuti a respirare un po’ meglio, un po’ più profondamente, in un mondo che ci soffoca con le sue certezze.
- W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, A.C. McClurg & Co., Chicago, 1903
- Gordon Parks, citato in Voices in the Mirror: An Autobiography, Doubleday, New York, 1990