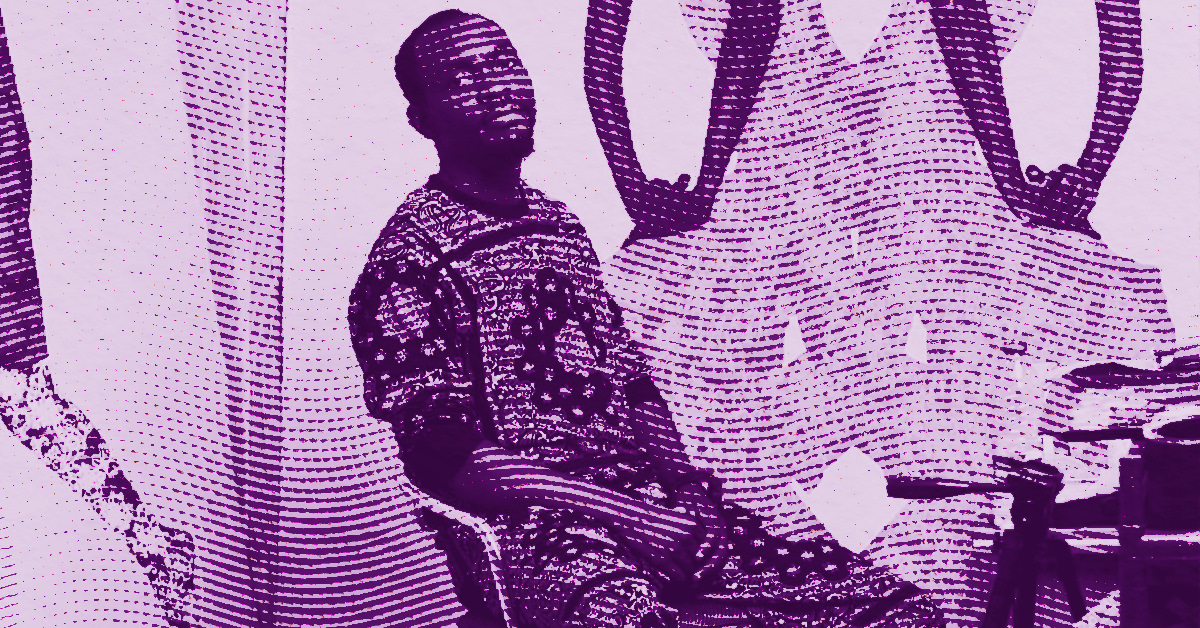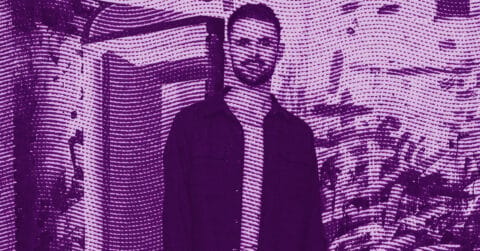Ascoltatemi bene, banda di snob: ecco un artista che, dai laboratori di Accra, reinventa il ritratto nero con un’audacia che dovrebbe farvi vergognare delle vostre certezze molli. Emmanuel Taku, nato nel 1986 in Ghana, disegna sulle sue tele monumentali una contro-storia della rappresentazione, un manifesto visivo che non vi chiede il permesso di esistere. Formatosi al Ghanatta College of Art and Design tra il 2005 e il 2009, quest’uomo ha prima insegnato disegno figurativo prima di comprendere che l’insegnamento non sarebbe bastato a contenere ciò che aveva da dire. Ciò che serviva era un linguaggio nuovo, una sintassi plastica capace di portare la venerazione dei corpi neri senza cadere nelle trappole convenzionali della commemorazione o del militante illustrativo.
La serie che ha catapultato Taku sulla scena internazionale si intitola “Temple of Blackness – It Takes Two”, prodotta durante la sua prima residenza a Noldor nel 2020. Il titolo stesso costituisce già un gesto teorico: laddove i musei occidentali hanno a lungo eretto templi alla bianchezza, Taku costruisce i suoi altari. Le sue figure, drappeggiate in tessuti con motivi floreali serigrafati, sono in pose che rimandano allo stesso tempo alle riviste di moda e alla statuaria classica. I loro occhi bianchi, completamente privi di pupille, li trasformano in semidei. Questo dettaglio formale, che l’artista rivendica come un riferimento al film Man of Steel dove Superman dimostra il suo potere attraverso questa metamorfosi oculare, supera di gran lunga l’omaggio cinematografico per toccare qualcosa di più profondo nelle cosmogonie ghanesi.
Il legame con il cinema d’autore non è casuale in Taku. È ascoltando il regista britanno-ghanese John Akomfrah raccontare la sua esperienza di bambino nero nei musei inglesi, che ha definito come “templi della bianchezza” [1], che Taku ha trovato il concetto fondatore del suo lavoro. Akomfrah, nato ad Accra nel 1957 prima di emigrare in Gran Bretagna, ha cofondato il Black Audio Film Collective nel 1982 e ha sviluppato durante la sua carriera un’opera filmica che interroga la memoria postcoloniale, lo spostamento diasporico e le strutture di potere inscritte nelle istituzioni culturali. Le sue installazioni video multi-schermo, come Vertigo Sea o Purple, intrecciano archivio storico e immagini contemporanee per creare saggi visivi sulla condizione nera e la crisi ambientale.
Per Taku, questa formulazione di Akomfrah, i musei come templi della bianchezza, ha agito come una rivelazione. Ha cristallizzato ciò che sentiva confusamente: che gli spazi culturali occidentali hanno storicamente funzionato come luoghi di consacrazione di una certa visione del mondo, di una certa estetica, di una certa umanità. Di fronte a questi templi, Taku erige i suoi. Ma contrariamente a quanto una lettura superficiale potrebbe suggerire, non si tratta di una semplice inversione binaria. I personaggi di Taku non sostituiscono un’egemonia con un’altra; propongono una modalità diversa di presenza al mondo. Le loro pose non sono trionfali nel senso militare del termine; affermano una sovranità tranquilla, una maestà che non ha bisogno di conquistare per affermarsi.
Questa dimensione architettonica del progetto di Taku merita attenzione. Parlando di “tempio”, l’artista non si limita a una metafora: evoca tutta una tradizione di pensiero sullo spazio sacro, sulla soglia tra il profano e il divino, sulla funzione dei luoghi in cui si opera una trasformazione dello sguardo. I templi, in tutte le culture, sono spazi di passaggio dove l’ordinario incontra lo straordinario. Facendo delle sue tele frammenti di questo tempio metaforico, Taku trasforma l’atto del guardare in atto di devozione. Lo spettatore non si trova più nella posizione del giudice estetico che valuta un’opera, ma in quella del pellegrino che penetra in uno spazio sacro. Questa inversione dei rapporti di potere nella relazione tra l’opera e il suo pubblico costituisce forse l’aspetto più sovversivo del lavoro di Taku.
Il cinema di Akomfrah e la pittura di Taku condividono anche un approccio stratificato all’immagine. In Akomfrah, gli schermi multipli e la sovrapposizione di temporalità creano una densità visiva che resiste a una lettura lineare. In Taku, questa stratificazione si realizza attraverso l’accumulo delle tecniche: acrilico, serigrafia, collage di giornali, tessuti. I tessuti floreali che vestono le sue figure non sono semplici ornamenti; portano una storia, quella della sorella sarta dell’artista, quella degli scambi commerciali tra India, Gran Bretagna e Africa, quella delle identità ibride che si formano in queste circolazioni. Il motivo cachemire che Taku predilige incarna questa complessità: originario della Persia e dell’India, popolarizzato in Scozia, adottato dai movimenti controculturali occidentali, porta in sé la mappa delle appropriazioni e delle riappropriazioni culturali.
Ma c’è qualcos’altro nell’opera di Taku, qualcosa di più intimo e più americano nella sua genealogia: l’influenza del pensiero positivo e del Nuovo Movimento del Pensiero come si è sviluppato negli anni 1920. L’artista cita volentieri The Secret of the Ages, opera pubblicata nel 1926 da Robert Collier [2], come quella che ha cambiato la sua vita. Questo libro, che ha venduto più di 300.000 copie in vita dell’autore, appartiene a quella tradizione letteraria dello sviluppo personale che promette l’accesso a un potere illimitato tramite il controllo della mente subconscia. Collier, nipote del fondatore della rivista Collier’s Weekly, sviluppa una psicologia dell’abbondanza basata sul desiderio, la fede e la visualizzazione.
Questo riferimento potrebbe stupire. Che cosa ci fa un’opera del genere, spesso criticata per il suo ottimismo ingenuo e per il suo individualismo sfrenato, nell’economia di un’opera che si presenta come un progetto di restituzione collettiva della dignità? La risposta si trova proprio nel modo in cui Taku rielabora le proposte di Collier. Dove The Secret of the Ages si rivolge a individui isolati alla ricerca del successo personale, Taku trasforma questi principi in un registro comunitario e decoloniale. La visualizzazione diventa creazione di immagini contro-egemoniche; la fede nelle proprie possibilità si trasforma in affermazione di una bellezza e di una potenza nere a lungo negate; il potere del subconscio diventa la capacità di reinventarsi al di là degli schemi imposti dalla storia coloniale.
Taku stesso lo spiega così: “Se puoi pensarci, allora puoi averlo” [3]. Questa frase, ispirata direttamente alla retorica di Collier, assume nell’artista una dimensione politica che non aveva nell’autore americano. Pensare i corpi neri come entità divine, visualizzarli in pose di potere, avvolgerli in tessuti sontuosi, significa operare quella trasformazione che Collier prometteva: far accadere con il pensiero ciò che la realtà ancora rifiuta. Il libro del 1926 e le tele del 2020 condividono questa convinzione che l’immaginazione non è semplice fantasia, ma forza creatrice capace di rimodellare la realtà.
C’è tuttavia una differenza: in Collier, la trasformazione resta individuale e materiale; in Taku, è collettiva e simbolica. Le figure dell’artista non sono mai sole. Vanno a coppie, a gruppi, formando configurazioni in cui i corpi si intrecciano e rispondono l’uno all’altro. Questa insistenza sulla dualità e sulla molteplicità trova la sua origine in un proverbio ghanese che Taku evoca regolarmente: una scopa isolata si rompe facilmente, ma legate insieme, le scope diventano infrangibili. La coesione, la sinergia, l’unità: questo cercano queste composizioni in cui le sagome antropomorfe si fondono tra loro, creando ibridi in cui non si sa più bene dove comincia un corpo e dove finisce l’altro.
Quell’estetica della fusione contrasta con l’iperindividualismo del Nuovo Movimento di Pensiero americano. Taku riprende lo strumento concettuale, la potenza del pensiero, la creazione tramite visualizzazione, ma lo reindirizza a fini comunitari. I suoi templi non celebrano eroi solitari ma collettivi, solidarietà, alleanze. In questo senso, compie una traduzione culturale: il successo personale diventa emancipazione collettiva. Questa operazione di detournement testimonia un’intelligenza strategica notevole. Piuttosto che respingere completamente gli strumenti concettuali prodotti dalla cultura dominante americana, Taku li piega ai suoi scopi personali.
Le tele monumentali dell’artista, alcune larghe fino a 3 metri, impongono fisicamente la loro presenza. Non si lasciano guardare distrattamente; richiedono di stare davanti a loro, di alzare gli occhi verso queste figure più grandi del naturale. Questa monumentalità partecipa alla strategia di ribaltamento: dove i corpi neri sono stati storicamente ridotti, oggettificati, frammentati, Taku li amplifica, li magnifica, li rende imprescindibili. La serigrafia che decora gli abiti aggiunge una dimensione ornamentale che rifiuta la sobrietà austera spesso associata all’arte “seria”. Questi motivi floreali esuberanti, questi colori saturi, questo rifiuto dell’ascetismo formale: tutto ciò costituisce un’affermazione gioiosa, quasi insolente, del diritto alla bellezza e alla sontuosità.
I collezionisti non si sono sbagliati. Nel 2022, con quasi un milione di euro di opere vendute all’asta, Taku è diventato il terzo artista ghanese della sua generazione più performante sul mercato mondiale. Un quadro realizzato durante la residenza Noldor ha stabilito il suo record personale a 250.000 euro nel marzo 2022. Questi numeri, che si potrebbero giudicare volgari da menzionare in un’analisi critica, dicono però qualcosa di importante: il mercato, nonostante tutti i suoi difetti, riconosce qui la potenza di un lavoro che non fa concessioni. Taku non ha edulcorato il suo messaggio per piacere; al contrario, ha radicalizzato le sue posizioni, ed è proprio questa inflessibilità che seduce.
Perché in fondo, ciò che propone Taku è un’uscita dal regime di rappresentazione compassionevole che ha a lungo caratterizzato il modo in cui l’arte occidentale affrontava i soggetti neri. Le sue figure non suscitano né pietà, né solidarietà buonista, né indignazione morale. Non hanno bisogno della vostra empatia. Si bastano a sé stesse, sovrane e inaccessibili nella loro splendida supernaturalità. Questa inaccessibilità, segnalata dagli occhi bianchi ciechi che in realtà non vi guardano, costituisce un rifiuto del patto scopico abituale. Potete contemplarle, ma loro non vi contemplano in cambio. Esistono in una sfera parallela, quella del tempio che abitano, e voi rimanete all’esterno, spettatori ammessi ma non invitati.
Questa posizione estetica coincide infine con quella di Akomfrah nelle sue installazioni: creare spazi contemplativi in cui lo spettatore occidentale si trova decentrato, in cui il suo sguardo non organizza più il mondo. Nelle sale oscure dove si sviluppano i video di Akomfrah, come davanti ai quadri di Taku, si fa l’esperienza di un’alterità che non si riduce, che non si spiega, che semplicemente si afferma. È questa dignità ontologica, questa presenza piena e intera, che i due artisti, con mezzi diversi, si impegnano a rendere visibile. Il cinema di Akomfrah e la pittura di Taku formano così una costellazione diasporica ghanese, un dialogo oltre l’Atlantico tra due generazioni di artisti che rifiutano di occupare i posti che erano stati loro assegnati.
Non si tratta qui di cedere alla tentazione agiografica che insidia ogni critica d’arte non appena affronta questioni di rappresentazione e giustizia. L’opera di Taku ha i suoi limiti, le sue zone d’ombra. Si potrebbe interrogare la permanenza della figura umana mentre tanti artisti contemporanei esplorano l’astrazione o l’installazione. Si potrebbe anche mettere in questione la relativa uniformità formale di una produzione che, serie dopo serie, ripropone gli stessi orientamenti compositivi. Ma queste riserve pesano poco di fronte all’evidenza di una necessità: queste immagini mancavano, e ora esistono. Occupano le gallerie di Bruxelles, New York e Hong Kong. Si scambiano nelle sale d’asta. Entrano nelle collezioni museali. Producono ciò che Taku aveva visualizzato, seguendo così i precetti di Collier: trasformano il possibile in reale.
Il tempio che costruisce Emmanuel Taku non è un monumento statico; è un cantiere permanente, un’architettura sempre in divenire. Ogni nuova tela aggiunge una pietra all’edificio, amplia lo spazio sacro, accoglie nuove figure nel pantheon. E così facendo, trasforma impercettibilmente il paesaggio dell’arte contemporanea, sposta le linee, rende un po’ più difficile il mantenimento delle vecchie gerarchie. È questa pazienza strategica, questa fiducia nel potere accumulativo delle immagini, che fa di Taku non un iconoclasta fracassone, ma un costruttore ostinato. Non distrugge i templi della bianchezza; erige pazientemente, metodicamente, i suoi, sapendo che la loro semplice esistenza basta a mettere in discussione l’egemonia dei primi. Questa è forse la lezione più preziosa che si possa trarre da quest’opera: che la contro-storia si scrive meno nella confrontazione frontale che nella costruzione paziente di alternative visive, nell’ostinazione a far esistere ciò che non aveva diritto di cittadinanza. E che questa esistenza, una volta stabilita, diventa irreversibile.
- John Akomfrah, riferimento menzionato da Emmanuel Taku durante la sua intervista con Gideon Appah per la Noldor Residency, 2020, riguardo ai musei come “temples of whiteness”.
- Robert Collier, The Secret of the Ages, Robert Collier Publications, 1926.
- Emmanuel Taku, intervista con Fashion Week Daily, 2021.