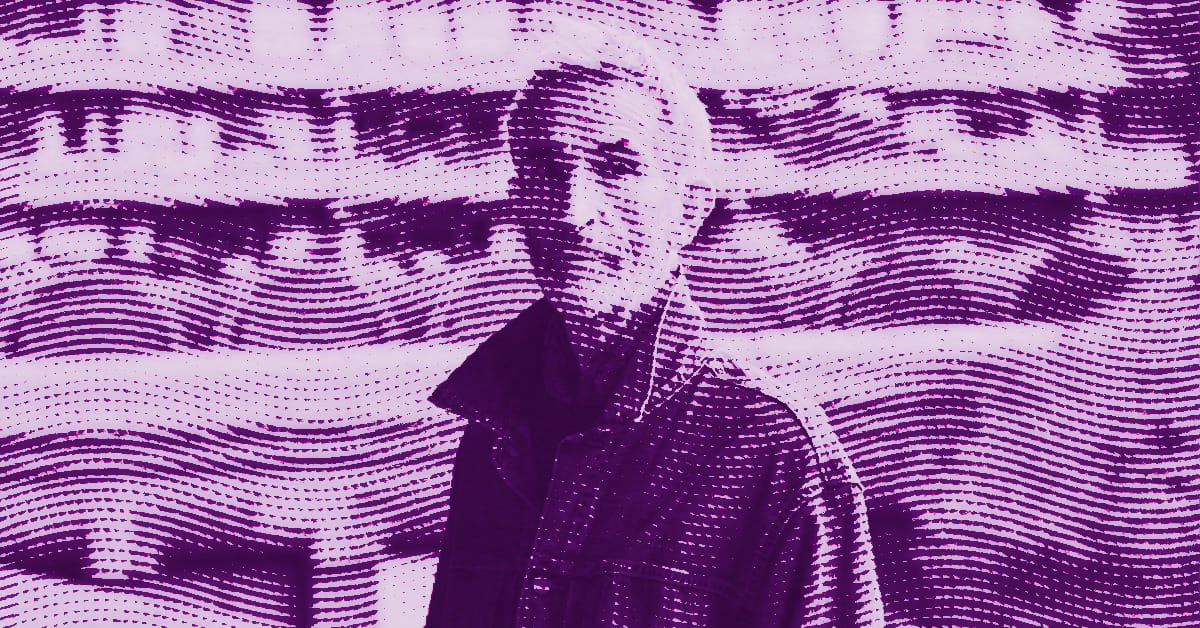Ascoltatemi bene, banda di snob: Francis Alÿs non ci chiede di comprendere le sue opere, ci chiede di percorrerle. In un mondo saturato da immagini spettacolari e gesti artistici fragorosi, questo belga stabilitosi a Città del Messico dal 1986 sviluppa una pratica artistica fondata sulla semplicità del gesto e la complessità delle sue risonanze. Né pittore nel senso tradizionale, né performer nel senso teatrale, Alÿs occupa un territorio artistico singolare dove l’atto di camminare diventa uno strumento di resistenza poetica alle logiche urbane contemporanee.
L’opera di Francis Alÿs si sviluppa nello spazio interstiziale tra arte e antropologia, tra il gesto minimale e il carico politico massimo. Dalle sue prime passeggiate nelle strade di Città del Messico all’inizio degli anni Novanta, l’artista sviluppa una pratica che interroga i modi di occupazione dello spazio urbano. Le sue azioni, documentate dal video e prolungate dalla pittura, costituiscono un corpus coerente di indagini sulle tensioni geopolitiche contemporanee.
Nato ad Anversa nel 1959, Francis Alÿs arriva in Messico come architetto, incaricato di partecipare ai progetti di ricostruzione post-terremoto del 1985. Questa formazione da architetto rimarrà fondamentale nel suo approccio artistico: non dimenticherà mai che lo spazio urbano è prima di tutto una costruzione sociale, un insieme di vincoli e possibilità che determinano le modalità di esistenza collettiva. Il suo passaggio all’arte, intorno al 1989, costituisce meno una rottura che una radicalizzazione di questa preoccupazione per lo spazio come rivelatore dei rapporti di forza sociali.
La camminata come scrittura dello spazio
L’opera di Francis Alÿs trova la sua risonanza teorica più profonda nel pensiero di Michel de Certeau, particolarmente nella sua analisi della camminata come pratica dello spazio sviluppata in “L’invenzione del quotidiano”. Per Certeau, l’atto di camminare costituisce una forma di enunciazione spaziale che sfugge ai sistemi di sorveglianza e controllo urbani [1]. Questa prospettiva trasforma radicalmente la nostra comprensione delle passeggiate di Alÿs, che non sono più un semplice esercizio estetico ma una vera politica dello spazio.
In “The Collector” (1991-1992), Alÿs trascina un cane magnetico di peluche per le strade di Città del Messico, raccogliendo i detriti metallici che coprono l’asfalto. Questa azione apparentemente ludica rivela, attraverso l’accumulazione progressiva dei residui ferrosi, lo stato di degrado dell’infrastruttura urbana messicana. Il gesto minimale di Alÿs trasforma la camminata in uno strumento di indagine sociale, rivelando ciò che le politiche ufficiali di pianificazione urbana si sforzano di nascondere.
Questa dimensione critica della camminata trova la sua espressione più compiuta in “Paradox of Praxis I (Sometimes Making Something Leads to Nothing)” (1997), dove Alÿs spinge un blocco di ghiaccio per le strade di Città del Messico per nove ore, fino al suo completo scioglimento. L’azione interroga frontalmente le nozioni di produttività ed efficacia che strutturano l’economia neoliberale. Investendo un considerevole sforzo per un risultato nullo, Alÿs attualizza le riflessioni di Michel de Certeau sulle tattiche di resistenza quotidiana: si tratta di perturbare, attraverso la stessa logica dell’assurdo, i ritmi e le finalità imposte dall’organizzazione razionale dello spazio urbano.
Le passeggiate di Alÿs si inseriscono in questa tradizione teorica che, da Baudelaire a Certeau passando per i Situazionisti, concepisce la camminata urbana come pratica critica. Ma Alÿs radicalizza questo approccio trasformando i suoi spostamenti in eventi artistici documentati. I suoi percorsi non sono più semplicemente l’esperienza soggettiva del flâneur, ma la costruzione di oggetti artistici che interrogano le modalità contemporanee di circolazione e controllo nello spazio metropolitano.
Questo approccio trova una particolare risonanza nel contesto messicano, dove la rapida urbanizzazione e l’informalità di molti quartieri creano spazi di attrito tra la pianificazione ufficiale e gli usi popolari. Alÿs sviluppa una poetica di questi interstizi, rivelando come gli abitanti inventino quotidianamente modalità di occupazione che sfuggono alle logiche dominanti di pianificazione.
L’efficacia critica delle azioni di Alÿs risiede nella loro capacità di rivelare, attraverso il minimo sovvertimento di gesti quotidiani, le strutture invisibili che organizzano l’esperienza urbana. Camminando in modo diverso, fermandosi dove normalmente non ci si ferma, raccogliendo ciò che solitamente si trascura, l’artista attualizza la funzione rivelatrice dell’arte che Certeau attribuiva alle pratiche quotidiane di resistenza.
La documentazione video di queste azioni non è un semplice registrazione, ma parte della loro efficacia critica. Trasformando l’effimero in archivio, rendendo riproducibile l’irriproducibile, Alÿs interroga anche le modalità contemporanee di circolazione e validazione dell’arte. I suoi video funzionano come virus, propagandosi nei circuiti artistici internazionali e contaminando altri contesti urbani con i loro interrogativi.
Questa dimensione politica della camminata trova il suo prolungamento nei progetti geopolitici di Alÿs, in particolare “The Green Line” (2004), dove l’artista segue a piedi, versando della vernice verde, la linea di armistizio del 1948 a Gerusalemme. L’azione rivela l’arbitrarietà di ogni confine, aggiornando al contempo, attraverso la semplice presenza fisica del camminatore, divisioni che gli accordi diplomatici cercano di naturalizzare.
Questa politica della deambulazione trova le sue fondamenta teoriche nell’analisi proposta da Certeau degli “arti del fare” quotidiani. Per il teorico francese, queste pratiche ordinarie costituiscono forme di resistenza micropolitica che, senza rovesciare le strutture dominanti, le perturbano abbastanza per creare spazi di libertà. Alÿs radicalizza questa analisi trasformando queste perturbazioni in eventi artistici che rivelano la dimensione politica di gesti apparentemente anodini.
La condivisione del sensibile e la redistribuzione dei ruoli
La pratica artistica di Francis Alÿs trova una seconda fondamentale illuminazione teorica nelle riflessioni di Jacques Rancière sulla “condivisione del sensibile” e sulla funzione politica dell’arte. Per Rancière, l’arte politica non consiste nel veicolare messaggi politici ma nel ridistribuire le condivisioni tra il visibile e l’invisibile, tra il dicibile e l’indicibile, che strutturano l’ordine sociale [2]. Questa prospettiva permette di cogliere la dimensione propriamente politica degli interventi di Alÿs, che non rientrano mai nella propaganda ma nella redistribuzione delle percezioni.
In “When Faith Moves Mountains” (2002), Alÿs organizza lo spostamento collettivo di una duna di sabbia a Lima, in Perù, mobilitando cinquecento volontari muniti di pale. L’azione, evidentemente futile dal punto di vista dell’efficacia geologica, ridistribuisce radicalmente i ruoli sociali abituali. Gli abitanti delle baraccopoli di Ventanilla, solitamente invisibili nello spazio pubblico peruviano, diventano i protagonisti di un evento artistico internazionale. Questa redistribuzione dei ruoli costituisce il vero obiettivo politico dell’azione: rende visibile una popolazione abitualmente relegata ai margini della rappresentazione.
Questa dimensione politica non dipende dal contenuto esplicito dell’opera ma dalla sua stessa forma. Organizzando un’azione collettiva attorno a un obiettivo apparentemente assurdo, Alÿs sospende temporaneamente le logiche di redditività ed efficacia che governano normalmente l’organizzazione sociale. Questa sospensione apre uno spazio di possibilità dove possono emergere altre modalità di convivenza, anche se temporaneamente.
Rancière insiste sul fatto che l’arte politica non consiste nel rappresentare il politico ma nel riconfigurare le condizioni stesse della rappresentazione. Le azioni di Alÿs operano esattamente secondo questa logica: esse non denunciano esplicitamente le disuguaglianze sociali ma creano situazioni in cui queste disuguaglianze diventano percepibili in modo diverso. In “The Green Line”, l’artista non prende posizione nel conflitto israelo-palestinese ma rende sensibile l’arbitrarietà di ogni confine così come la sua realtà vincolante.
Questo approccio trova una singolare risonanza nel contesto latino-americano, dove i rapporti tra arte e politica sono stati a lungo pensati sulla base dell’impegno esplicito. Alÿs sviluppa un’alternativa a questa tradizione esplorando le modalità indirette attraverso cui l’arte può intervenire nello spazio pubblico. Le sue azioni non militano per una causa precisa ma creano situazioni in cui gli spettatori sono portati a riconsiderare le loro percezioni abituali dello spazio sociale.
La serie “Children’s Games” (1999-presente) illustra in modo esemplare questa politica della redistribuzione percettiva. Documentando giochi di bambini in contesti geopolitici tesi (Afghanistan, Iraq, Ucraina), Alÿs non cade mai nel pietismo ma rivela la persistenza di forme di vita che sfuggono alle logiche della guerra. Questa persistenza non costituisce un messaggio di speranza ma un dato antropologico fondamentale: nonostante i contesti più drammatici, l’invenzione ludica continua a strutturare l’esperienza infantile.
Questa dimensione antropologica delle opere di Alÿs si collega alle preoccupazioni di Rancière riguardo alla capacità dell’arte di rivelare forme di vita ignorate dai discorsi dominanti. Documentando questi giochi infantili, l’artista non produce una testimonianza sulla guerra ma rivela la coesistenza di temporalità diverse all’interno di uno stesso spazio sociale. Questa coesistenza sconvolge le rappresentazioni univoche della violenza geopolitica rivelando la complessità irriducibile del reale.
L’efficacia politica di queste documentazioni risiede nella loro capacità di sospendere le nostre abituali categorie percettive. Di fronte alle immagini di bambini che giocano tra le macerie di Mosul, lo spettatore non può più mantenere una rappresentazione uniforme della guerra. Questa sospensione delle certezze percettive costituisce, secondo Rancière, la funzione politica specifica dell’arte: non convincere ma disturbare, non insegnare ma disorientare.
I dipinti di Alÿs partecipano della stessa logica di redistribuzione percettiva. Le sue piccole tele, spesso realizzate di notte, funzionano come condensati poetici delle sue azioni. Non costituiscono illustrazioni delle sue performance ma oggetti autonomi che esplorano altre modalità di rapporto con lo spazio e il tempo. Per la loro scala ridotta e la loro fattura delicata, contrastano con l’ampiezza geografica delle azioni che accompagnano, creando un gioco di scale che turba le nostre abitudini percettive.
Questo approccio multimediale permette ad Alÿs di esplorare diverse modalità della resistenza estetica. Le sue azioni interrogano gli usi dello spazio pubblico, i suoi dipinti rivelano temporalità alternative, i suoi video mettono in discussione le modalità di circolazione dell’arte contemporanea. Questa moltiplicazione dei supporti non è dovuta a opportunismo ma a una strategia coerente di intervento in diversi regimi di sensibilità.
La forza critica dell’opera di Alÿs risiede infine nella sua capacità di evitare l’insidia del didatticismo senza cadere nell’estetismo. I suoi interventi non forniscono messaggi espliciti ma creano situazioni in cui l’ordine abituale delle percezioni si trova momentaneamente sospeso. Questa sospensione apre possibilità di riconfigurazioni percettive che costituiscono il vero impegno politico del suo lavoro.
L’arte come laboratorio di alternative
L’opera di Francis Alÿs interroga fondamentalmente le modalità contemporanee di resistenza alla razionalizzazione neoliberale dell’esistenza. Di fronte alla crescente mercificazione dello spazio urbano e all’accelerazione dei ritmi sociali, l’artista sviluppa una pratica della lentezza e della apparente inefficacia che costituisce una forma di resistenza passiva alle logiche dominanti di produttività.
Questa resistenza non nasce dalla nostalgia ma dall’invenzione di modalità alternative di esistenza collettiva. Le azioni di Alÿs funzionano come laboratori dove si sperimentano altri rapporti con il tempo, lo spazio e l’efficacia. In “Rehearsal I” (1999-2001), una Volkswagen rossa tenta instancabilmente di salire una collina a Tijuana, fallendo sistematicamente e ricominciando ogni volta. Questa ripetizione ossessiva interroga le mitologie del progresso che strutturano l’immaginario della modernizzazione latinoamericana.
L’efficacia critica di questo pezzo risiede nella sua capacità di rivelare l’aspetto sisifeo di numerose imprese di sviluppo economico. Trasformando il fallimento in spettacolo estetico, Alÿs non cade nel cinismo ma rivela la dimensione tragica e comica di alcune aspirazioni collettive. Questa rivelazione non sfocia in una lezione morale ma in una sospensione delle certezze che permette di considerare diversamente le sfide dello sviluppo.
I progetti recenti di Alÿs in Afghanistan e in Iraq rivelano un’evoluzione significativa della sua pratica verso contesti sempre più drammatici. Questa evoluzione non nasce dalla ricerca del sensazionale ma da una radicalizzazione delle sue domande sulle modalità di convivenza in spazi di conflitto. In “Reel-Unreel” (2011), due bambini afgani corrono nelle strade di Kabul svolgendo e riavvolgendo alternativamente una pellicola cinematografica. Questa azione semplice rivela la persistenza di forme di gioco e invenzione in un contesto di guerra permanente.
Queste documentazioni sollevano questioni complesse sulle modalità etiche di rappresentazione della guerra. Alÿs evita sistematicamente il pietismo concentrandosi sulle forme di resistenza quotidiana sviluppate dalle popolazioni civili. Questo approccio riprende le riflessioni di Susan Sontag sulla fotografia di guerra: invece di documentare la sofferenza, si tratta di rivelare le forme di vita che persistono nonostante la violenza.
L’originalità di Alÿs sta nella sua capacità di evitare le insidie del voyeurismo umanitario senza cadere nell’estetizzazione della violenza. Le sue documentazioni rivelano come l’arte possa intervenire in contesti di conflitto senza pretendere di risolverli. Questa modestia costituisce paradossalmente la forza politica del suo lavoro: rinunciando alle grandi dichiarazioni, apre spazi di riflessione più sfumati sulle questioni geopolitiche contemporanee.
La dimensione internazionale della carriera di Alÿs solleva anche questioni sulle modalità di circolazione dell’arte critica nei circuiti istituzionali. Le sue opere, esposte nelle più prestigiose istituzioni artistiche occidentali, interrogano i rapporti tra resistenza estetica e integrazione commerciale. Questa tensione non invalida la portata critica del suo lavoro, ma rivela le contraddizioni strutturali dell’arte contemporanea.
L’efficacia delle opere di Alÿs consiste infine nella loro capacità di creare situazioni di riflessione piuttosto che oggetti di consumo culturale. Le sue azioni funzionano come catalizzatori che rivelano le tensioni latenti dello spazio sociale senza pretendere di risolverle. Questa funzione rivelatrice rappresenta l’apporto specifico dell’arte ai dibattiti politici contemporanei: non fornire soluzioni, ma complessificare i termini dei problemi.
L’opera di Francis Alÿs ci invita così a ripensare le modalità contemporanee della critica sociale. Di fronte alle forme spettacolari della contestazione politica, sviluppa un’estetica della discrezione che rivela la dimensione politica di gesti apparentemente insignificanti. Questa rivelazione non si traduce in programmi d’azione, ma in una sensibilizzazione alle questioni micropolitiche che strutturano l’esistenza quotidiana.
La forza di questo approccio risiede nella sua capacità di evitare la trappola del moralismo senza cadere nell’indifferenza estetica. Le interazioni di Alÿs creano situazioni in cui gli spettatori sono portati a riconsiderare i loro rapporti abituali con lo spazio, il tempo e l’efficacia. Questa riconsiderazione rappresenta un preliminare necessario a ogni vera trasformazione politica: rivela la contingenza delle nostre evidenze percettive e apre possibilità di organizzazione alternativa dell’esperienza collettiva.
L’arte di Francis Alÿs ci insegna infine che la resistenza politica può seguire vie indirette, che l’efficacia critica non si misura necessariamente dall’entità delle trasformazioni prodotte, ma dalla qualità delle domande suscitate. In un mondo in cui le forme spettacolari della protesta sembrano spesso recuperate dalle logiche che intendono combattere, Alÿs esplora le potenzialità politiche della modestia, della lentezza e della apparente inefficacia. Questa esplorazione rappresenta un contributo prezioso alle riflessioni contemporanee sulle modalità della critica sociale e sulle funzioni politiche dell’arte.
- Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano. 1. Arti del fare, Parigi, Gallimard, 1990.
- Jacques Rancière, La condivisione del sensibile. Estetica e politica, Parigi, La Fabrique, 2000.