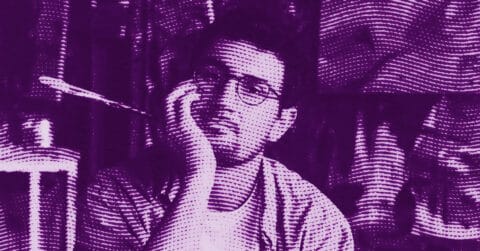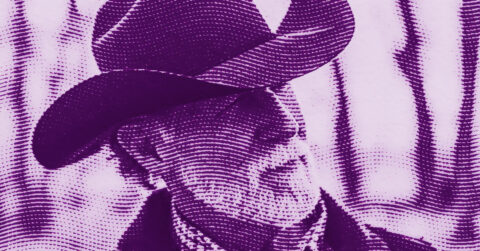Ascoltatemi bene, banda di snob. Coloro che credono ancora che l’arte contemporanea sia solo una successione di concetti vuoti e installazioni incomprensibili farebbero bene a rendersi conto di ciò che Kehinde Wiley sta realizzando da ormai diversi decenni. Questo ritrattista americano, nato nel 1977 a Los Angeles, ha creato niente meno che una rivoluzione pittorica, anzi, una trasformazione completa del nostro rapporto con il ritratto classico e con la rappresentazione del corpo nero nell’arte occidentale.
Le sue tele monumentali impongono la loro presenza con un’autorità innegabile. Non si possono semplicemente osservare; esse ci osservano a loro volta, ci interrogano e sconvolgono il nostro rapporto con la storia dell’arte. Wiley proietta giovani uomini neri ordinari in pose gloriose ispirate ai grandi maestri europei, creando così una tensione visiva immediata che mette in discussione le nostre aspettative.
Wiley ha il dono particolare di creare ritratti che sembrano vibrare di un’energia inesauribile. I suoi soggetti, spesso reclutati direttamente per le strade di New York, Dakar o Londra, emanano una presenza sovrana, incorniciati da motivi floreali meticolosi e sfondi colorati che evocano talvolta arazzi barocchi, talvolta carte da parati vittoriane. Eppure, nulla nel suo lavoro è una semplice appropriazione. Ciò che avviene qui è una vera trasmutazione alchemica del linguaggio pittorico europeo.
Collocando corpi neri contemporanei in pose che evocano direttamente la tradizione del ritratto europeo, Wiley instaura un dialogo complesso con l’architettura. Non sto parlando di edifici, ma della struttura stessa che sottende la nostra percezione culturale. Perché la pittura classica europea è, nella sua essenza, un’architettura del potere e del privilegio. Come scriveva l’architetto francese Jean Nouvel: “L’architettura è, prima di tutto, un’arte dell’articolazione, l’articolazione dei corpi, dello spazio, della memoria e del senso” [1]. Ed è proprio questo che fa Wiley: riartecola la relazione tra corpo, spazio, memoria e senso.
Prendiamo ad esempio la sua rilettura di Officier de hussards di Théodore Géricault. Nella versione originale, vediamo un ufficiale bianco su un cavallo imbizzarrito, simbolo del potere militare francese post-rivoluzionario. Nella versione di Wiley, è un giovane uomo nero in jeans e Timberlands a occupare questa posizione dominante. Non è una semplice sostituzione; è una ricomposizione architettonica completa dell’immagine, una riorganizzazione dei codici visivi che pone la domanda: chi ha il diritto di occupare lo spazio simbolico del potere?
Questa questione architettonica è tanto più rilevante quando si considera che gli edifici del potere, musei, palazzi governativi, istituzioni finanziarie, sono proprio i luoghi in cui l’arte classica europea è stata consacrata come canone. Introdurre i suoi ritratti in queste stesse istituzioni, Wiley non si limita a decorare le pareti; riconfigura l’architettura simbolica del luogo. Come ha osservato il critico di architettura Rem Koolhaas: “L’architettura è un miscuglio pericoloso di potere e impotenza” [2]. Le opere di Wiley sfruttano precisamente questa tensione.
L’altro aspetto interessante del lavoro di Wiley è il suo rapporto con la psicoanalisi, particolarmente nel trattamento della mascolinità nera. I suoi ritratti mettono in discussione non solo gli stereotipi razziali, ma anche le costruzioni psichiche della virilità e del desiderio. Incorniciando i suoi soggetti maschili in pose tradizionalmente associate alla nobiltà europea, espone e sovverte ciò che Franz Fanon chiamava “lo schema corporeo storico-razziale” imposto ai corpi neri.
Nelle sue serie come “The World Stage”, Wiley interroga il modo in cui i corpi neri sono al contempo ipervisibili e invisibili nella cultura occidentale. Questa dualità richiama il concetto lacaniano dello sguardo (il “gaze”), quella coscienza opprimente di essere visti, oggettivati, che determina il nostro modo stesso di vederci. Come ha scritto Jacques Lacan: “Io vedo solo da un punto, ma nella mia esistenza sono guardato da tutte le parti” [3]. I soggetti di Wiley ci guardano direttamente, ribaltando il “gaze” tradizionale dell’arte occidentale in cui i corpi neri erano relegati ai margini, rappresentati come servitori o come curiosità esotiche.
Questa inversione psicoanalitica è particolarmente evidente nella sua serie “Down”, dove corpi neri sono rappresentati sdraiati o in posizioni di apparente vulnerabilità. Queste opere fanno riferimento alle rappresentazioni classiche di martiri cristiani, ma evocano anche inevitabilmente le immagini contemporanee di violenza contro i corpi neri. Giustapponendo queste risonanze traumatiche con la bellezza formale della pittura classica, Wiley crea ciò che la psicoanalista Julia Kristeva chiamerebbe uno spazio di “abiezione”, un luogo in cui i confini tra bellezza e orrore, potere e vulnerabilità si dissolvono.
Il ritratto di Barack Obama di Wiley per la National Portrait Gallery rappresenta forse l’apice di questo lavoro psicoanalitico. Raffigura il primo presidente nero americano seduto semplicemente su una sedia, circondato da vegetazione simbolica (fiori rappresentanti Hawaii, Chicago e Kenya), evitando le trappole abituali del ritratto presidenziale. Niente scrivania, niente bandiera, nessun segno ostentato di potere. Obama è presentato come un uomo pensieroso, umano, complesso, una rappresentazione che sfida le aspettative inconsce che potremmo avere di un ritratto presidenziale, e più in generale, di un uomo nero al potere.
Ciò che distingue veramente Wiley è che crea opere che sono sia politicamente incisive sia esteticamente sfarzose. Non c’è alcuna contraddizione tra il suo impegno critico e il suo evidente amore per la bellezza formale della pittura. Le sue tele sono banchetti visivi; la ricchezza dei colori, la precisione tecnica, la complessità dei motivi floreali, tutto testimonia un pittore che comprende e rispetta profondamente la tradizione che sovverte.
Ed è proprio questo che rende il suo lavoro così potente. Perché, a differenza di molti artisti contemporanei che rigettano completamente l’eredità pittorica occidentale, Wiley l’abbraccia per trasformarla meglio. Non si tratta di demolire il museo, ma di reinventarlo, aprirlo, renderlo vivo per pubblici che si sentivano esclusi. Come ha dichiarato lui stesso: “Sappiamo che i musei e le istituzioni, così come l’arte, devono rispondere al mondo in cui si evolvono per rimanere attuali, sopravvivere e corrispondere alla società che li circonda… È un’opportunità entusiasmante prendere un linguaggio immobile e antico e infondere in esso la vitalità del presente” [4].
Facendo ciò, Wiley mette in evidenza l’assurdità del nostro sistema artistico che troppo spesso continua a considerare l’arte occidentale come universale e l’arte non-occidentale come specifica. Le sue opere ci obbligano a riconoscere che ogni tradizione artistica, inclusa quella europea, è culturalmente situata, storicamente contingente. Il genio di Wiley è farci vedere questa contingenza non come una limitazione, ma come un invito a reimmaginare cosa l’arte possa essere e fare.
Certamente, si potrebbe rimproverare a Wiley una certa ridondanza formale in alcune delle sue serie, o mettere in discussione la produzione semi-industriale delle sue opere nel suo atelier di Pechino. Si potrebbe anche chiedersi se il suo successo commerciale e istituzionale rischi di smussare il taglio critico del suo lavoro. Ma sarebbe perdere l’essenziale: Wiley è riuscito a fare della pittura figurativa contemporanea un terreno di esplorazione vitale per questioni di rappresentazione, identità e potere che sono al cuore della nostra epoca.
Nel 2018, la rivista Time lo ha incluso nella sua lista delle “100 persone più influenti”, un riconoscimento che va ben oltre il mondo dell’arte. Ciò che è notevole è che Wiley ha raggiunto questa influenza non abbandonando la pittura per forme d’arte più “contemporanee”, ma dimostrando che la pittura stessa può essere un medium radicale, capace di trasformare il nostro modo di vedere e di essere visti.
Le ultime opere di Wiley, come la sua serie “An Archaeology of Silence” esposta alla Biennale di Venezia nel 2022, mostrano un artista che continua a evolversi, a correre rischi, ad approfondire la sua visione. Queste opere più cupe, che meditano sulla vulnerabilità dei corpi neri di fronte alla violenza dello Stato, dimostrano che Wiley è molto più di un pittore decorativo. È un artista capace di cogliere le tensioni e i traumi della nostra epoca immaginando al contempo possibilità di bellezza, dignità e trascendenza.
Ciò che rende Kehinde Wiley un artista così importante oggi è la sua capacità di costruire ponti, tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, tra critica sociale e piacere estetico. In un mondo artistico spesso diviso tra formalisti conservatori e concettualisti radicali, Wiley ci ricorda che la grande pittura è sempre stata entrambe le cose insieme: formalmente esigente e intellettualmente audace, sensuale e cerebrale, personale e politica.
Quindi la prossima volta che incrocerete una delle sue tele monumentali in un museo o alla galleria Templon, a Parigi o New York, prendetevi il tempo di guardare davvero. Non limitatevi ad ammirare la virtuosità tecnica o a decodificare il messaggio politico. Lasciatevi coinvolgere in questo gioco complesso di sguardo, desiderio, potere e bellezza che Wiley orchestra con tanta maestria. Perché è proprio in quello spazio tra il godimento visivo e la coscienza critica che la sua arte opera la sua magia più profonda.
- Nouvel, Jean. “Architettura e libertà: Interviste con Jean Baudrillard”, Éditions Galilée, Parigi, 2003.
- Koolhaas, Rem. “S,M,L,XL”, The Monacelli Press, New York, 1995.
- Lacan, Jacques. “Il Seminario, Libro XI: I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi”, Éditions du Seuil, Parigi, 1973.
- Kadish Morris. “Kehinde Wiley”, intervista su The Guardian, 21 novembre 2021.