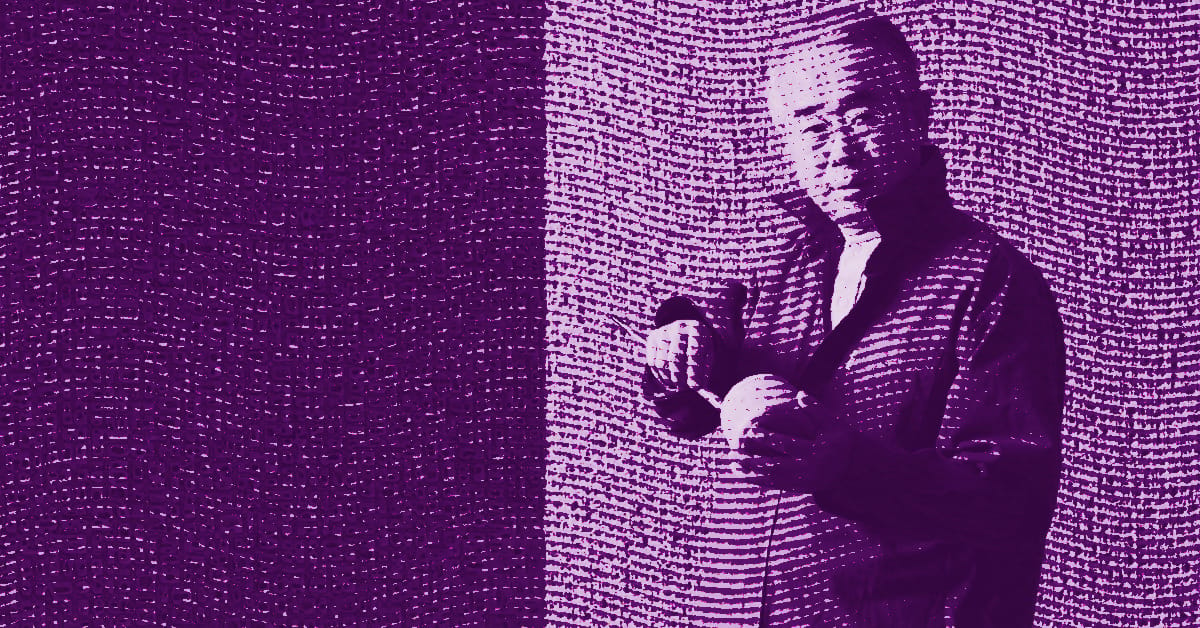Ascoltatemi bene, banda di snob: mentre vi smarrite nei vostri laboriosi dibattiti sul futuro dell’arte contemporanea, Kim Tae-Ho ha trascorso quasi quarantacinque anni della sua vita a costruire, strato dopo strato, uno dei corpus più autenticamente rivoluzionari dell’arte coreana contemporanea. Quest’uomo, nato a Busan nel 1948 e deceduto prematuramente nel 2022, non ha solo partecipato al movimento Dansaekhwa, lo ha ripensato, superato, spinto verso territori inesplorati in cui la pittura diventa scultura, dove il tempo si materializza in stratificazioni colorate, dove ogni gesto ripetuto risuona come una meditazione sull’esistenza umana.
L’opera di Kim Tae-Ho, in particolare la sua serie emblematica Rythme Intérieur (Internal Rhythm), rimane una delle realizzazioni più compiute di quella che si potrebbe definire un “architettura pittorica”. Questa espressione non è casuale: rivela una profonda parentela tra l’approccio dell’artista coreano e l’approccio spaziale dell’architetto giapponese Tadao Ando, maestro indiscusso della manipolazione dello spazio e della luce nell’architettura contemporanea.
La geometria sacra: Quando l’arte incontra l’architettura
L’analogia tra Kim Tae-Ho e Tadao Ando [1] va oltre la semplice coincidenza geografica o temporale. Questi due creatori condividono un’ossessione comune per la trasformazione di materiali grezzi, il cemento per Ando e la pittura acrilica per Kim, in spazi di contemplazione e rivelazione. Nell’architetto giapponese, i muri in cemento non sono mai semplici pareti ma interfacce che permettono un dialogo sottile tra interno ed esterno, tra luce e ombra. Le sue creazioni, dalla chiesa della Luce al tempio dell’Acqua, mostrano una padronanza dello spazio che trasforma ogni percorso architettonico in esperienza spirituale.
Questa stessa filosofia spaziale anima l’opera di Kim Tae-Ho. Le sue griglie meticolosamente costruite non sono semplici motivi decorativi ma vere e proprie architetture in miniatura. Ogni cella della griglia funziona come una camera autonoma, uno spazio intimo dove i colori si dispiegano secondo la propria logica interna. Il processo creativo dell’artista coreano evoca direttamente i metodi costruttivi di Ando: accumulo paziente di materiali, attenzione ossessiva ai dettagli tecnici, ricerca di una perfezione formale che non sacrifica mai l’emozione alla fredda geometria.
L’influenza dell’architettura su Kim Tae-Ho non si limita a una semplice analogia metaforica. L’artista stesso evocava la sua fascinazione per le strutture urbane, in particolare le serrande metalliche dei negozi che hanno ispirato la sua prima serie Forme negli anni ’70. Questi elementi architettonici banali diventano, sotto il suo pennello, esplorazioni sofisticate della tensione tra rivelazione e occultamento, tra superficie e profondità. Questo approccio anticipa notevolmente la filosofia di Ando, per il quale l’architettura deve creare “zone di individualità all’interno della società”, spazi di ritiro e meditazione in un mondo sempre più standardizzato.
La tecnica di sovrapposizione sviluppata da Kim Tae-Ho nella sua serie Rythme Intérieur può essere compresa come una trasposizione pittorica dei metodi costruttivi di Ando. L’architetto giapponese utilizza il calcestruzzo non come materiale di riempimento ma come sostanza poetica, capace di catturare e riflettere la luce con una sensibilità quasi-tessile. Kim Tae-Ho procede in modo simile con i suoi strati di acrilico: ogni strato diventa un elemento strutturale dell’opera, contribuendo a edificare uno spazio virtuale dove lo sguardo può perdersi e ritrovarsi. La luce, per entrambi i creatori, non è un semplice agente illuminante ma un materiale scultoreo a tutti gli effetti.
Questa parentela si esprime anche nella loro concezione del tempo. Ando concepisce i suoi edifici come organismi viventi che evolvono secondo le ore e le stagioni, rivelando aspetti inattesi a seconda dell’angolo della luce o della posizione dell’osservatore. Kim Tae-Ho ottiene un effetto simile con l’accumulo temporale dei suoi gesti: ogni strato di pittura porta in sé la traccia del tempo trascorso, creando una stratigrafia emozionale che lo spettatore scopre progressivamente. Le “piccole camere” delle sue griglie evocano gli spazi contemplativi di Ando, quei luoghi di raccoglimento dove l’architettura si fa discreta per rivelare meglio l’essenziale.
L’opera di Kim Tae-Ho dialoga così con una tradizione architettonica che supera i confini nazionali per interrogare i fondamenti dell’esperienza spaziale. Come Ando trasforma volumi geometrici semplici in cattedrali di luce, l’artista coreano trasforma gesti ripetitivi in architetture intime, creando spazi di meditazione che esistono solo nell’incontro tra l’opera e lo sguardo che la contempla.
La fenomenologia della materia: L’eredità di Heidegger
La dimensione filosofica dell’opera di Kim Tae-Ho non può essere pienamente compresa senza riferimento al pensiero di Martin Heidegger [2], particolarmente alla sua meditazione sull’essere, il tempo e l’arte. Il filosofo tedesco, nel suo saggio “L’Origine dell’opera d’arte”, sviluppa una concezione rivoluzionaria della creazione artistica come “messa in opera della verità”, processo attraverso il quale l’essere si rivela nella sua dimensione più autentica. Questo approccio illumina in modo straordinario il percorso di Kim Tae-Ho, la cui ogni opera costituisce una vera archeologia della presenza.
Heidegger distingue tra l’oggetto manufatto (Zeug) e l’opera d’arte (Kunstwerk), sottolineando che quest’ultima non si limita a rappresentare il mondo ma lo fa manifestare nella sua verità. I dipinti di Kim Tae-Ho illustrano perfettamente questa distinzione: lontani dall’essere semplici oggetti decorativi, funzionano come rivelatori di temporalità, rendendo visibile il processo stesso della loro elaborazione. Ogni raschiatura al coltello rivela gli strati sepolti, attualizzando ciò che Heidegger chiama l’Unverborgenheit, la rivelazione di ciò che era nascosto.
Il concetto di Heidegger di Dasein (esserci) trova nell’arte di Kim Tae-Ho una traduzione particolarmente eloquente. Il Dasein indica quel modo specificamente umano di esistere nel tempo, di essere già proiettato verso il futuro pur portando in sé il peso del passato. Le opere della serie Rythme Intérieur materializzano questa temporalità esistenziale: ogni strato di pittura corrisponde a un momento vissuto, a un “estasi temporale” per riprendere il vocabolario di Heidegger, e la loro sovrapposizione crea una stratigrafia dell’essere che rende sensibile la dimensione storica di ogni esistenza.
L’approccio tecnico di Kim Tae-Ho, questa alternanza minuziosa tra accumulo e sottrazione, evoca direttamente la dialettica di Heidegger tra l’Anwesenheit (presenza) e l’Abwesenheit (assenza). Ogni gesto di raschiatura fa scomparire una parte della materia pittorica rivelando al contempo le stratificazioni sottostanti, attualizzando questo paradosso fondamentale secondo il quale ogni rivelazione implica simultaneamente un occultamento. Questa dinamica supera la semplice tecnica per diventare una meditazione sulle condizioni di possibilità di ogni apparizione.
La ripetitività dei gesti dell’artista coreano può essere intesa come una forma di Wiederholung di Heidegger, non una semplice ripetizione meccanica ma una “ripresa autentica” che consente a ogni momento di rivelare la sua unicità. Kim Tae-Ho non riproduce mai esattamente lo stesso gesto: ogni strato, ogni raschiatura porta con sé la propria necessità, la propria verità. Questo approccio trasforma l’atto creativo in un esercizio di autenticità esistenziale, permettendo all’artista di sfuggire alla dittatura del “si” (das Man) per accedere a una creatività veramente personale.
L’opera di Kim Tae-Ho rivela inoltre una comprensione intuitiva di ciò che Heidegger chiama la “quadratura” (Geviert), questa articolazione originaria tra la terra e il cielo, i mortali e i divini. I suoi dipinti non sono mai semplici oggetti estetici ma condensati cosmologici dove si articolano diverse dimensioni dell’esperienza. La materialità della pittura evoca la terra, la sua luminosità variabile a seconda dell’illuminazione richiama il cielo, il tempo della loro elaborazione testimonia la condizione mortale dell’artista, e la loro capacità di suscitare meraviglia apre a una dimensione che supera l’umano troppo umano.
Questa dimensione cosmologica si esprime particolarmente nella metafora dell'”alveare” spesso associata alle opere di Kim Tae-Ho. Ogni cella della griglia funziona come un microcosmo autonomo, ma il complesso forma un organismo complesso dove circolano forze invisibili. Questa struttura evoca la concezione di Heidegger del mondo come totalità articolata, dove ogni ente trova il suo posto in una rete di significati che lo supera pur costituendolo.
L’influenza di Heidegger su Kim Tae-Ho non deve essere intesa come un’applicazione meccanica di un sistema filosofico ma come una convergenza spontanea verso questioni fondamentali. L’arte coreana del ventesimo secolo, particolarmente il movimento Dansaekhwa, testimonia una sensibilità filosofica che si unisce naturalmente alle preoccupazioni di Heidegger: interrogazione sull’essenza dell’arte, meditazione sul tempo e la finitudine, ricerca di un’autenticità creativa in un mondo dominato dalla tecnica. L’opera di Kim Tae-Ho si inscrive in questa confluenza, realizzando tramite i mezzi della pittura ciò che Heidegger tentava di formulare concettualmente: un pensiero dell’essere che sia anche una poetica dell’esistenza.
L’eredità del gesto: Tra tradizione e innovazione
Kim Tae-Ho ha sviluppato la sua singolarità artistica in un contesto culturale dove la tradizione del gesto ripetitivo occupa un posto centrale. L’arte coreana, profondamente impregnata delle filosofie buddista e confuciana, ha sempre privilegiato l’esercizio della pazienza e la ricerca della perfezione tramite la ripetizione. Questo approccio trova nelle opere della serie Rythme Intérieur una concretizzazione straordinariamente moderna, dove la gestualità tradizionale incontra le preoccupazioni estetiche contemporanee.
La tecnica sviluppata dall’artista, sovrapposizione di più di venti strati di pittura acrilica seguiti dal loro scrupoloso grattaggio, rivela una padronanza tecnica che evoca i grandi artigiani della ceramica coreana. Questa affinità non è casuale: testimonia una continuità culturale che attraversa i secoli, adattando le saggezze ancestrali alle sfide estetiche contemporanee. Kim Tae-Ho non rompe con la tradizione coreana; la reinventa, la proietta verso territori inesplorati dove può dialogare alla pari con l’arte internazionale.
Il processo creativo di Kim Tae-Ho trasforma ogni opera in una testimonianza temporale in cui si sovrappongono i momenti della sua creazione. Questa stratificazione rivela una concezione del tempo che si allontana radicalmente dalla temporalità lineare occidentale per aderire a un approccio ciclico più conforme alle filosofie asiatiche. Ogni grattatura rivela strati precedenti senza però cancellarli completamente: essi rimangono presenti, influenzando per la loro semplice esistenza gli strati superiori. Questa coesistenza di temporalità trasforma ogni dipinto in un condensato di storia, in un archivio sensibile dove il passato continua ad agire sul presente.
La dimensione meditativa del lavoro di Kim Tae-Ho non può essere sottovalutata. L’artista stesso menzionava questa qualità contemplativa del suo processo creativo, descrivendo come la ripetizione dei gesti lo conduceva verso uno stato di concentrazione che superava la semplice applicazione tecnica per diventare esercizio spirituale. Questo approccio inscrive la sua opera nella linea delle pratiche meditative asiatiche, dove la ripetizione ritmica permette di accedere a stati di coscienza modificati. Ogni pennellata diventa così un gesto di meditazione, ogni grattatura una forma di preghiera laica.
Questa dimensione spirituale non deriva da un misticismo di facciata ma da un approccio rigorosamente materialista alla creazione. Kim Tae-Ho non cerca di evadere il mondo sensibile ma di rivelarne le potenzialità nascoste. La sua tecnica di sovrapposizione e rivelazione progressiva richiama i metodi dell’alchimia tradizionale, dove la trasformazione della materia comporta una trasformazione parallela dell’operatore. L’artista non rimane esterno alla sua opera ma partecipa alla sua metamorfosi, accettando di essere modificato dal processo stesso che mette in moto.
Verso un’estetica della rivelazione
L’opera di Kim Tae-Ho si impone oggi come uno dei risultati più significativi dell’arte coreana contemporanea, non nonostante la sua apparente modestia ma proprio grazie a essa. In un mondo artistico spesso dominato dall’enfasi e dalla spettacolare esagerazione, i suoi dipinti propongono una via alternativa: quella dell’approfondimento paziente, dell’esplorazione minuziosa delle potenzialità infinite contenute in mezzi limitati. Questo approccio rivela una saggezza estetica che supera ampiamente le sfide proprie dell’arte contemporanea per interrogare le condizioni stesse dell’esperienza umana.
La serie Rythme Intérieur costituisce così molto più di un semplice corpus di opere: propone una vera filosofia della creazione che riconcilia l’eredità culturale coreana con le esigenze della modernità artistica. Kim Tae-Ho è riuscito a evitare la doppia insidia del tradizionalismo sterile e dell’occidentalizzazione superficiale per inventare un linguaggio plastico autenticamente personale, radicato nella sua cultura d’origine pur restando aperto alle influenze esterne. Questa sintesi notevole lo rende uno dei rappresentanti più compiuti di quella che potremmo chiamare una “mondializzazione creatrice”, in cui lo scambio interculturale arricchisce le particolarità locali invece di livellarle.
L’influenza di Kim Tae-Ho sulle generazioni di artisti che gli sono succedute testimonia la pertinenza del suo approccio. La sua concezione dell’arte come esercizio di pazienza e rivelazione progressiva continua a ispirare creatori preoccupati di ritrovare una temporalità creativa autentica in un mondo dominato dall’accelerazione perpetua. Questa influenza non si limita ai confini coreani, ma irradia internazionalmente, contribuendo a ridefinire i termini del dialogo tra tradizione e modernità nell’arte contemporanea.
La prematura scomparsa di Kim Tae-Ho nel 2022 priva il mondo artistico di una voce singolare proprio nel momento in cui le sue ricerche iniziavano a ottenere il riconoscimento internazionale che meritavano da tempo. Le sue ultime opere testimoniavano una crescente libertà nell’uso del colore e una complessificazione delle sue strutture compositive che lasciavano intravedere sviluppi promettenti. Questa interruzione brusca trasforma il suo corpus in un testamento estetico, in un insieme chiuso che invita a una meditazione sul compimento e l’incompiuto nell’arte.
L’opera di Kim Tae-Ho ci ricorda che la vera arte non si misura dalla sua capacità di seduzione immediata, ma dalla sua potenza di rivelazione progressiva. I suoi dipinti richiedono tempo, pazienza, un’attenzione sostenuta che si oppone radicalmente ai modi di consumo artistico contemporanei. Questa esigenza costituisce anche la loro forza: propongono un’esperienza estetica che resiste all’usura del tempo e che si rivela sempre più ricca man mano che la si approfondisce. In questo, Kim Tae-Ho si unisce alla schiera dei grandi creatori che hanno saputo trasformare le apparenti limitazioni dei loro mezzi in fonti di invenzione inesauribile.
L’arte di Kim Tae-Ho ci insegna infine che la vera innovazione artistica non procede da una rottura spettacolare, ma dall’approfondimento paziente delle possibilità offerte da mezzi semplici. Le sue griglie meticolose, le sue sovrapposizioni colorate, i suoi grattamenti rivelatori costituiscono altrettanti inviti a riscoprire la ricchezza infinita contenuta nei gesti più elementari della creazione. Questa lezione di umiltà creativa risuona con un’acuità particolare nella nostra epoca di sovrapproduzione artistica, ricordando che l’autenticità non si decreta, ma si conquista attraverso l’esercizio ripetuto di una esigenza senza compromessi.
Kim Tae-Ho ci ha lasciato un’opera che funziona come uno specchio delle nostre stesse possibilità creative. I suoi dipinti non si limitano a offrirci uno spettacolo estetico: ci invitano a scoprire in noi stessi questa pazienza, questa attenzione, questa capacità di approfondimento che costituiscono i veri fondamenti di ogni creazione autentica. Questa dimensione pedagogica, nel senso più nobile del termine, assicura alla sua opera una perennità che supera di gran lunga le fluttuazioni del mercato dell’arte o le mode critiche passeggere. Kim Tae-Ho entra così in quella rara categoria di creatori la cui influenza continua a crescere dopo la loro scomparsa, arricchendo la nostra comprensione di cosa può e deve essere l’arte in un mondo in continua trasformazione.
- Tadao Ando, vincitore del premio Pritzker per l’architettura nel 1995, architetto giapponese contemporaneo riconosciuto per le sue costruzioni in cemento e per la sua padronanza della luce naturale nello spazio architettonico.
- Martin Heidegger, L’origine dell’opera d’arte (1935-36), in Sentieri interrotti, edizioni Gallimard, 1962.