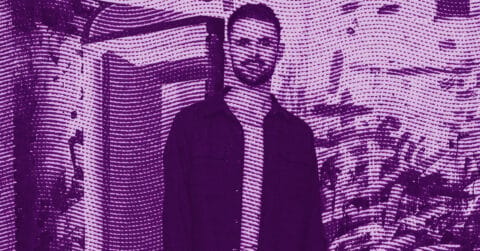Ascoltatemi bene, banda di snob: mentre vi crogiolate nelle ultime stravaganze del mercato dell’arte occidentale, un uomo a Tamale, nel nord del Ghana, tesse una poetica della rovina che mette in discussione le vostre comode certezze. Ibrahim Mahama non gioca il gioco che vi aspettate da lui. Rifiuta i codici, devia le aspettative e costruisce, letteralmente, un’opera che interroga le basi stesse delle nostre strutture materiali e narrative. Questo artista nato nel 1987 non si limita a creare installazioni monumentali: riscrive le regole dell’architettura e della letteratura in un linguaggio fatto di sacchi di juta usati, vagoni abbandonati e letti ospedalieri fatiscenti.
Parliamo di architettura, dato che Mahama se ne occupa con un’audacia che farebbe arrossire molti costruttori contemporanei. Dove altri si accontentano di drappeggiare tessuti sulle facciate per abbellire, lui investe le strutture con una violenza concettuale che scuote le nostre concezioni spaziali. I suoi interventi architettonici non sono semplici gesti estetici. Incarnano una critica materiale del colonialismo e delle sue infrastrutture difettose. Quando avvolge il Barbican di Londra con Purple Hibiscus, questa imponente installazione di duemila metri quadrati di tessuto, non decora un edificio: lo strangola simbolicamente sotto il peso della storia postcoloniale [1]. Il gesto è brutale, quasi soffocante, come le eredità coloniali che denuncia.
Ma l’architettura in Mahama non è mai solo metaforica. Diventa il terreno di un’esperienza sociale concreta. Con il Savannah Centre for Contemporary Art che fonda nel 2019, poi Red Clay Studio e Nkrumah Volini, erige spazi che sfidano le convenzioni occidentali dell’istituzione culturale. Questi edifici, costruiti con mattoni di argilla locale cotti al sole, non cercano di imitare i musei climatizzati d’Europa. Mahama afferma che l’arte deve pensare in relazione alle condizioni locali, che la qualità non è inferiore semplicemente perché si adatta ai vincoli energetici e climatici del Ghana. Questo approccio architettonico pragmatico ma radicale ribalta la gerarchia implicita tra Nord e Sud. Le sue strutture non sono sostituti poveri di istituzioni occidentali: sono modelli alternativi che mettono in discussione la pertinenza stessa degli standard che consideriamo universali.
L’architettura in Mahama diventa anche un atto di memoria materializzata. Quando trasforma vagoni di treni coloniali in aule scolastiche e studi di registrazione, pratica una forma di chirurgia temporale. Queste infrastrutture, un tempo strumenti dell’estrazione coloniale britannica, si trasformano in spazi pedagogici per le comunità locali. La pelle strappata dai pavimenti dei vagoni, segnata dalla decomposizione e dal tempo, rivela ferite che diventano la materia stessa dell’opera. Come dice lui stesso, questa pelle sembra una pelle scorticata, che porta tutte le cicatrici di un sistema sanitario in crisi. Questa trasformazione architettonica non sublima nulla: espone, dissseca, rivela i traumi inscritti nei materiali stessi.
Ma è forse nel suo approccio alla letteratura che Mahama dispiega la sua sottigliezza più temibile. Non perché scriva, anche se produce saggi e riflessioni teoriche, ma perché concepisce la sua opera come un testo tessuto, una narrazione materiale che dialoga con le grandi voci della letteratura africana. Quando intitola una mostra Purple Hibiscus dal romanzo di Chimamanda Ngozi Adichie [1], non fa semplicemente un cenno culturale. Stabilisce un parallelo strutturale tra la scrittura di Adichie e la sua propria pratica. Il romanzo di Adichie, pubblicato nel 2003, racconta la storia di Kambili, un’adolescente che vive sotto l’autorità tirannica di un padre al contempo filantropo pubblico e violento domestico. L’ibisco porpora del giardino della zia Ifeoma simboleggia la libertà e la ribellione contro l’oppressione familiare e religiosa.
Mahama comprende che questo fiore raro porta esattamente lo stesso carico simbolico dei suoi materiali recuperati. I suoi sacchi di iuta, marchiati “Product of Ghana”, hanno viaggiato dall’Asia sudorientale per trasportare il cacao ghanese, la maggiore risorsa di esportazione del paese all’inizio del ventesimo secolo. Questi sacchi, come l’ibisco porpora di Adichie, incarnano una forma di resistenza sottile, una bellezza che sfida le strutture oppressive. Portano le tracce del lavoro forzato, della migrazione imposta, dello sfruttamento sistematico. Assemblandoli con collaboratori locali per creare patchwork monumentali, Mahama pratica una forma di scrittura collettiva, una narrazione cucita filo dopo filo.
Proprio come Adichie impiega l’igbo nel suo inglese per creare una lingua ibrida che rifiuta l’egemonia coloniale, Mahama mescola materiali coloniali (i sacchi importati, le rotaie britanniche) con tecniche locali (la tessitura manuale, la costruzione in argilla). Questa strategia narrativa materiale crea un vocabolario formale che parla più lingue simultaneamente. L’opera diventa polifonica, rifiutando la purezza stilistica che il mondo dell’arte occidentale vorrebbe imporgli. Cita anche Chinua Achebe intitolando alcune opere secondo i titoli del romanziere nigeriano, creando così una rete intertestuale che ancora il suo lavoro nell’eredità letteraria africana [2].
Questa dimensione letteraria non si limita ai titoli presi in prestito. Mahama pratica quella che si potrebbe chiamare una “lettura materiale” della storia. Le sue opere funzionano come racconti non lineari in cui ogni oggetto porta uno strato narrativo. I banchi di scuola recuperati, le scatole dei lucida scarpe, le reti per affumicare il pesce: tutti questi elementi costituiscono un vocabolario narrativo che racconta storie di lavoro, migrazione, sopravvivenza economica. Mahama dichiara di interessarsi al momento in cui la relazione tra materiale e società si rompe, rivelando così le falle del sistema. Questa attenzione alla rottura narrativa richiama le tecniche moderniste di frammentazione, ma applicate al dominio scultoreo e architettonico.
La nozione di “fantasmi” attraversa anche la sua opera come un leitmotiv letterario. Durante la pandemia di COVID-19, scrive che “le promesse del presente possono cominciare con i fantasmi del futuro e del passato” [3]. Questi fantasmi sono l’incarnazione delle promesse non mantenute, dei futuri abortiti, delle infrastrutture abbandonate. Essi infestano le sue installazioni come i personaggi fantasmatici popolano i romanzi gotici. Ma a differenza del gotico europeo, i fantasmi di Mahama sono politici, economici, profondamente radicati nelle realtà postcoloniali. Non terrorizzano: testimoniano.
Il suo metodo di lavoro evoca i processi di scrittura collaborativa e di editing. Acquista materiali dai venditori di rottami, li smonta, li studia, li riassembla. È un processo di riscrittura materiale, di correzione, di annotazione. Mahama parla di “viaggio temporale” per descrivere il suo approccio: un modo di navigare tra passato, presente e futuro riattivando oggetti abbandonati. Questa concezione temporale fluida richiama le strutture narrative complesse della letteratura postmoderna, dove il tempo lineare si dissolve a favore di strati temporali intrecciati.
Ciò che rende Mahama veramente sovversivo è il suo rifiuto categorico dell’estetica della consolazione. Non offre belle metafore rassicuranti sulla resilienza africana. Non sublimà la povertà in esotismo per collezionisti annoiati. Al contrario, le sue opere conservano la rudezza, lo sporco, le tracce di usura. I sacchi di juta rimangono bucati, macchiati, a volte puzzolenti. Questa estetica del rifiuto consapevole rifiuta il vocabolario della bellezza occidentale creando al contempo composizioni visivamente schiaccianti. È un paradosso potente: opere monumentali fatte di detriti, che comandano rispetto pur rigettando la grandezza convenzionale.
La dimensione pedagogica del suo lavoro merita anch’essa attenzione. Mahama investe i proventi delle sue vendite nella costruzione di spazi comunitari. Trasforma silos di grano abbandonati, aerei dismessi, carceri in spazi di apprendimento. Questa pratica architettonica e sociale costituisce forse la sua opera più radicale: creare le condizioni materiali affinché le future generazioni di artisti possano emergere. Afferma che quando si costruiscono comunità artistiche, “queste comunità sono piene di amore”. Una dichiarazione che potrebbe sembrare ingenua, ma che acquista tutto il suo peso osservando l’impatto concreto delle sue infrastrutture nel nord del Ghana.
Perché ecco il cuore della questione: Mahama rifiuta la separazione tra pratica artistica e responsabilità sociale. Rifiuta l’idea che l’arte contemporanea africana debba semplicemente produrre oggetti per i circuiti internazionali. I suoi spazi funzionano come contro-istituzioni, laboratori dove l’intelligenza locale prevale sui modelli importati. Collabora con falegnami, calzolai, guardiani, tatuatori, persone le cui competenze sono generalmente invisibili nel mondo dell’arte. Questo approccio collaborativo produce opere che portano i segni di molteplici mani, di molteplici voci.
I critici occidentali amano parlare di “decolonizzazione” come se fosse una postura intellettuale elegante. Mahama, invece, decolonizza concretamente: recuperando le infrastrutture coloniali per riutilizzarle, creando economie alternative intorno al recupero materiale, formando giovani nel nord del Ghana piuttosto che a Londra o New York. La sua decolonizzazione non è retorica: è materiale, architettonica, economica. Marie-Ann Yemsi, curatrice al Palais de Tokyo di Parigi, afferma proprio che egli “gioca un ruolo immenso nella decolonizzazione dell’immaginazione” [4].
Sarebbe allettante concludere con una nota ottimista, celebrare Mahama come un eroe dell’arte contemporanea, un modello per tutti. Ma sarebbe tradire lo spirito stesso della sua opera. Perché ciò che Mahama ci offre non è un racconto di trionfo, ma una profonda meditazione sul fallimento come materiale fertile. Egli stesso dice di essere interessato al fallimento come materiale ma anche come potenziale, all’idea che il fallimento apra un portale per rileggere il mondo in cui viviamo. Questa filosofia del fallimento produttivo rovescia le nostre aspettative eroiche. Suggerisce che sia proprio nel guasto, nella rottura, nell’abbandono che si trovano le opportunità di reinvenzione.
I suoi vagoni arrugginiti, i suoi letti d’ospedale usurati, i suoi sacchi bucati: tutto ciò testimonia sistemi che hanno fallito. Il sistema ferroviario coloniale che non ha mai servito le popolazioni locali. Il sistema sanitario sottofinanziato. L’economia mondiale che tratta le materie prime africane come semplici commodity. Mahama non nasconde questi fallimenti. Li espone, li studia, li trasforma in strumenti di riflessione. Le sue opere diventano autopsie del capitalismo postcoloniale, rivelando i meccanismi dello sfruttamento nella tessitura stessa dei materiali.
Ciò che distingue Mahama dagli artisti che si limitano a denunciare è che costruisce contemporaneamente delle alternative. I suoi centri d’arte non sono monumenti alla sua stessa gloria, ma infrastrutture vive, in costante mutamento. Ospitano mostre della durata di sei mesi per permettere ai villaggi più remoti di effettuare il viaggio. Archiviano il lavoro di artisti ghanesi delle generazioni precedenti le cui opere stavano scomparendo. Formano bambini alla programmazione, alla robotica, alle tecnologie digitali mantenendo al contempo un radicamento nelle pratiche materiali.
In un mondo dell’arte contemporanea ossessionato dalla novità, Mahama adotta una temporalità diversa. Le sue opere guardano indietro per immaginare avanti. Attingono alle rovine del passato i materiali del futuro. Questo atteggiamento nei confronti del tempo non è né nostalgico né futurista: è archeologico e visionario simultaneamente. Scava nelle stratificazioni della storia coloniale e postcoloniale per estrarne potenzialità inesplorate.
Allora sì, Ibrahim Mahama merita attenzione. Non perché rappresenti l’arte africana contemporanea (come se esistesse una categoria monolitica simile), ma perché propone una rifondazione radicale di ciò che l’arte può fare nel mondo. Ci ricorda che i materiali portano storie, che gli edifici sono testi, che i gesti artistici possono costruire comunità reali. La sua opera è una dimostrazione eclatante che l’arte non ha bisogno di scegliere tra rigore intellettuale e impatto sociale, tra bellezza formale e impegno politico. Può essere tutto ciò insieme, nella sua complessità ruvida e magnifica. E se questo vi disturba, tanto meglio: era proprio l’intenzione.
- Chimamanda Ngozi Adichie, Purple Hibiscus, Algonquin Books, 2003.
- Chinua Achebe, scrittore nigeriano (1930-2013), autore fra l’altro di Things Fall Apart (1958), considerato un testo fondante della letteratura africana postcoloniale moderna.
- Ibrahim Mahama, contributo alla serie Messages of Hope di Designboom durante la pandemia di COVID-19.
- Marie-Ann Yemsi, curatrice della mostra Ubuntu, a Lucid Dream al Palais de Tokyo a Parigi.