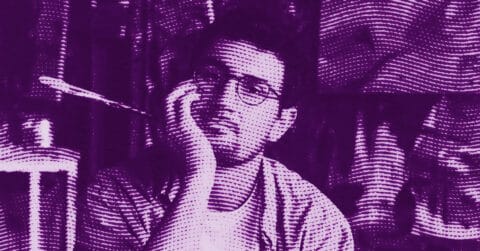Ascoltatemi bene, banda di snob. Choi Young Wook non è solo un altro pittore di anfore lunari. È un monaco zen mascherato da uomo d’affari, un cartografo dell’anima umana che ha scelto come supporto la più umile delle ceramiche coreane. Mentre voi vi esternate davanti agli scarabocchi concettuali dell’ultima biennale, quest’uomo traccia linee microscopiche su superfici bianche da vent’anni, come un Sisifo felice che ha scambiato la sua pietra con un pennello.
Attenzione, non vi propinerò il solito discorso sulla bellezza pura della ceramica Joseon o sull’estetica del vuoto. No. Ciò che accade nell’atelier di Paju è molto più radicale. Choi Young Wook pratica quello che definirei volentieri un minimalismo ossessivo che farebbe sembrare Sol LeWitt un barocco esuberante. Le sue tele? Monocromi quasi invisibili dove solo un occhio esperto distinguerà un’anfora da un semplice sfondo bianco. È quasi un insulto per lo spettatore abituato a essere accarezzato nel senso del pelo.
L’artista passa dieci ore al giorno a tracciare linee sottilissime sulle sue tele, ripetendo lo stesso gesto migliaia di volte come un calligrafo folle che avesse dimenticato i caratteri. Quelle famose linee che chiama “karma” dovrebbero rappresentare i nostri percorsi di vita che si incrociano e si separano. Affascinante. Tranne che, moltiplicandole, Choi Young Wook crea qualcosa di molto più interessante di una metafora new age: una texture visiva così densa da diventare quasi tattile. L’occhio si perde in questo labirinto di crepe immaginarie, cercando disperatamente un punto d’ancoraggio in questo bianco su bianco quasi monocromatico.
I collezionisti occidentali ne vanno ovviamente pazzi. Bill Gates ha comprato tre pezzi in una volta per la sua fondazione. Ma non facciamoci ingannare. Dietro l’apparente facilità commerciale di queste opere si nasconde una radicalità concettuale che non ha nulla da invidiare ai minimalisti americani degli anni ’60.
Nel catalogo della storia dell’arte contemporanea sudcoreana, l’arrivo negli anni ’70 del movimento Dansaekhwa ha segnato una svolta [1]. Questi artisti, tra cui Park Seo-Bo e Chung Sang-Hwa, hanno sviluppato una pratica della pittura monocromatica basata sulla ripetizione di gesti semplici e meditativi. Choi Young Wook si inscrive in questa discendenza, ma la spinge fino ai suoi limiti. Dove i maestri del Dansaekhwa cercavano la cancellazione del sé nel processo creativo, Choi afferma invece di proiettare la propria autobiografia in ogni linea tracciata.
“Racconto la storia della mia vita”, proclama. Ma quale vita può mai stare in queste intrecci di linee tutte simili? È proprio qui che il suo lavoro diventa interessante. Ripetendo instancabilmente lo stesso motivo, variando infinitamente i micro-dettagli delle sue crepe, Choi ci mette di fronte alla nostra percezione del tempo e della ripetizione. Le sue tele funzionano come test di Rorschach minimalisti: alcuni vedono montagne, altri onde, altri ancora costellazioni. Lo spettatore proietta le proprie ossessioni su queste superfici quasi vergini.
Questa dimensione proiettiva non è senza ricordare le esperienze condotte negli anni ’60 dal movimento Op Art. Bridget Riley, in particolare, esplorava come motivi geometrici ripetitivi potessero creare illusioni ottiche e sensazioni fisiche nello spettatore [2]. Ma dove Riley cercava l’effetto spettacolare, Choi coltiva l’impercettibile. Le sue opere richiedono un tempo di adattamento, un’abitudine dell’occhio che deve imparare a distinguere le sottili variazioni in ciò che appare inizialmente uniforme.
Il processo creativo in sé merita di essere esaminato attentamente. Choi inizia tracciando cerchi a matita sulla sua tela, cercando la forma perfetta del suo vaso immaginario. Poi applica strati successivi di materia, una miscela di gesso e polvere di pietra bianca che leviga instancabilmente. Questa tecnica non è senza richiamare le pratiche di alcuni pittori del Rinascimento italiano, che preparavano i loro pannelli con una meticolosità maniacale per ottenere superfici perfettamente lisce. Ma a differenza di loro, Choi non cerca di creare l’illusione della profondità. Al contrario, appiattisce deliberatamente lo spazio pittorico, creando una tensione tra la tridimensionalità suggerita del vaso e la radicale planarità della sua rappresentazione.
Nelle sue opere recenti, l’artista porta questa logica ancora più lontano. Le serie “Black & White” presentano vasi che scompaiono quasi completamente, assorbiti dall’oscurità o dalla luce. Restano solo le linee, che fluttuano in uno spazio indeterminato come spartiti musicali astratti. Si pensa alle ultime opere di Rothko, quei rettangoli neri che sembravano aspirare lo sguardo nella loro profondità senza fondo. Ma là dove Rothko cercava il sublime tragico, Choi coltiva una forma di serenità inquietante.
La mostra del 2020 alla Helen J Gallery di Los Angeles ha segnato una svolta. Per la prima volta, Choi presentava opere in cui il vaso non era più che un pretesto, frammenti ingranditi di superficie ceramica dove le crepe diventavano il soggetto principale. Queste tele astratte rivelano la vera natura del suo progetto: non rappresentare oggetti, ma mappare stati mentali, flussi di coscienza materializzati in reti di linee.
Va anche notata la strana coincidenza temporale del suo lavoro. Choi ha iniziato a dipingere vasi lunari nel 2005, proprio nel momento in cui il mercato dell’arte sudcoreano esplodeva sulla scena internazionale. Caso o calcolo? L’artista afferma di essere stato colpito da una rivelazione quasi mistica davanti a un vaso del Metropolitan Museum. D’accordo. Ma non si può non notare che la scelta di un motivo così identitario coreano giunge al momento giusto per cavalcare l’onda dell’hallyu.
Questa ambiguità tra sincerità spirituale e opportunismo commerciale attraversa tutta la sua opera. Choi si presenta come un asceta, trascorrendo le giornate nella solitudine del suo studio a meditare tracciando linee. Ma partecipa anche a numerose fiere internazionali, da Miami a Hong Kong. Questa doppia identità non è necessariamente contraddittoria. Riflette piuttosto la condizione dell’artista contemporaneo, diviso tra esigenze interiori e necessità di mercato.
Questo approccio può essere avvicinato al lavoro svolto da Agnes Martin negli anni Sessanta e Settanta. Anche Martin tracciava linee ripetitive su tele monocrome, cercando di raggiungere uno stato di purezza meditativa [3]. Anche Martin affermava di dipingere non ciò che vedeva ma ciò che sentiva. La differenza è che Martin cercava l’universale mentre Choi rivendica il particolare. I suoi vasi sono coreani, le sue linee sono autobiografiche. Paradossalmente, è forse questo che rende il suo lavoro più contemporaneo: i tempi non sono più quelli delle grandi astrazioni universali ma dei racconti identitari frammentati.
Il titolo generico delle sue opere, “Karma”, è particolarmente interessante. Il karma, nel pensiero buddhista, indica la legge di causalità che governa le nostre esistenze successive. Le nostre azioni presenti determinano le nostre vite future, in una catena infinita di cause ed effetti. Applicato all’arte, questo concetto assume una risonanza particolare. Ogni linea tracciata da Choi potrebbe essere la conseguenza di una linea precedente? Ogni quadro, il risultato karmico dei quadri precedenti?
Questa lettura rende la sua opera un “work in progress” potenzialmente infinito, una serie di variazioni su un tema unico che troverà la sua risoluzione solo con la morte dell’artista. È insieme grandioso e derisorio. Grandioso perché inserisce la sua pratica in una temporalità che supera la scala umana. Derisorio perché, in fondo, cosa cambia che dipinga cento o mille anfore lunari? Il gesto resta lo stesso, ossessivo e vano.
Ma è proprio questa vanità assunta che dà forza al lavoro di Choi. In un mondo dell’arte ossessionato dalla novità e dall’innovazione, fa il gioco della ripetizione. In un’epoca saturata di immagini, propone superfici quasi vuote. In un mercato che valorizza lo spettacolare, coltiva l’impercettibile. È o molto intelligente o completamente stupido. Probabilmente entrambe le cose.
L’artista stesso sembra consapevole di questa ambivalenza. “Non sto disegnando un’anfora lunare”, insiste. Sottile sfumatura che rivela tutta la dimensione performativa del suo lavoro. Choi non dipinge oggetti, ma mette in scena la propria trasformazione in oggetto. È body art concettuale, se si vuole, eccetto che il corpo è scomparso, sostituito da queste migliaia di linee che sono come le tracce digitali di una presenza assente.
Nel pantheon dell’arte contemporanea, dove collocare Choi Young Wook? Sicuramente non tra i provocatori o i trasgressori. La sua arte è troppo educata, troppo ben educata per questo. Ma nemmeno tra i conservatori accademici. La sua radicalità è altrove, in questa ostinazione maniacale di scavare sempre lo stesso solco, di esplorare sempre lo stesso territorio fino all’esaurimento.
Si pensa ovviamente a Roman Opałka che ha passato la vita a dipingere numeri in sequenza crescente su tele sempre più chiare [4]. O a On Kawara, che dipingeva ogni giorno la data del giorno su una tela monocromatica. Questi artisti concettuali hanno fatto della ripetizione sistematica la loro firma. Choi appartiene a questa famiglia, ma con una differenza notevole: dove Opałka e Kawara eliminavano ogni emozione dal loro processo, Choi invece pretende di caricare ogni linea di affetto personale.
Questa pretesa autobiografica è forse ciò che c’è di più sospetto nel suo lavoro. Come credere che dopo aver tracciato milioni di linee, ciascuna mantenga ancora un significato particolare? L’esercizio non diventa forse puramente meccanico, una routine priva di senso? È tutta l’ambiguità di queste pratiche ripetitive: oscillano costantemente tra meditazione e automatismo, tra presenza totale e assenza mentale.
Gli ultimi sviluppi della sua opera suggeriscono inoltre che Choi cominci lui stesso a annoiarsi delle sue anfore. I suoi tentativi di astrazione, gli zoom su frammenti di superficie, le sue sperimentazioni con il bianco e nero, tutto questo profuma di fuga in avanti. L’artista cerca di rinnovare una formula che comincia a esaurirsi. Normale: vent’anni a dipingere lo stesso motivo, è logorante. Anche i monaci zen finiscono per cambiare kōan.
Eppure, paradossalmente, è forse ora che il suo lavoro diventa davvero interessante. Abbandonando progressivamente la figurazione del vaso, mantenendo solo le reti di linee, Choi rivela ciò che era lì fin dall’inizio: una mappatura ossessiva della propria psiche. Questi intrecci di tratti non rappresentano più altro che se stessi, puri segni grafici liberati da ogni funzione rappresentativa.
Allora, Choi Young Wook, genio o impostore? Come tutti gli artisti che contano, è allo stesso tempo sincero nel suo approccio e calcolatore nella sua carriera, profondo nelle sue intenzioni e superficiale nei suoi effetti, innovativo per il suo radicalismo e conservatore per il suo attaccamento alla tradizione. È questa tensione irrisolta che rende interessante la sua opera.
Che cosa ci dice Choi della nostra epoca? Che siamo stanchi dei grandi gesti e dei manifesti fragorosi. Che preferiamo i sussurri alle grida. Che cerchiamo il senso nella ripetizione piuttosto che nella rottura. Che vogliamo credere che sia ancora possibile fare qualcosa di nuovo con il vecchio. Illusione forse, ma illusione necessaria.
I suoi vasi lunari continueranno a vendersi come il pane nelle fiere internazionali. I critici continueranno a discorrere sulla profondità zen delle sue crepe. I collezionisti continueranno a proiettare in essi i loro sogni di un Oriente mistico. E Choi continuerà a tracciare le sue linee, imperterrito, rinchiuso nella sua bolla di certezze, producendo in serie quegli oggetti di contemplazione standardizzati che sono il lusso del nostro tempo.
Forse questo è il vero karma dell’arte contemporanea: essere condannati a ripetere eternamente gli stessi gesti pretendendo che abbiano ancora un senso. Choi Young Wook lo ha compreso meglio di chiunque altro. Ed è per questo che, nonostante tutte le mie riserve, non posso fare a meno di trovare la sua opera stranamente toccante. Essa è lo specchio della nostra stessa vacuità, e questo è già molto.
- Sul movimento Dansaekhwa, vedere Yoon Jin Sup, Dansaekhwa: Korean Monochrome Painting, Seoul: Kukje Gallery, 2012.
- Su Bridget Riley e l’Op Art, vedere Frances Follin, Embodied Visions: Bridget Riley, Op Art and the Sixties, Londra: Thames & Hudson, 2004.
- Sulla pratica di Agnes Martin, vedere Arne Glimcher, Agnes Martin: Paintings, Writings, Remembrances, Londra: Phaidon Press, 2012.
- Sul lavoro di Roman Opałka, vedere Lorand Hegyi, Roman Opałka, Parigi: Éditions Dis Voir, 1996.