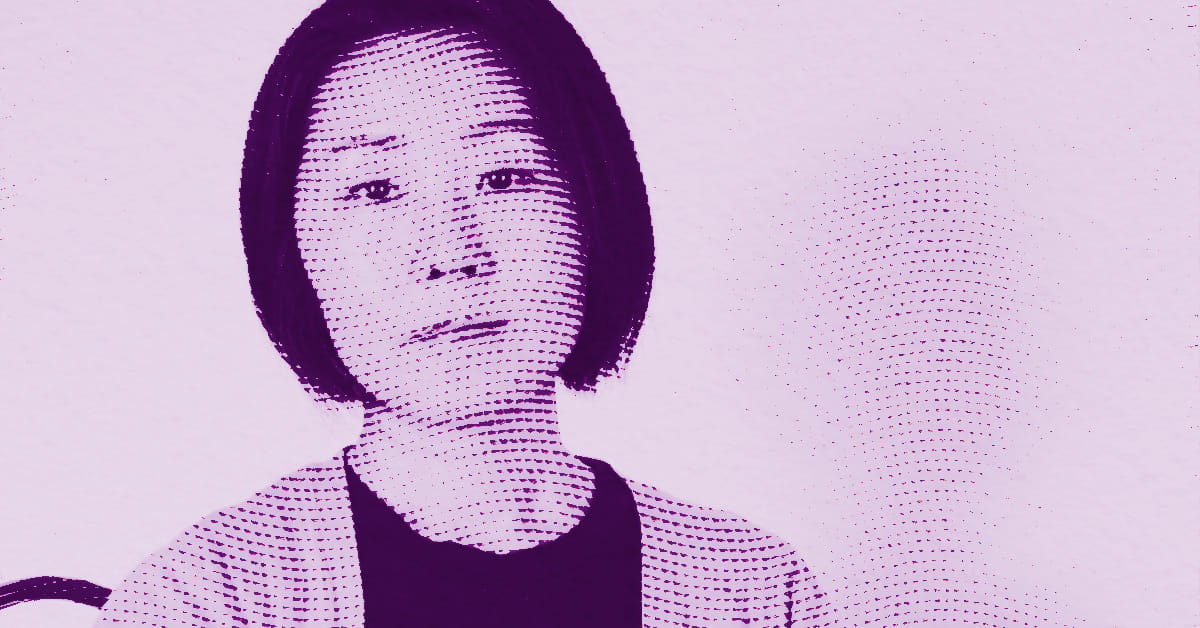Ascoltatemi bene, banda di snob, devo attirare la vostra attenzione sull’opera straordinaria di Naoko Sekine, artista giapponese il cui lavoro scuote le convenzioni stabilite dell’arte contemporanea con una sottigliezza e una profondità intellettuale indiscutibili, e che ha vinto, insieme ad altri due vincitori, il prestigioso Luxembourg Art Prize nel 2023, un riconoscimento artistico internazionale.
Sekine è una virtuosa del paradosso, che gioca tra l’immanenza e la trascendenza con una disinvoltura che farebbe invidia ai vostri artisti concettuali preferiti. Le sue opere, queste strutture scintillanti dove le linee fisiche e immaginarie si intrecciano, non sono semplici oggetti da contemplare ma dispositivi che ci costringono a ripensare il nostro rapporto con lo spazio e il tempo.
Prendete “Mirror Drawing-Straight Lines and Nostalgia” (2022), questa composizione monumentale di quasi tre metri per tre. L’opera evoca i paesaggi urbani di New York visti attraverso il prisma di Mondrian, ma Sekine spinge l’esperienza molto più oltre. I nove pannelli indipendenti di dimensioni diverse che costituiscono l’insieme creano linee fisiche che diventano parte integrante della composizione. Lucidando la superficie di grafite come si luciderebbe una pietra preziosa, lei trasforma la materia opaca in superficie riflettente, invitando lo spettatore e lo spazio circostante a fondersi nell’opera.
Questo approccio mi ricorda stranamente le riflessioni di Maurice Blanchot sullo spazio letterario, dove lo scrittore scompare dietro alla sua opera per lasciare spazio all’esperienza pura del linguaggio. In L’Espace littéraire (1955), Blanchot scriveva: “L’opera attira colui che vi si dedica verso il punto in cui essa è alla prova dell’impossibilità” [1]. Questo punto di impossibilità, Sekine lo materializza nelle sue superfici specchianti, creando una soglia dove l’immagine e il reale si confondono, dove lo spettatore si trova simultaneamente dentro e fuori, come sospeso in un intermezzo vertiginoso.
Quando Blanchot parlava della “solitudine essenziale dell’opera”, indicava questa capacità dell’arte di creare uno spazio autonomo che, paradossalmente, prende vita solo nell’incontro con lo spettatore. Le opere di Sekine incarnano perfettamente questa tensione: le loro superfici riflettenti assorbono e trasformano l’ambiente, rendendo ogni esperienza unica e contingente. È un’arte che rifiuta la fissità e reclama il movimento perpetuo della percezione.
In “Stacks Ⅱ” (2023), Sekine gioca con la nostra percezione dello spazio mettendo a confronto due tipi di linee: quelle create fisicamente dall’assemblaggio dei pannelli e quelle disegnate a mano. Questo dialogo tra il materiale e il rappresentato non è senza richiamare le riflessioni di Blanchot sulla distinzione tra il linguaggio ordinario, che fa scomparire le parole a favore del loro significato, e il linguaggio letterario, che fa apparire le parole nella loro stessa materialità.
Ciò che mi piace di Sekine è il suo modo di incorporare la serendipità nel suo processo creativo. Quando menziona gli “incidenti” che si verificano durante la creazione e che integra come elementi dell’opera, si percepisce un’artista che dialoga con la materia piuttosto che imporle una visione preconcetta. Questo approccio evoca irresistibilmente i principi del wabi-sabi giapponese, quell’estetica che valorizza l’imperfezione e l’impermanenza.
L’ispirazione che Sekine attinge alle grotte preistoriche francesi che ha visitato nel 2013 è particolarmente rivelatrice. Quegli artisti anonimi di 30.000 anni fa utilizzavano già i rilievi naturali delle pareti per completare le loro rappresentazioni animali, creando una fusione tra natura e intervento umano. Sekine prosegue questa tradizione millenaria integrando la fisicità dei suoi supporti nella composizione finale. L’arte non è più una semplice rappresentazione appiccicata su un supporto neutro, ma una collaborazione con la materialità stessa del mondo.
Passiamo ora alla serie “Colors”, nella quale Sekine estrae palette cromatiche da opere come “Les Licornes” di Gustave Moreau o “Model by The Wicker Chair” (“Modèle de la chaise en osier”) di Edvard Munch per creare composizioni puntiniste di una complessità sorprendente. Ciò che mi interessa qui non è tanto il riferimento a questi pittori quanto la struttura musicale che sostiene queste opere.
Infatti, questo è il secondo concetto che illumina l’opera di Sekine: la musicalità minimalista contemporanea. Nei suoi scritti, l’artista giapponese fa esplicito riferimento alla composizione “Music for 18 Musicians” del compositore americano Steve Reich come fonte fondamentale di ispirazione per il suo percorso artistico. Quest’opera cardine del minimalismo musicale, creata nel 1976, presenta una struttura particolare in cui diciotto strumentisti e vocalist generano collettivamente una trama sonora sofisticata senza la direzione di un direttore d’orchestra. Questo approccio compositivo riecheggia la pratica artistica di Sekine per la sua concezione non gerarchica dell’insieme: ogni elemento musicale (o visivo nel caso di Sekine) conserva la propria autonomia contribuendo a una coerenza globale dell’opera.
Il compositore John Cage, parlando della musica di Reich, osservava: “Non è un inizio-medio-fine, ma piuttosto un processo, un processo che si svela” [2]. Questa descrizione potrebbe applicarsi altrettanto bene alle opere di Sekine, in particolare alla sua serie “Colors” dove ogni punto colore, posizionato con precisione in un sistema di coordinate, crea un’esperienza visiva che trascende la somma delle sue parti.
Lo stesso Reich spiegava: “La musica come processo graduale mi permette di concentrarmi sul suono stesso” [3]. Analogamente, Sekine ci invita a concentrarci sull’esperienza visiva pura, piuttosto che sulla rappresentazione o sul messaggio. I suoi punti colore creano vibrazioni ottiche che ricordano i battiti ritmici di Reich, quella pulsazione che emerge dalla ripetizione di motivi simili ma leggermente spostati.
In “Colors-The Unicorns (383)” (2023), i punti colore formano quella che Sekine chiama una “struttura circolare”, in cui nessun elemento domina gli altri. Come nella musica di Reich, dove gli strumenti entrano e escono dalla composizione senza una gerarchia fissa, i colori di Sekine creano una rete di interazioni in cui lo spettatore percepisce movimenti, vibrazioni e mescolanze ottiche che non esistono materialmente sulla superficie. L’opera si completa nell’occhio e nella mente dello spettatore, proprio come la musica di Reich prende vita nell’orecchio dell’ascoltatore.
Questa idea di struttura circolare opposta alla struttura piramidale tradizionale dell’arte rappresentativa è particolarmente interessante. Sekine rifiuta l’idea di un motivo centrale al quale tutti gli altri elementi siano subordinati, preferendo una costellazione di elementi che interagiscono tra loro alla pari. È un approccio che riecheggia la musica minimalista processuale, dove i motivi si sovrappongono e si trasformano gradualmente, creando un’esperienza immersiva che evoca i cicli naturali.
I grandi compositori minimalisti hanno spesso dichiarato di non voler imitare, ma semplicemente comprendere i processi [4]. Potrebbe essere il motto di Sekine, che non cerca di riprodurre fedelmente immagini, ma di comprendere e rivelare i processi percettivi che danno origine alla nostra esperienza del mondo. I suoi “Mirror Drawings” riflettono letteralmente l’ambiente in cui sono esposti, trasformando ogni mostra in un’esperienza unica e contestuale.
E che dire del suo interesse per il Bunraku, quel teatro di marionette giapponese tradizionale? Anche qui si ritrova questa fascinazione per i sistemi in cui diversi elementi (manipolatori, narratori, musicisti) mantengono la loro indipendenza pur creando un’esperienza unificata. La separazione tra il narratore e la marionetta, tra la voce e il movimento, crea uno spazio intermedio in cui l’immaginazione dello spettatore può immergersi, esattamente come nelle opere di Sekine, dove le linee fisiche e disegnate creano un’intercapedine concettuale.
“Edge Structure” (2020) illustra perfettamente questo approccio. In quest’opera, Sekine taglia un disegno astratto seguendone i contorni, quindi estrae un quadrato dall’interno e riorganizza gli elementi per creare una nuova composizione. Questo processo di decostruzione e ricostruzione richiama il modo in cui la musica processuale scompone e ricompone i suoi motivi. L’artista visiva e il compositore esplorano entrambi come la trasformazione di strutture esistenti possa rivelare nuove possibilità percettive.
La musica minimalista americana è celebre per la “gradualità udibile” dei suoi processi musicali [5]. Questa trasparenza del processo si ritrova in Sekine, che non nasconde i meccanismi di creazione delle sue opere, ma al contrario li mette in evidenza. Le giunzioni tra i pannelli, le tracce di lucidatura, gli strati successivi di materiali, tutto è visibile, creando un’onestà materiale che coinvolge direttamente lo spettatore.
Ciò che mi piace di questi approcci artistici paralleli è la loro capacità di creare opere che sono allo stesso tempo intellettualmente stimolanti e sensualmente coinvolgenti. La musica minimalista, nonostante la sua rigorosa concezione, resta profondamente emozionante e fisicamente percepita. Allo stesso modo, le opere di Sekine, nonostante la loro sofisticata teoria, offrono un’esperienza visiva immediata e viscerale; queste superfici specchiate che catturano la luce e trasformano lo spazio creano una sensazione quasi tattile.
“Square Square” (2023), con i suoi rettangoli sfalsati e i diversi tipi di linee, crea quello che chiamerei una “polifonia visiva” in cui diversi strati di percezione si sovrappongono senza mai fondersi completamente. Questa stratificazione ricorda la tecnica dello “sfasamento” caratteristica della musica minimalista, in cui due motivi identici suonati a velocità leggermente diverse creano progressivamente configurazioni ritmiche complesse.
Vi sento già mormorare: “Un altro di quegli artisti intellettuali che fanno arte per i teorici”. Sbagliate. Ciò che salva Sekine dall’aridità concettuale è il suo attaccamento incrollabile alla sensualità della materia. Queste superfici levigate come specchi, queste linee che cambiano aspetto a seconda dell’angolo e della luce, questi punti di colore che vibrano nella nostra retina, tutto ciò crea un’esperienza estetica immediata che trascende l’intellettualizzazione.
È qui che risiede la vera originalità di Naoko Sekine: nella sua capacità di riconciliare approcci apparentemente contraddittori. Il concettuale e il sensuale, il piano e il volume, il fisso e il mobile, il controllato e il casuale coesistono nelle sue opere senza annullarsi a vicenda. Come nella musica minimalista contemporanea, dove la rigore matematica genera paradossalmente un’esperienza meditativa quasi mistica, le opere di Sekine utilizzano la precisione geometrica per aprirci a una percezione più fluida e intuitiva del mondo.
Se l’arte ha ancora un ruolo da svolgere nel nostro mondo saturo di immagini, è proprio questo: ricordarci che la nostra percezione non è una semplice registrazione passiva della realtà, ma una costruzione attiva in cui materialità e coscienza si intrecciano inestricabilmente. Le opere di Sekine, rendendo visibili questi meccanismi percettivi, ci invitano a un nuovo dialogo con il mondo visibile, un dialogo in cui non siamo più semplici spettatori, ma partecipanti attivi nella creazione del significato.
Allora la prossima volta che vedrete un’opera di Naoko Sekine, fermatevi un attimo. Osservate come la luce gioca su queste superfici levigate, come il vostro stesso riflesso si mescola alle linee tracciate dall’artista, come i punti di colore si trasformano a seconda della vostra distanza e del vostro angolo di visione. E forse sentirete, in questo dialogo silenzioso tra l’opera e la vostra percezione, gli echi lontani di quelle strutture musicali che tanto hanno ispirato l’artista, quelle pulsazioni ritmiche minimaliste che, come i battiti del nostro cuore, scandiscono il tempo della nostra esistenza.
- Maurice Blanchot, Lo spazio letterario, Gallimard, 1955.
- John Cage, Silenzio: Letture e Scritti, Wesleyan University Press, 1961.
- Steve Reich, Scritto sulla musica, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.
- Steve Reich, intervista con Jonathan Cott, The Rolling Stone Interview, 1987.
- Steve Reich, Musica come processo graduale in Scritto sulla musica, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.