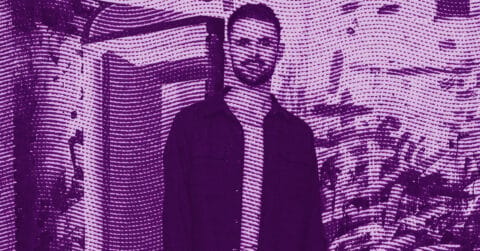Ascoltatemi bene, banda di snob : esistono ancora artisti che osano affrontare la materia grezza senza rifugiarsi dietro gli espedienti concettuali della nostra epoca. Nikola Vudrag, scultore croato nato nel 1989, appartiene a questa razza rara che preferisce il peso dell’acciaio ai chiacchiericci teorici. Formatosi alle accademie di Rijeka e poi di Zagabria, dove fu eletto miglior studente nel 2012, questo erede di una linea di metallurgisti trasforma il ferro in meditazioni tangibili. Le sue sculture monumentali, esposte da Venezia a Malta passando per Dubai, interrogano il nostro rapporto con il mito, la forma e il tempo con un’audacia che si distingue nel panorama attuale dell’arte contemporanea.
L’opera di Vudrag si sviluppa attraverso diverse serie distinte: i dodici lavori di Ercole che rivisitano la mitologia greca, i diamanti geometrici in acciaio Corten, la serie Net-Work composta da migliaia di barre metalliche saldate, e le installazioni monumentali nello spazio pubblico. Il suo vocabolario plastico attinge tanto alla geometria e alla fisica quanto ai racconti antichi, creando un linguaggio scultoreo che rifiuta la facilità del decorativo. I suoi Atlante e Prometeo, presentati alla 60ª Biennale di Venezia, incarnano questa duplice esigenza: rigore formale e profondità simbolica. L’artista non cerca di sedurre ma di confrontare lo spettatore con questioni essenziali sulla condizione umana.
Platone pervade lo studio di Vudrag, anche se lo scultore non lo nomina sempre esplicitamente. La distinzione platonica tra il mondo delle idee e quello delle apparenze sensibili trova nel suo lavoro una risoluzione inaspettata. Quando Vudrag crea i suoi diamanti luminosi, dove la luce sgorga dagli interstizi di un guscio di acciaio arrugginito, non si limita a un gioco formale: materializza il passaggio dall’intelligibile al sensibile. Queste sculture diventano metafore operative della teoria delle forme. L’acciaio, materia prima e industriale, fa da stampo a una luce che rappresenta l’idea stessa. Di giorno, queste opere rivelano la loro struttura grezza, le saldature apparenti, il loro peso terrestre. Di notte, la luce interna le trasforma in disegni geometrici, pure astrazioni luminose che sembrano sfidare la loro stessa materialità.
Questa dialettica tra materia e idea attraversa tutta la produzione di Vudrag. Nelle sue Mele delle Esperidi, esposte alla prima Biennale di Malta, la luce non decora: costituisce il senso stesso dell’opera. L’artista evoca esplicitamente Platone e Aristotele quando descrive il suo processo creativo, riconoscendo che “solo il mondo immaginario delle idee può raggiungere la forma perfetta” mentre la nostra realtà rimane necessariamente imperfetta. Questa lucidità filosofica lo ha portato a invertire il suo approccio: invece di inseguire invano la perfezione nella forma positiva, crea gusci metallici che plasmano il vuoto, permettendo alla luce, questa vecchia metafora platonica della conoscenza, di abitare lo spazio negativo. Il risultato produce un effetto sorprendente: forme monumentali e ruvide di giorno, disegni di luce eleganti di notte, come se l’Idea emergesse letteralmente dalla materia.
L’uso sistematico dell’acciaio Corten rafforza questa dimensione filosofica. Vudrag ama l’ironia di questo materiale che si protegge attraverso la propria corrosione, trasformando ciò che di solito distrugge i metalli in un meccanismo di conservazione. Descrive questa miscela di metalli nobili e ordinari come “il sangue della terra, qualcosa come l’ichor, quel fluido etereo dei miti omerici conosciuto come il sangue degli dei e dei titani” [1]. Questa concezione quasi-animista del materiale va oltre l’aneddoto poetico: inscrive il lavoro scultoreo in una cosmogonia dove la materia stessa possiede una dimensione mitologica. L’acciaio diventa portatore di una memoria e di una intenzionalità che risuonano con i racconti antichi che Vudrag rivisita. Atlante che porta il peso del mondo, Prometeo incatenato per aver rubato il fuoco: queste figure mitologiche trovano nel Corten patinato un medium che amplifica il loro carico simbolico.
La scultura monumentale possiede una storia lunga e tumultuosa, segnata da monumenti commemorativi pomposi, celebrazioni totalitarie e clamorosi fallimenti. Vudrag si iscrive in questa tradizione secolare pur reindirizzandola verso preoccupazioni contemporanee. Il suo monumento a Nikola Tesla, questa “scultura-linea di trasmissione” alta dodici metri e del peso di due tonnellate, coniuga funzionalità ed estetica, design urbano e patrimonio nazionale. Questo tipo di opera pubblica richiede una maestria tecnica imponente: calcoli statici, fondazioni di venti metri cubi di cemento, coordinamento di squadre di dieci persone o più. Rari sono gli scultori contemporanei che possono aspirare a questa ambizione di scala. La maggior parte preferisce installazioni effimere e interventi discreti, come se la monumentalità fosse diventata sospetta in linea di principio.
Eppure, Vudrag rivendica questa scala senza complessi. Il suo Poseidone di quattro metri, eretto di fronte al mare, il suo violino interattivo che consente ai passanti di suonare note, il suo Enso nella piazza principale di Čakovec: questi interventi urbani rifiutano la modestia postmoderna. Affermano che la scultura può ancora strutturare lo spazio pubblico, creare punti di riferimento simbolici, suscitare esperienze collettive. Questa ambizione lo avvicina paradossalmente ai minimalisti americani, in particolare a Richard Serra, la cui vicinanza materiale e visiva è stata sottolineata da diversi critici. Le lastre di acciaio Corten di Vudrag, la loro patina caratteristica, la loro imponente presenza fisica intrattengono un dialogo evidente con l’opera di Serra. Ma laddove Serra privilegiava l’astrazione pura e la fenomenologia della percezione spaziale, Vudrag reintroduce la figura e la narrazione mitologica.
Questa differenza merita di essere approfondita. Il minimalismo degli anni 1960-1970 aveva eliminato ogni riferimento esterno all’opera stessa: la scultura parlava solo di se stessa, del suo peso, del suo volume, del suo rapporto con lo spazio. Vudrag eredita questa lezione formale, con geometria rigorosa, franchezza dei materiali e rifiuto del modellato pittorico, ma la contraddice nel principio stesso reinserendo contenuti simbolici. I suoi animali poligonali, le sue figure mitologiche, le sue maschere della serie Net-Work restano riconoscibili nonostante il loro trattamento geometrico. L’artista realizza così una sintesi audace tra l’essenzialità minimalista e la tradizione rappresentativa, tra l’astrazione contemporanea e la narrazione antica. Questa posizione lo espone ovviamente alle critiche di entrambi i fronti: troppo figurativo per i puristi dell’astrazione, troppo geometrico per gli amanti della scultura classica.
La questione della tradizione metallurgica aggiunge uno strato supplementare a questa problematica. Vudrag insiste regolarmente sulla sua filiazione familiare: suo padre e suo nonno erano metallurgisti, e ha appreso il loro sapere fin dall’infanzia attraverso il gioco. Questa trasmissione generazionale del gesto tecnico non è insignificante in un’epoca in cui la maggior parte degli artisti subappaltano la fabbricazione delle loro opere ad officine specializzate. Vudrag modella personalmente l’acciaio nel suo laboratorio di trecentocinquanta metri quadrati, un ex sito industriale trasformato in spazio creativo. Questa prossimità fisica con il materiale, questa conoscenza intima delle sue proprietà e delle sue resistenze informano direttamente le forme che produce. L’artista non disegna sculture che altri eseguirebbero: pensa come un fabbro tanto quanto come scultore, lasciando al materiale il compito di guidare parzialmente il processo creativo.
Questo approccio contrasta fortemente con la crescente dematerializzazione dell’arte contemporanea. Mentre alcuni artisti si limitano a produrre concetti, istruzioni o file digitali, Vudrag difende una concezione arcaica e salutare dell’arte come confronto fisico con la materia. Le sue mani portano le tracce di questa lotta: ustioni da saldatura, tagli, calli. Il suo intero corpo partecipa all’elaborazione delle opere monumentali che richiedono forza e resistenza. Questa dimensione artigianale potrebbe sembrare retrograda se non si accompagnasse a un’apertura alle tecnologie contemporanee. Vudrag usa la scansione 3D per documentare le sue sculture, creare modelli digitali, pianificare le versioni a diverse scale. Integra sistemi di illuminazione LED in alcune opere, sfruttando le possibilità del digitale senza però rinunciare alla primazia del lavoro manuale.
Il suo percorso recente testimonia un riconoscimento internazionale crescente. La vendita dell’opera “Sumeran Maiden from the NET-WORK cycle (2023)” durante un’asta benefica a Varsavia per quasi 190.000 euro al martello ha fatto scalpore, stabilendo il suo valore sul mercato dell’arte. Questa cifra vertiginosa potrebbe suscitare sospetti: il mercato non consacra forse spesso gli artisti più insipidi? Ma nel caso di Vudrag, la valorizzazione commerciale accompagna un riconoscimento istituzionale legittimo. Le sue partecipazioni alle biennali di Venezia e Malta, le sue commissioni pubbliche in Croazia, le sue mostre in gallerie parigine consolidate, il suo ruolo di creatore delle monete euro croate: questo curriculum non ammette contestazioni.
L’artista si rivela inoltre consapevole dei pericoli del successo commerciale. Interrogato sui suoi progetti futuri, evoca il suo bisogno di ritirarsi regolarmente nel suo atelier, lontano dal rumore mediatico, per ritrovare “la solitudine, l’introspezione e i vecchi libri, camminando quasi sulla sottile linea tra ragione e follia alla ricerca di un nuovo momento personale “Eureka!”” [1]. Questa formulazione traduce una comprensione acuta del processo creativo come equilibrio precario tra controllo razionale e abbandono ispirato. Vudrag legge moltissimo, filosofia, mitologia e storia delle scienze, e questa erudizione alimenta il suo lavoro senza mai appesantirlo con uno sterile pedanteria. Le sue sculture parlano prima di tutto visivamente, per la loro presenza fisica e la loro forza plastica, prima di consegnare i loro strati di senso agli spettatori che si prenderanno il tempo di decifrarle.
Rimane la questione del mito, onnipresente nella sua opera. Perché questo ricorso sistematico ai racconti greci? Vudrag risponde lui stesso: “Se la storia si è ripetuta in varie forme per migliaia di anni, deve esserci un certo messaggio a cui prestare attenzione. Alla fine, quelli che ho decifrato e compreso mi hanno aiutato a capire meglio me stesso e il mondo che mi circonda” [1]. Questa giustificazione potrebbe sembrare ingenua se si dimenticasse che i miti greci costituiscono effettivamente un serbatoio inesauribile di archetipi psicologici e di strutture narrative universali. Atlante che porta il mondo, Prometeo che ruba il fuoco, Ercole che compie le sue dodici fatiche: queste figure incarnano esperienze umane fondamentali che risuonano ancora oggi. Lo scultore non le tratta come curiosità archeologiche ma come matrici di significato sempre attive.
La sua interpretazione del duo Atlante-Prometeo illustra questo approccio vivente al mito. Atlante diventa la mano che emerge dal suolo e afferra una colonna classica, simboleggiando il fardello e la forza necessari per portare il mondo. Prometeo si riduce a una mano tirata da una catena, rappresentando la ribellione e la ricerca della conoscenza a costo di conseguenze terribili. Vudrag collega esplicitamente queste due figure al destino umano: Atlante porta la testa, sede del mondo ideale; Prometeo rappresenta lo spirito cosciente che abita questa testa. Il loro destino comune di stress e pressione eterni costituisce, secondo l’artista, un’esperienza umana universale. Questa lettura esistenzialista dei miti antichi evita la trappola dell’allegoria semplicistica: le sculture non traducono meccanicamente un senso prestabilito ma aprono uno spazio di riflessione sulla nostra condizione.
L’ampiezza della produzione di Vudrag impressiona tanto quanto la sua qualità. In una decina d’anni di carriera, ha creato decine di sculture pubbliche, partecipato a più di sessanta mostre e vinto diversi premi. Questo ritmo di lavoro sostenuto richiede un’organizzazione rigorosa dell’officina, una gestione precisa degli ordini e delle scadenze, competenze che superano di gran lunga il quadro strettamente artistico. Vudrag si rivela anche imprenditore, manager e comunicatore. La sua facilità mediatica, la sua capacità di spiegare il suo lavoro in modo accessibile, la sua abilità a negoziare con le istituzioni e i collezionisti: questi talenti extra-artistici hanno certamente contribuito alla sua rapida ascesa. Alcuni puristi vi vedranno forse una concessione alle esigenze del mercato, ma questa critica sembra ingiusta. Un artista che desidera realizzare sculture monumentali nello spazio pubblico deve necessariamente padroneggiare queste dimensioni pragmatiche.
Arriva il momento di tirare qualche filo. L’opera di Nikola Vudrag si inserisce in una tradizione scultorea plurisecolare pur indirizzandola secondo linee di forza contemporanee. La sua fedeltà all’acciaio e al lavoro manuale, eredità di una trasmissione familiare, si coniuga con una consapevolezza acuta delle sfide filosofiche ed estetiche della nostra epoca. Il dialogo che stabilisce tra minimalismo e figurazione, tra astrazione geometrica e narrazione mitologica, tra monumentalità e intimità crea uno spazio singolare nel campo della scultura attuale. Né tradizionalista nostalgico né avanguardista provocatore, Vudrag occupa una posizione mediana che potrebbe sembrare scomoda ma che si rivela infine feconda. Dimostra che resta possibile scolpire la materia in modo ambizioso senza rinunciare alla profondità concettuale, creare opere pubbliche monumentali senza cadere nel retorico, attingere ai miti antichi senza scadere nell’accademismo polveroso.
Il suo utilizzo della luce come elemento scultoreo parte dalla constatazione platonica dell’impossibilità di raggiungere la perfezione formale nel mondo sensibile per inventare una soluzione originale: la forma negativa, lo stampo metallico che accoglie la luce. Questa inversione testimonia un’intelligenza plastica che non si limita a illustrare idee filosofiche ma le fa lavorare nella materia stessa. La ruggine protettiva dell’acciaio Corten, che lui paragona al sangue degli dei, cessa di essere una semplice proprietà chimica per diventare una metafora operativa del tempo che preserva invece di distruggere. Questi spostamenti semantici, queste condensazioni simboliche costituiscono la stessa carne del suo lavoro: impediscono alle sue sculture di ridursi ad allegorie trasparenti conferendo loro uno spessore di significato che va oltre la pura presenza fisica.
Nikola Vudrag è ancora un giovane artista. Gli restano, se il destino lo permette, diverse decadi di creazione davanti a sé. Difficile prevedere le evoluzioni che prenderà la sua opera: altri materiali, altre scale, altre tematiche? L’artista stesso menziona con entusiasmo i lavori di Eracle che devono ancora essere completati, suggerendo di non aver esaurito le possibilità del filone mitologico. Ma qualunque direzione sceglierà, avrà già dimostrato che uno scultore del XXI secolo può ancora affrontare l’acciaio e il mito con un rigore che rifiuta le facilità del tempo. Questa inflessibilità nella ricerca di una visione personale, questa capacità di coniugare rigore formale e generosità simbolica, questa ostinazione a scolpire piuttosto che discorrere: ecco cosa merita di essere celebrato in Nikola Vudrag. Il resto, i record d’asta, le biennali prestigiose e i riconoscimenti, non sono che schiuma sulla superficie di un lavoro paziente e ostinato che scava il suo solco nell’acciaio come nel tempo.
- Julien Delagrange, “A Conversation with Nikola Vudrag”, Contemporary Art Issue, 2024