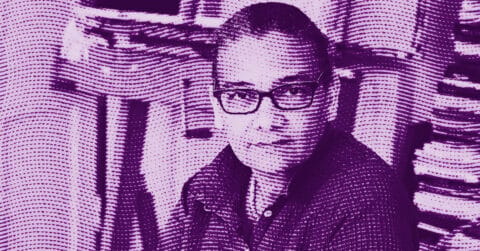Ascoltatemi bene, banda di snob : nell’arte contemporanea esiste una giovane artista libica che rifiuta le certezze facili, preferendo tessere il suo linguaggio negli interstizi dove si incontrano il tessile e l’architettura, la memoria e lo spostamento. Nour Jaouda, nata nel 1997, lavora tra Londra e Il Cairo, creando arazzi e installazioni che interrogano le nozioni di luogo, identità e spiritualità con una rara acutezza. La sua opera, presentata alla 60ª Biennale di Venezia nel 2024 e attualmente esposta a Spike Island (Bristol) fino a gennaio 2026, pone domande essenziali su cosa significhi abitare il mondo contemporaneo in uno stato di mobilità perpetua.
La poesia come mappatura dell’esilio
L’opera di Jaouda trova uno dei suoi ancoraggi più profondi nella poesia palestinese di Mahmoud Darwish. I tre arazzi presentati a Venezia si ispirano direttamente alla personificazione degli ulivi in Darwish, quegli alberi che incarnano sia l’ancoraggio che la spoliazione. Darwish scriveva da una posizione di esilio, cercando nel linguaggio poetico una patria portatile. Jaouda fa lo stesso con il tessile, creando ciò che chiama “un paesaggio di memoria che esiste in uno spazio liminale”. Il riferimento ai fichi di sua nonna a Bengasi, materializzato in Where the fig tree cannot be fenced (2023), prosegue questa meditazione sull’albero come metafora dell’appartenenza impossibile. Le forme vegetali sono decostruite fino a diventare quasi irriconoscibili, condensate in un paesaggio di verdi sovrapposti dove le lacune funzionano come silenzi poetici.
Ciò che è notevole è il modo in cui Jaouda traduce la sintassi poetica in vocabolario tessile. Ogni taglio, ogni assemblaggio, ogni tintura funziona come una metafora materializzata. I teorici postcoloniali Edward Said e Stuart Hall, che Jaouda cita come influenze intellettuali, hanno analizzato come l’identità culturale si formi in modo fluido piuttosto che fisso. Jaouda adotta questa prospettiva teorica ma la trasforma nel dominio del sensibile, creando opere che incarnano letteralmente questo processo di divenire. I suoi tessuti non rappresentano l’identità, la performano.
La scrittrice libanese Etel Adnan, da cui Jaouda riprende una citazione, “i luoghi geografici diventano concetti spirituali” [1], offre un altro punto d’ancoraggio. Adnan, che ha vissuto anche lei tra più lingue e più geografie, comprendeva che lo spostamento non è solo fisico ma ontologico. I luoghi diventano concetti, le mappe diventano meditazioni. Dust that never settles (2024), con i suoi blu oceanici e i verdi che si fondono, materializza questa idea di una geografia che rifiuta di fissarsi. La lentezza del processo creativo, tintura vegetale che impiega ventiquattro ore per impregnarsi nel tessuto, poi altre ventiquattro per asciugarsi, impone una temporalità meditativa vicina a quella della scrittura poetica. Ogni piega del tessuto trasportata nelle valigie diventa parte integrante dell’opera, iscrizione materiale del viaggio, archivio tattile dello spostamento.
L’architettura come soglia del sacro
Se la poesia fornisce il quadro concettuale, è l’architettura che struttura formalmente il lavoro di Jaouda. Il suo interesse per l’architetto egiziano AbdelWahed El-Wakil, noto per il suo uso dell’architettura vernacolare e della geometria divina, non è casuale. El-Wakil sosteneva l’idea che gli edifici non debbano essere permanenti. Questa visione trova un’eco diretta nella pratica di Jaouda, per la quale i tessuti possono essere arrotolati, trasportati, reinstallati in nuovi contesti.
L’installazione Before the Last Sky (2025), presentata alla Biennale d’arte islamica, è un esempio di questo approccio. L’opera comprende tre grandi arazzi sospesi dal soffitto e che scendono fino al pavimento, rappresentando le posture della preghiera islamica, sujud, ruqu’ e julus. Questi tessuti sono appesi a portali metallici decostruiti, creando un’inversione di prospettiva: le porte scendono dal cielo invece di innalzarsi dal suolo. L’installazione utilizza i motivi delle merlature islamiche, quelle forme architettoniche ornamentali che coronano le moschee. Le merlature interessano Jaouda perché costituiscono uno spazio liminale, alternando pieni e vuoti, terra e cielo, materiale e spirituale. Si concentra sugli spazi negativi tra le merlature, creando significato da ciò che è assente. Questo approccio rivela una comprensione sofisticata dell’estetica islamica, che evita la rappresentazione figurativa per esprimere il divino attraverso la ripetizione geometrica.
Il tappeto da preghiera, forma ricorrente nell’opera di Jaouda, costituisce il suo paradigma architettonico per eccellenza. Questo pezzo di tessuto ordinario diventa uno spazio sacro attraverso l’atto della preghiera. Crea un “terzo spazio” temporaneo, una soglia che può essere dispiegata ovunque. Questa portabilità del sacro risuona profondamente con l’esperienza della mobilità che caratterizza la vita dell’artista. Le strutture in acciaio che lei incorpora, portali e archi recuperati nei mercati del Cairo, funzionano come scheletri architettonici. Creano una struttura senza interrompere lo spazio, invitando lo spettatore a circolare intorno, attraverso. Per The Shadow of every tree ad Art Basel 2024, Jaouda ha costruito un ampio portale in acciaio che si estendeva per tutta la larghezza dello spazio, obbligando i visitatori a varcare questa soglia. Il portale negava l’accesso diretto pur invitando all’esplorazione.
Questa attenzione alle strutture che organizzano lo spazio senza sezionarlo ricorda i mashrabiya, quegli schermi di legno traforato che permettono di vedere senza essere visti. I tessuti di Jaouda funzionano in modo simile: creano spazi ma restano permeabili. L’installazione The iris grows on both sides of the fence (2025) a Spike Island, concepita come una tenda in collaborazione con gli artigiani di Chariah-el-Khayamia al Cairo, crea un luogo di lutto collettivo per i paesaggi sradicati. La scelta dell’iris di Faqqua, fiore nazionale della Palestina, per decorare questa tenda non è casuale. Questo fiore, simbolo di resistenza e speranza, cresce su entrambi i lati della barriera. L’architettura tessile di Jaouda rifiuta le divisioni binarie: crea spazi dove coesistono molteplici storie, molteplici geografie. Le sue opere non sono né dipinti né sculture, abitano il limbo, rifiutando le classificazioni rigide.
Il processo come filosofia
Il processo creativo di Jaouda incarna filosoficamente la sua visione. Inizia con lo schizzo delle forme geometriche e organiche che incontra: reticoli delle moschee del Cairo, motivi floreali, elementi architettonici vittoriani. Queste forme piatte vengono trasformate in oggetti che lei ritaglia, modella, strappa, ricostruisce e cuce. Il vocabolario che utilizza è rivelatore: “decostruzione”, “distruzione”, “distacco”. Questo approccio paradossale, costruire attraverso la decostruzione, trova giustificazione nei pensatori postcoloniali da lei citati. Hall e Said hanno dimostrato che le identità culturali si formano in modo fluido attraverso il movimento.
La tintura vegetale, processo lento e imprevedibile, conferisce ai pigmenti un’agency propria. I colori si infiltrano nelle fibre, trasformano la materialità del tessuto. Al Cairo, le sue opere si vestono di gialli caldi, blu profondi. A Londra, i colori si raffreddano, verdi cupi, marroni, viola. Il colore diventa una lingua che supera il linguaggio verbale. Questa pratica nomade inscrive fisicamente lo spostamento nell’opera. Jaouda afferma che questa “esistenza senza radici” [2] costituisce il cuore della sua ricerca. Le opere possiedono questa qualità rara di essere simultaneamente complete e incomplete. Questa indeterminatezza riflette la convinzione dell’artista che l’identità culturale sia “un processo costante di divenire” [3]. I tessuti non hanno né inizio né fine, partecipano a una continuità che supera l’oggetto individuale.
Abitare l’intervallo
Arrivati al termine di questa esplorazione, cosa ritenere? Il lavoro di Jaouda resiste alle semplificazioni, rifiuta appartenenze nette, coltiva l’ambiguità produttiva. La coerenza tra il suo approccio concettuale e la sua realizzazione materiale colpisce: la mobilità non è un tema che illustra, è la condizione stessa della sua pratica. I tessuti che si piegano, si trasportano, si reinstallano incarnano letteralmente l’idea di un’identità portatile. Il tappeto da preghiera che crea uno spazio sacro ovunque venga deposto diventa metafora di questa possibilità di portare con sé il proprio luogo, la propria storia.
In un mondo in cui i flussi migratori si intensificano, in cui milioni di persone vivono tra più paesi, più lingue, più culture, l’opera di Jaouda offre un modello per pensare questa condizione non come un deficit ma come una ricchezza, come la capacità di abitare più mondi simultaneamente. La dimensione spirituale merita che ci si soffermi. In un ambiente dell’arte contemporanea spesso allergico alle questioni religiose, Jaouda assume pienamente questa dimensione senza cadere nell’illustrazione pietistica. Il suo interesse per la preghiera islamica, per gli spazi sacri, non deriva da un approccio identitario difensivo ma da un’interrogazione sincera su cosa costituisca un luogo sacro.
La qualità poetica delle sue opere, questa capacità di condensare realtà complesse in forme evocative piuttosto che descrittive, li distingue da una certa arte concettuale che privilegia il discorso sull’esperienza sensibile. I tessuti di Jaouda funzionano a più livelli: possono essere apprezzati per la loro bellezza formale, i loro colori sontuosi; ma si offrono anche a letture più profonde per chi accetta di rallentare. Questa polisemia è una forza. Sarebbe tentante vedere in quest’opera una semplice reazione alla crisi geopolitica contemporanea. Sarebbe riduttivo. Certamente, la presenza dell’iris palestinese, il titolo Before the Last Sky che fa riferimento a Said, il riferimento ai fichi di Bengasi ancorano l’opera all’attualità tragica. Ma Jaouda rifiuta l’arte come illustrazione diretta del politico. Opera a un livello più sottile, creando spazi dove possano coesistere la bellezza e il lutto.
Ciò che rende necessario il suo lavoro è questa capacità di mantenere la complessità, di resistere alle semplificazioni binarie. In un’epoca in cui i discorsi si nutrono di divisioni nette, noi contro loro, qui contro là, Jaouda propone forme che abitano deliberatamente lo spazio intermedio. I suoi tessuti non sono né orientali né occidentali, né tradizionali né contemporanei. Esistono in questo spazio del “né né” che è anche un “e e”, affermando la possibilità di appartenenze multiple. L’opera di Jaouda ci ricorda che l’arte non ha lo scopo di fornire risposte definitive ma di mantenere aperte le domande essenziali. Cosa significa appartenere a un luogo quando si vive tra mondi diversi? Come portare con sé la propria cultura senza fissarla in folklore? Come creare il sacro? Come costruire attraverso la decostruzione?
Queste domande attraversano i suoi tessuti senza mai risolversi in certezze confortanti. È proprio questa tensione produttiva, questo equilibrio precario tra radicamento e sradicamento, presenza e assenza, materiale e spirituale che costituisce la forza del suo lavoro. In un secolo che si annuncia dominato dalle migrazioni, dove la questione del significato dell’avere o non avere un luogo si porrà con crescente intensità, l’opera di Jaouda offre molto più di una riflessione estetica. Propone un modo di esistere, un modo di abitare il mondo che riconcilia la mobilità con il bisogno di appartenenza. I suoi tessuti non sono oggetti da contemplare passivamente ma proposte esistenziali, inviti a ripensare il nostro rapporto con il luogo, l’identità, il sacro. Ecco perché Nour Jaouda è tra le voci artistiche più importanti della sua generazione.
- Etel Adnan, Journey to Mount Tamalpais, The Post-Apollo Press, 1986
- Sofia Hallström, “Artist Nour Jaouda’s landscapes of memory”, Art Basel, marzo 2024
- Lu Rose Cunningham, “In Conversation with Nour Jaouda”, L’Essenziale Studio Vol.08, aprile 2025