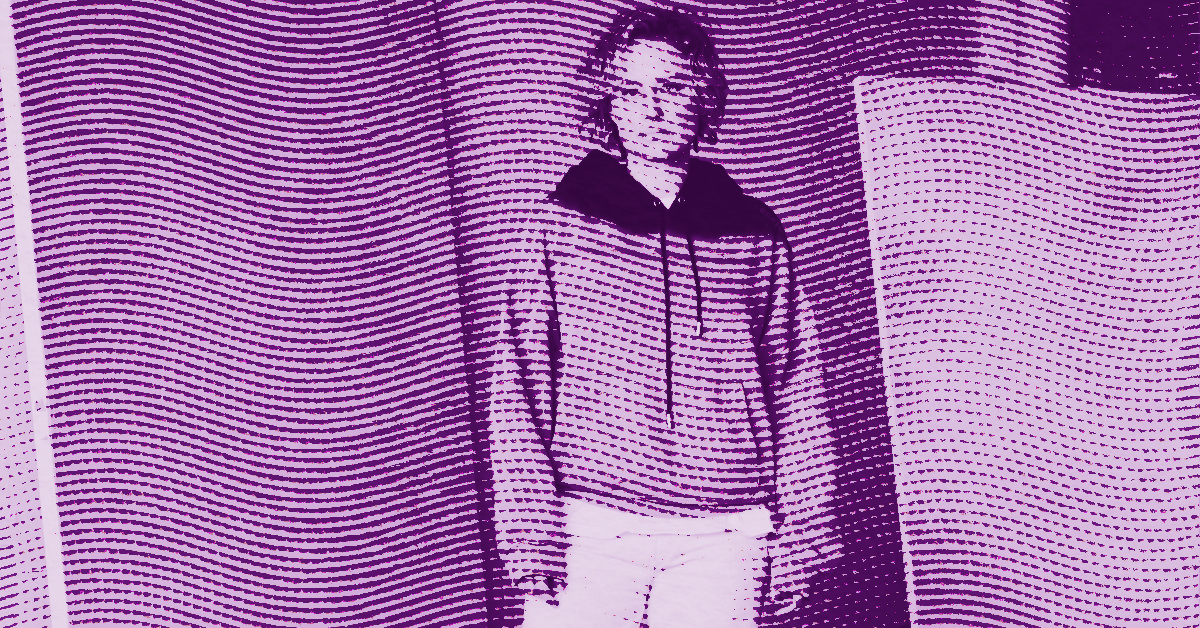Ascoltatemi bene, banda di snob: Robin F. Williams dipinge donne che rifiutano di essere guardate passivamente, e questo rifiuto costituisce forse l’atto artistico più radicale della sua generazione. Nata a Columbus, Ohio, nel 1984 e stabilita a Brooklyn, questa artista sviluppa da quasi due decenni un’opera che continua a interrogare, provocare e ribaltare le nostre aspettative riguardo alla rappresentazione femminile nell’arte contemporanea.
Williams lavora principalmente a olio, ma il suo arsenale tecnico comprende anche aerografo, stencil, pittura versata e varie tecniche di marmorizzazione che conferiscono alle sue tele monumentali una texture complessa e stratificata. Le sue figure femminili, rese a grandezza naturale o maggiori, possiedono quella qualità inquietante di osservarci a loro volta, creando una dinamica di potere invertita che destabilizza lo spettatore abituato a una contemplazione unilaterale.
L’universo visivo di Williams attinge le sue fonti da un registro volutamente eterogeneo: social network, folklore americano, ritratto storico, pubblicità vintage e, più recentemente, cinema horror di serie B. Quest’ultima ossessione merita attenzione, poiché rivela la profondità concettuale del suo approccio e la sua intelligenza strategica di fronte alle convenzioni patriarcali dello sguardo.
Il cinema horror, particolarmente il sottogenere dello slasher (film di serial killer) degli anni ’70 e ’80, occupa un posto centrale nelle mostre recenti di Williams: Watch Yourself (2023) a Città del Messico, Undying (2024) a Tokyo, e Good Mourning (2024) a New York. Questi film, spesso disprezzati dalla critica istituzionale e relegati allo status di intrattenimento di bassa lega, operano secondo Williams come archivi grezzi delle nostre paure collettive e dei nostri desideri repressi. In una conversazione con la rivista BOMB, afferma: “Viviamo per procura attraverso queste emozioni femminilizzate, che tuttavia sono emozioni umane. Per me, si tratta di accedere a tutta la gamma di emozioni che abbiamo deciso di riservare a certi generi a seconda delle circostanze” [1].
Questa riappropriazione del cinema horror va ben oltre un’esercizio referenziale o nostalgico. Williams identifica in questi film una struttura narrativa ricorrente dove la donna serve da veicolo emozionale, un corpo sofferente destinato a generare una reazione viscerale nello spettatore. Le figure di Carrie coperta di sangue di maiale, di Sally Hardesty che fugge nel furgone o delle adolescenti di The Slumber Party Massacre diventano sotto il suo pennello agenti narrativi dotati di una propria coscienza e di una capacità di reazione.
La tela Slumber Party Martyrs (2023) illustra perfettamente questa strategia di riappropriazione. Williams trasporta la composizione di Saint Sébastien soigné par Irène di Georges de La Tour, stabilendo un audace parallelismo tra la sofferenza dei martiri cristiani e quella delle vittime di serial killer. Questa sovrapposizione temporale e culturale suggerisce che l’estasi religiosa rappresentata nei musei europei e l’isteria femminile sfruttata da Hollywood derivano dallo stesso meccanismo di strumentalizzazione del corpo femminile. Le distorsioni dello schermo che Williams integra in alcune composizioni di questa serie ricordano costantemente allo spettatore la mediazione tecnologica attraverso cui consumiamo queste immagini di donne.
Il trattamento pittorico di Williams per queste scene orrifiche privilegia l’ambiguità emotiva rispetto al puro terrore. I suoi protagonisti mostrano talvolta un sorriso sardonico, un’espressione di noia o uno sguardo complice che contraddice la situazione drammatica in cui si trovano. Questa dissonanza tra l’iconografia attesa del genere e l’affetto reale delle figure crea un disagio produttivo, obbligando lo spettatore a riconsiderare le proprie aspettative e proiezioni.
Il riferimento al folklore e agli archetipi culturali attraversa anche questo corpus orrifico. Williams paragona i film di serial killer a racconti popolari costantemente reinterpretati, dove i codici del genere si trasmettono e trasformano da film a film, creando una mitologia collettiva della paura di genere. Questa dimensione folkloristica spiega perché i suoi dipinti conservano una forte qualità narrativa nonostante il loro trattamento formale sofisticato.
L’uso del moiré, quell’effetto di distorsione che appare quando si fotografa uno schermo con uno smartphone, diventa per Williams una metafora visiva dei molteplici filtri mediali attraverso cui percepiamo la femminilità. Queste interferenze ottiche ricordano che non vediamo mai direttamente le donne, ma sempre attraverso strati di rappresentazioni culturalmente costruite. Il cinema horror, nella sua brutalità franca e nella sua codificazione estrema, rende questi meccanismi visibili e quindi criticabili.
Le tele derivanti da questa esplorazione cinematografica manifestano anche un interesse per il colore come agente di distanziamento. Williams cita Joan Semmel, pittrice femminista che rappresentava scene sessuali con scelte cromatiche deliberatamente artificiali per contrastare l’erotizzazione automatica dei corpi femminili. Williams applica una strategia simile, saturando le sue composizioni di rosa elettrico, blu digitale e arancione tossico che impediscono qualsiasi lettura naturalistica della violenza rappresentata.
L’altro pilastro concettuale dell’opera di Williams risiede nel suo dialogo costante con la storia dell’arte, particolarmente la tradizione della pittura figurativa occidentale e le sue convenzioni riguardo al nudo femminile. Qui emerge con un’incisività notevole una figura tutelare: Édouard Manet e il suo Olympia (1863), quadro che Williams considera un testo fondante per la sua pratica.
In diverse interviste, Williams racconta il suo pellegrinaggio regolare davanti a Olympia al museo d’Orsay, descrivendo l’emozione intensa che le suscita lo sguardo diretto e indomito della prostituta dipinta da Manet [2]. Questo quadro, scandaloso alla sua presentazione al Salon de Paris nel 1865, disturba proprio perché rifiuta i codici di passività e idealizzazione che fino a quel momento caratterizzavano la rappresentazione del nudo femminile. Olympia non finge di essere una dea mitologica come le Veneri di Tiziano o di Cabanel; guarda lo spettatore con una consapevolezza acuta della sua presenza e delle sue intenzioni.
Williams identifica in questo sguardo frontale una strategia di resistenza che sistematizza e radicalizza nella propria pittura. Le sue figure possiedono tutte quella qualità inquietante di consapevolezza di sé che Manet aveva introdotto nella storia dell’arte moderna. Come spiega: “Mi piace pensare che le figure delle mie opere posseggano una forma di consapevolezza di sé, ed è un modo per me di giocare con la dinamica di potere tra lo spettatore e la figura nel quadro” [3].
Questa autocoscienza delle figure dipinte pone una domanda filosofica vertiginosa che Williams formula con una candida disarmante: i suoi dipinti possiedono una forma di coscienza? Intellettualmente, sappiamo che si tratta di pigmenti su tela, di illusioni bidimensionali. Tuttavia, l’esperienza fenomenologica davanti a certe opere di Williams suggerisce una presenza, un’agentività che eccede il loro stato di oggetti inanimati.
Questa interrogazione sullo status ontologico dell’immagine dipinta si inserisce in una precisa genealogia artistica. Manet, ma anche George de La Tour con i suoi santi illuminati a candela, George Tooker con le sue figure isolate in spazi burocratici, tutti quei pittori che Williams cita come influenze condividono un’attenzione particolare alla qualità dello sguardo e all’implicazione dello spettatore nella scena rappresentata.
La mano di Manet sul sesso di Olympia, quella mano piatta e quasi batraciana che Williams menziona specificamente, segnala il lavoro, la transazione commerciale, la materialità del corpo prostituito. Williams trasporta questa franchezza nelle proprie composizioni, rifiutando sistematicamente l’estetizzazione consolatoria. I suoi nudi non sono mai graziosi nel senso accademico; mostrano una corporalità frontale, a volte aggressiva, che respinge la compiacenza voyeuristica.
La mostra Your Good Taste Is Showing (2017) esplorava già questa tensione tra femminilità commercializzata e resistenza soggettiva. Williams presentava donne nelle pose delle pubblicità delle riviste di moda, ma con espressioni facciali che contraddicevano la sottomissione attesa. Il titolo stesso funziona come una provocazione ironica: il buon gusto, questa nozione borghese di decenza estetica, è proprio ciò che Williams rifiuta di rispettare.
La ex critica d’arte del New York Times, Roberta Smith, aveva perfettamente colto questa dimensione sovversiva scrivendo che i dipinti di Williams “prendono di mira le idealizzazioni impossibili della donna nell’arte come nella pubblicità, rappresentando supermodelle androgine, per lo più nude e irraggiungibili” [4]. Questa formulazione cattura l’ambivalenza produttiva dell’opera: simultaneamente seducente e respingente, esteticamente sofisticata e concettualmente corrosiva.
La tecnica pittorica stessa diventa in Williams un sito di resistenza alle gerarchie culturali. Il suo utilizzo dell’aerografo, dello stencil, delle catene metalliche per creare effetti di texture evoca i tutorial di YouTube e TikTok, quell’universo della pittura amatoriale e democratizzata che l’istituzione artistica disprezza. Williams rivendica esplicitamente quella filiazione con la cultura “crafty”, quel termine inglese che designa simultaneamente l’abilità manuale, la domesticità femminile e l’astuzia strategica.
Incorporando queste tecniche considerate di basso livello in composizioni monumentali destinate alle gallerie internazionali e alle collezioni museali, Williams opera un’inversione simbolica dei valori artistici. Demolisce il mito del genio solitario, quella figura romantica e intrinsecamente maschile che domina ancora l’immaginario dell’arte contemporanea. La sua pittura proclama che si può essere tecnicamente virtuose pur rifiutando la serietà patriarcale della grande pittura.
La serie recente che incorpora gli assistenti virtuali Siri e Alexa in corpi di attrici hollywoodiane costituisce forse l’approdo logico di questa riflessione sulla coscienza, la rappresentazione e l’agency. Williams immagina queste intelligenze artificiali femminilizzate come prigioniere che cercano di fuggire dai loro sistemi operativi tecnologici. Siri Calls For Help, ispirata a una scena di Rosemary’s Baby in cui Mia Farrow telefona da una cabina, visualizza l’assurdità kafkiana di un assistente digitale che avrebbe bisogno di aiuto ma non potrebbe usare il telefono che abita per chiamarlo.
Queste opere proiettano in un futuro prossimo le questioni che Manet si poneva già nel diciannovesimo secolo: chi guarda chi? Chi detiene il potere nello scambio visivo? Quale forma di soggettività può emergere da un corpo costantemente oggettivato, mediato, strumentalizzato? Williams non propone risposte consolatorie, ma i suoi dipinti mantengono aperte queste domande con un’urgenza che non ha perso nulla della sua pertinenza.
L’ampiezza dell’opera di Williams, la sua coerenza concettuale nonostante le evoluzioni stilistiche, e la sua capacità di intrecciare cultura alta e bassa, riferimenti storici e preoccupazioni contemporanee, la rendono una voce essenziale della pittura americana contemporanea. Il suo lavoro dimostra che la figurazione, lungi dall’essere esaurita o reazionaria, resta un terreno fertile per l’esplorazione critica delle strutture di potere e delle convenzioni di rappresentazione.
La prima mostra museale monografica di Williams, We’ve Been Expecting You, presentata al Columbus Museum of Art nel 2024, offriva una panoramica di diciassette anni di produzione. Il titolo stesso, con il suo tono leggermente minaccioso e la sua implicazione per il visitatore, riassume perfettamente l’approccio dell’artista: queste figure ci aspettavano, sapevano che saremmo venuti a guardare, e sono pronte a ricambiare questo sguardo con un’intensità che destabilizza le nostre certezze.
L’opera di Williams ci ricorda che la pittura rimane un medium vivo, capace di porre domande filosofiche complesse offrendo al contempo il piacere sensuale del colore, della texture e della forma. Dimostra che si può essere contemporaneamente una virtuosa tecnica e una teorica rigorosa, un’erede della grande tradizione pittorica e un’iconoclasta radicale. In un mondo saturo di immagini digitali effimere, le sue tele monumentali affermano la persistente ostinazione dello sguardo umano e la possibilità di una rappresentazione che rifiuta l’oggettificazione. Ecco perché il suo lavoro è importante, ecco perché bisogna prestare attenzione ora. Queste donne dipinte non spariranno, non distoglieranno lo sguardo, non faciliteranno il nostro comfort visivo. Sono qui per restare, e spetta a noi imparare a sostenere il loro sguardo.
- Londres, Michael. “Robin F. Williams by Michael Londres”, BOMB Magazine, 12 agosto 2024.
- Indrisek, Scott. “Robin F. Williams Revels in the Craft of Painting”, Artsy, 27 marzo 2020.
- Cepeda, Gaby. “Robin F. Williams”, Artforum, giugno 2023.
- Smith, Roberta. Citazione apparsa nell’articolo Wikipedia “Robin F. Williams”, consultato nell’ottobre 2025.