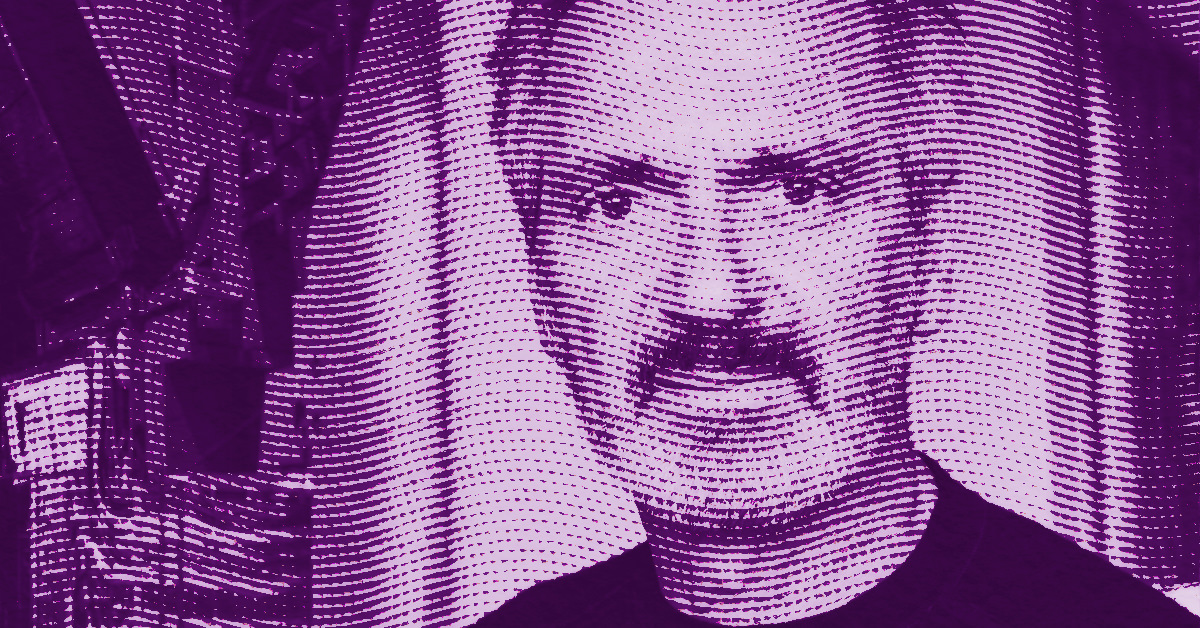Ascoltatemi bene, banda di snob, Thomas Struth non è né il cronista freddo che alcuni pretendono di vedere né il semplice erede dei Becher che si ostina a descrivere. Quest’uomo di settantuno anni ci offre da quasi cinque decenni un’opera di una coerenza implacabile, costruita come una cattedrale dell’immagine contemporanea dove ogni serie dialoga con le altre secondo una logica tanto rigorosa quanto un sistema filosofico. La sua macchina fotografica diventa lo strumento di un’indagine permanente sulle strutture che organizzano la nostra esistenza collettiva, dalle strade deserte di Düsseldorf ai laboratori del CERN, passando per quei ritratti di famiglia inquietanti e quelle scene di museo dove si gioca il teatro eterno dello sguardo.
L’indagine urbana
Fin dalla fine degli anni 1970, Struth sviluppa un approccio fotografico che rompe con le convenzioni documentarie del suo tempo. Le sue fotografie urbane in bianco e nero rivelano meno la superficie visibile delle città che la loro struttura profonda, quella geometria nascosta che organizza i nostri spostamenti e i nostri incontri. In Düsselstrasse, Düsseldorf (1979), l’artista non si limita a documentare un paesaggio urbano : rivela la stratificazione temporale di una società, quegli strati di intenzioni successive che si accumulano nello spazio pubblico come le stratificazioni geologiche testimoniano il lungo tempo della Terra.
Questo metodo trova un’eco particolare nell’opera di Robert Musil [1], quello scrittore austriaco che descriveva l’uomo moderno come plasmato da “le contro-formazioni di ciò che ha creato”. In L’Uomo senza qualità, Musil osservava che “i muri della strada irradiano ideologie”, una formula che sembra scritta per le fotografie urbane di Struth. L’artista tedesco coglie proprio queste radiazioni ideologiche nelle sue inquadrature frontali e nelle sue prospettive centrali. Ogni facciata, ogni finestra, ogni traccia di usura racconta la storia di una decisione collettiva, di una scelta architettonica, di un adattamento pragmatico ai vincoli del reale.
La città secondo Struth diventa una testimonianza gigante in cui si sovrappongono le intenzioni di molteplici attori storici. Architetti, urbanisti, abitanti, commercianti, autorità pubbliche : tutti hanno lasciato il loro segno in quegli spazi che l’obiettivo rivela come tanti “luoghi inconsci” dove si cristallizzano i rapporti di forza di un’epoca. Questo approccio supera di gran lunga il semplice constatare sociologico per raggiungere una vera archeologia del presente, dove ogni dettaglio architettonico testimonia le tensioni che lavorano sul corpo sociale.
L’assenza sistematica di figure umane in queste immagini rafforza la loro dimensione di indagine sulle strutture piuttosto che sugli individui. Struth ci invita a capire come l’ambiente costruito condizioni i nostri comportamenti, i nostri spostamenti, le nostre possibilità di incontro o di isolamento. Queste strade vuote non sono disabitate: sono saturate dalla presenza fantomatica di tutti coloro che le hanno percorse, trasformate e abitate. Il fotografo rivela così la dimensione profondamente politica dello spazio urbano, quella capacità del quadro architettonico di orientare i nostri gesti e i nostri pensieri secondo logiche che ci superano.
I ritratti di famiglia
L’evoluzione verso la fotografia di famiglia segna un punto di svolta decisivo nell’opera di Struth. Questi ritratti, iniziati negli anni 1980 in collaborazione con lo psicoanalista Ingo Hartmann, esplorano i meccanismi attraverso cui si trasmettono le strutture sociali elementari. Lontano dalle convenzioni del ritratto borghese, queste immagini rivelano la complessità delle dinamiche familiari contemporanee, quei sottili giochi di prossimità e distanza che organizzano i rapporti tra generazioni.
Il riferimento alle teorie di Jacques Lacan [2] è imprescindibile qui per cogliere tutta la portata di queste composizioni. Lo psicoanalista francese aveva mostrato come la famiglia costituisca il primo luogo di strutturazione simbolica dell’individuo, quello spazio in cui si stringe il rapporto con l’autorità, con la differenza dei sessi, con la trasmissione intergenerazionale. I ritratti di Struth mostrano precisamente questi meccanismi all’opera nell’organizzazione spaziale dei corpi, nella distribuzione degli sguardi, nella gestualità che tradisce le sfide inconsce di ogni configurazione familiare.
In The Richter Family (1989), per esempio, la disposizione dei personaggi rivela molto più di una semplice composizione estetica: mappa i rapporti di potere, le alleanze tacite, le distanze affettive che strutturano questo microcosmo sociale. La presenza del figlio tra le braccia del padre, la distanza mantenuta con la moglie, la disposizione degli oggetti nello spazio domestico: ogni dettaglio partecipa a una grammatica relazionale che l’obiettivo di Struth decifra con precisione clinica.
Queste immagini funzionano come tante “scene primitive” nel senso che Lacan intendeva, quei momenti fondativi in cui si cristallizza l’organizzazione psichica del soggetto. Fotografando i suoi cari e le loro famiglie, Struth non indulge mai in un intimismo complice: mantiene questa distanza analitica che permette di cogliere i meccanismi universali all’opera in queste configurazioni singolari. I suoi ritratti rivelano come ogni famiglia riproduca, adatti o sovverta i modelli relazionali ereditati dalla storia collettiva.
La tecnica fotografica stessa partecipa a questo approccio psicoanalitico. I tempi di posa relativamente lunghi, la necessità di mantenere una posizione statica, l’attesa condivisa di fronte all’obiettivo: tutti questi elementi creano una situazione artificiale che rivela le tensioni di solito mascherate dalla fluidità delle interazioni quotidiane. Struth trasforma così l’atto fotografico in un dispositivo rivelatore, capace di far affiorare le strutture inconsce che organizzano i legami familiari.
L’artista evita accuratamente la trappola del voyeurismo mantenendo i suoi modelli nella loro dignità. Queste famiglie posano con gravità, consapevoli di partecipare a un’impresa che le supera. Diventano i rappresentanti di configurazioni sociali più ampie, permettendo allo spettatore di riconoscere in questi volti sconosciuti qualcosa dei meccanismi che organizzano la sua propria storia familiare. Questa universalizzazione del particolare costituisce uno dei grandi temi estetici di questa serie, che trasforma l’aneddoto personale in rivelazione antropologica.
Le fotografie di museo
La serie delle fotografie di musei, sviluppata dalla fine degli anni 1980, costituisce forse il compimento più maturo dell’approccio di Struth. Queste immagini, che mostrano visitatori intenti a contemplare opere d’arte, mettono in scena la complessità dell’esperienza estetica contemporanea interrogando al contempo le condizioni di possibilità dello sguardo artistico nella nostra epoca saturata d’immagini.
Art Institute of Chicago II (1990) è un esempio perfetto di questo approccio. Una donna con un passeggino si trova davanti a Rue de Paris, temps de pluie di Gustave Caillebotte. La sua silhouette contemporanea fa eco alle figure del dipinto impressionista, creando un dialogo temporale sorprendente tra due epoche della modernità urbana. Struth rivela così come l’arte del passato continua a illuminare il nostro presente, ma anche come il nostro sguardo contemporaneo trasformi retroattivamente il significato delle opere antiche.
Queste fotografie funzionano secondo una logica di mise en abyme vertiginosa: osserviamo persone che guardano opere che rappresentano altre persone che osservano il mondo. Questa moltiplicazione dei livelli di sguardo rivela la dimensione fondamentalmente riflessiva dell’esperienza artistica. Struth non si limita a documentare la frequentazione dei musei: indaga i meccanismi attraverso cui si costituisce il nostro rapporto collettivo con l’arte e la storia.
L’influenza del pensiero di Hans Belting su questa serie merita di essere sottolineata. Lo storico dell’arte tedesco aveva mostrato come le immagini funzionino come “labirinti” in cui si perdono i nostri tentativi di controllo razionale del visibile. Le fotografie di Struth attualizzano questa intuizione rivelando la complessità dei processi percettivi all’opera nella contemplazione artistica. Ogni visitatore porta la sua storia, i suoi riferimenti, le sue aspettative, creando una polifonia interpretativa che l’obiettivo del fotografo riesce a cogliere nella sua dinamica collettiva.
L’organizzazione spaziale di queste immagini rivela altresì una riflessione approfondita sulle questioni politiche della diffusione culturale. Queste masse di turisti che si affollano davanti a La Joconde o agli affreschi di Raffaello testimoniano la democratizzazione dell’accesso all’arte, ma anche la sua trasformazione in spettacolo di consumo. Struth evita accuratamente la trappola della facile denuncia: le sue immagini rivelano piuttosto la persistenza del desiderio estetico nel cuore stesso di questa economia dell’attenzione che caratterizza la nostra epoca.
Natura e Politica : L’indagine tecnologica
La serie Nature et Politique (2008-2015) segna una nuova tappa nell’evoluzione dell’opera di Struth. Queste fotografie di laboratori scientifici e installazioni tecnologiche rivelano il retroterra della nostra civiltà tecnica, quei luoghi di solito invisibili dove si plasma il nostro futuro collettivo. L’artista vi prosegue la sua indagine sulle strutture contemporanee secondo un metodo che sintetizza i risultati delle sue ricerche precedenti.
In Tokamak Asdex Upgrade Periphery (2009), Struth ci confronta con la complessità vertiginosa dei dispositivi per la fusione nucleare sviluppati presso l’Istituto Max Planck. Questi intrecci di cavi, tubi e apparecchiature varie rivelano l’esistenza di un mondo tecnico che sfugge ampiamente alla nostra comprensione comune. L’artista non cerca di spiegare o semplificare: rivela piuttosto la crescente distanza tra la sofisticazione dei nostri strumenti e la nostra capacità collettiva di comprenderne le implicazioni.
Queste immagini funzionano come allegorie della nostra condizione contemporanea, presa tra le promesse tecnologiche e la nostra incapacità di controllarne le conseguenze. Struth rivela la bellezza plastica di queste installazioni mantenendo il loro carattere enigmatico. Questi laboratori diventano le cattedrali della nostra epoca, luoghi di culto di una razionalità tecnica che pretende di risolvere le sfide ecologiche ed energetiche dell’umanità.
La serie si conclude con una meditazione inquietante con le fotografie di animali morti realizzate presso l’Istituto Leibniz di Berlino. Queste immagini di zebre, orsi o volpi colti nel loro ultimo riposo rivelano la fragilità universale del vivente di fronte alle promesse di eternità tecnologica. Struth instaura così un dialogo toccante tra le nostre ambizioni prometeiche e la realtà immutabile della mortalità, ricordando che ogni politica rimane inscritta nei limiti della condizione naturale.
L’architettura di un’opera totale
L’opera di Thomas Struth resiste ai tentativi di classificazione in serie distinte. Funziona piuttosto come un sistema complesso in cui ogni insieme di immagini dialoga con gli altri secondo una logica d’insieme che rivela progressivamente la sua coerenza. Questa architettura globale trasforma ogni fotografia individuale in elemento di una ricerca più ampia sulle condizioni contemporanee dello sguardo e della rappresentazione.
Questo approccio sistemico colloca Struth nella linea dei grandi investigatori della modernità, da Charles Dickens che descrive le trasformazioni della Londra industriale a James Joyce che mappa Dublino in Ulysse. Come questi scrittori, il fotografo tedesco costruisce un’opera-mondo capace di cogliere le profonde mutazioni del suo tempo secondo un metodo che unisce rigore analitico e sensibilità estetica.
L’influenza del suo passato nella pittura rimane percepibile in questa concezione architettonica dell’opera fotografica. Struth compone le sue serie come un pittore organizza gli elementi di un polittico: ogni pannello possiede la sua autonomia pur partecipando a un progetto d’insieme che lo supera. Questo approccio gli permette di evitare la trappola del documentario illustrativo per raggiungere una vera poetica del contemporaneo.
La temporalità particolare di questa costruzione è interessante. Contrariamente alle logiche dell’attualità mediatica, Struth sviluppa le sue ricerche seguendo un ritmo lento che gli permette di approfondire progressivamente la sua comprensione dei fenomeni studiati. Questa pazienza rivela il suo debito verso la tradizione tedesca della Bildung, questa formazione progressiva della coscienza attraverso l’accumulo ragionato delle esperienze e delle conoscenze.
L’opera di Struth testimonia un’ambizione rara nell’arte contemporanea: quella di costruire un sistema di rappresentazione capace di cogliere la complessità del mondo contemporaneo senza sacrificare né il rigore analitico né l’esigenza estetica. Questa sintesi colloca il fotografo tedesco tra i creatori indispensabili per comprendere le trasformazioni della nostra epoca e le sfide che esse pongono alla nostra capacità collettiva di rappresentazione e di azione.
In un mondo saturo di immagini istantanee, Thomas Struth ci ricorda che la fotografia può ancora servire da strumento di conoscenza e di rivelazione. La sua opera dimostra che la pazienza dello sguardo può rivelare strutture invisibili, che il rigore della composizione può rivelare verità nascoste, che l’arte può ancora pretendere di illuminare la nostra condizione comune senza rinunciare alla sua dimensione estetica. Questa lezione rimane più attuale che mai nella nostra epoca di confusione visiva e di sovrapproduzione di immagini.
- Robert Musil, L’Homme sans qualités, Seuil, 1956-1957
- Jacques Lacan, Écrits, Seuil, 1966