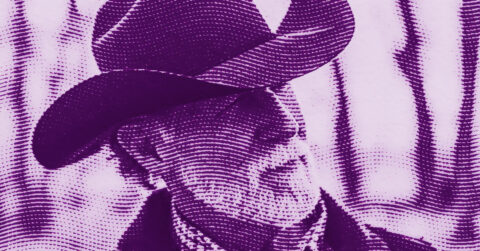Ascoltatemi bene, banda di snob, è giunto il momento di parlare di Wilhelm Sasnal, nato nel 1972 a Tarnów in Polonia, questo artista che ci tiene con il fiato sospeso da più di vent’anni con le sue opere che oscillano costantemente tra il sublime e il banale, tra la grande Storia e il quotidiano più triviale. Non è un semplice pittore che riproduce meccanicamente immagini raccolte qua e là. No, Sasnal è un osservatore meticoloso della nostra epoca, un archivista visivo ossessivo che analizza il nostro rapporto con le immagini con precisione chirurgica.
La prima cosa che colpisce nella sua opera è questo modo unico che ha di trasformare immagini apparentemente banali in veri e propri manifesti visivi. Prendete, per esempio, le sue serie sulle chiese polacche dipinte a rovescio, come “Kirche” (2001). Questi dipinti non sono semplici esercizi formali, incarnano perfettamente quello che Friedrich Nietzsche chiamava il “rovesciamento dei valori”. In una Polonia post-comunista dove la Chiesa cattolica continua ad esercitare un’influenza considerevole sulla vita quotidiana, Sasnal ci obbliga a guardare questi simboli religiosi da una prospettiva letteralmente invertita. Queste chiese capovolte diventano potenti metafore del nostro rapporto ambiguo con il sacro in un mondo desacralizzato. E non pensate neanche per un attimo che ciò sia gratuito o provocatorio, ogni pennellata è calcolata per farci riflettere sul nostro complesso rapporto con le istituzioni religiose e il loro potere simbolico.
Ma aspettate, questa è solo la punta dell’iceberg. Ciò che rende l’opera di Sasnal veramente interessante è la sua capacità di intrecciare la storia personale e collettiva. Non dipinge la Storia con la S maiuscola in modo didattico o moralistico. No, la fa emergere nei dettagli più anodini, come nei suoi dipinti ispirati al fumetto “Maus” di Art Spiegelman. Nel 2001, quando si appropria di queste immagini, non è per dare un’ennesima rappresentazione dell’Olocausto, ma per interrogarsi sul modo in cui questa tragedia continua a infestare il nostro presente. Walter Benjamin parlava della “storia al contrario”, è esattamente ciò che fa Sasnal: gratta la superficie liscia del nostro presente per rivelare le cicatrici del passato che persistono sotto la nostra coscienza collettiva. Queste opere non sono semplici citazioni o appropriazioni, sono atti di resistenza contro l’oblio, contro la tentazione di voltare pagina troppo rapidamente sulle pagine oscure della nostra storia.
La tecnica pittorica di Sasnal è altrettanto rivelatrice quanto i suoi soggetti. Maneggia la pittura come un DJ miscela i suoi campioni: a volte con una precisione fotografica clinica, a volte con gesti espressionisti scatenati. Questo approccio ricorda ciò che Roland Barthes chiamava il “piacere del testo”, solo che qui è il piacere dell’immagine a essere in gioco. Sasnal gioca costantemente con le nostre aspettative visive, creando dipinti che sembrano familiari a prima vista ma che si rivelano stranamente inquietanti man mano che li osserviamo. La sua tavolozza cromatica, spesso ristretta, non è una scelta estetica superficiale ma una decisione concettuale profonda. I grigi, i marroni, i neri che dominano le sue tele non sono lì per essere carini, ma per ricordarci la materialità stessa della pittura, la sua capacità di trasformare la realtà in qualcosa di più ambiguo, di più inquietante.
E parliamo di questa ambiguità. Prendete i suoi ritratti politici, come quelli di Marine Le Pen (2012) o Angela Merkel (2016). Non sono semplici rappresentazioni di figure pubbliche, ma studi psicologici profondi sul potere e la sua immagine mediatica. Sasnal li dipinge come spettri, apparizioni fantasmatiche che infestano il nostro paesaggio politico contemporaneo. Questi ritratti riecheggiano ciò che Michel Foucault descriveva come il “potere pastorale”, quella forma di governo che pretende di prendersi cura del proprio gregge mentre esercita su di esso un controllo assoluto. Ogni pennellata è un’analisi politica, ogni sfumatura di colore è un commento sulla natura del potere nella nostra società mediatica.
Nelle sue vedute di Tarnów, la sua città natale, o nei suoi dipinti di siti industriali come le fabbriche di Azoty, Sasnal trasforma luoghi ordinari in scene quasi apocalittiche. Questi paesaggi non sono senza ricordare ciò che Jean-François Lyotard chiamava il “sublime contemporaneo”, quella sensazione vertiginosa di fronte all’immensità tecnologica e industriale che ci circonda. Ma a differenza dei romantici che cercavano il sublime nella natura selvaggia, Sasnal lo trova nelle periferie urbane, nelle zone industriali dismesse, nei non-luoghi della nostra modernità tardiva. Dipinge questi spazi con un’attenzione particolare ai dettagli che rivelano la loro storia: le tracce di usura, i segni del tempo, le cicatrici lasciate dall’attività umana. Questi paesaggi sono testimonianze silenziose della trasformazione brutale della Polonia post-comunista, ma anche metafore più ampie del nostro rapporto problematico con l’ambiente nell’era dell’antropocene.
L’altro aspetto della sua opera è il suo rapporto con i media di massa e la cultura popolare. Sasnal non esita a attingere dalle copertine di dischi, dai film, dalle pubblicità o da Internet. Ma attenzione, non si tratta di un semplice riciclo pop art alla Warhol. No, Sasnal usa queste immagini come gli archeologi usano gli artefatti: per comprendere il nostro presente attraverso le sue rappresentazioni più banali. È ciò che Jacques Rancière chiama il “partage du sensible”, quella redistribuzione delle immagini che determina ciò che è visibile e ciò che non lo è nella nostra società. Quando dipinge una scena tratta da un film o un’immagine trovata su Internet, non si limita a riprodurla, la trasforma, la decostruisce, la re-inventa per farci vedere ciò che si nasconde dietro la sua superficie apparentemente anonima.
Nei suoi film, realizzati spesso in collaborazione con sua moglie Anka, come “It Looks Pretty from a Distance” (2011), Sasnal spinge ancora più lontano questa esplorazione del nostro rapporto con le immagini. Queste opere cinematografiche non sono semplici estensioni della sua pratica pittorica, ma meditazioni profonde sulla natura stessa della rappresentazione. Utilizzando spesso attori non professionisti e filmando scene apparentemente banali con un’intensità quasi insostenibile, crea ciò che Gilles Deleuze chiamava “immagini-tempo”, immagini che ci costringono a pensare il tempo stesso. I suoi film sono esperienze visive radicali che mettono in discussione le nostre abitudini di spettatori e il nostro modo di consumare le immagini.
Il suo lavoro sulla memoria collettiva è particolarmente toccante. Quando affronta temi come l’Olocausto o il comunismo, non lo fa mai in modo diretto o illustrativo. Al contrario, trova angolazioni oblique, approcci indiretti che rendono questi temi ancora più presenti nella loro apparente assenza. È ciò che lo storico Pierre Nora chiamava i “luoghi della memoria”, quei punti di cristallizzazione della nostra memoria collettiva. Sasnal comprende che alcune realtà storiche sono troppo complesse, troppo dolorose per essere rappresentate direttamente. Sceglie quindi di avvicinarsi a esse per la periferia, creando opere che funzionano come echi, riverberi di questi traumi storici.
Ciò che è particolarmente notevole in Sasnal è che mantiene una coerenza concettuale pur variando costantemente i suoi approcci stilistici. Può passare da un dipinto iperrealista a un’astrazione gestuale senza mai perdere il filo conduttore della sua riflessione sull’immagine. Questa versatilità non è incoerenza, ma piuttosto ciò che il filosofo Theodor Adorno chiamava la “non-identità”, questa capacità di resistere a qualsiasi categorizzazione definitiva. Ogni nuova serie, ogni nuovo progetto è un’esplorazione diversa del nostro rapporto con le immagini, la storia, la memoria.
La sua pratica pittorica è profondamente contemporanea, non perché segue mode o tendenze, ma perché interroga costantemente cosa significhi dipingere oggi. In un mondo saturo di immagini digitali, dove fotografia e video sono onnipresenti, Sasnal riafferma la rilevanza della pittura non come una pratica nostalgica o reazionaria, ma come un mezzo unico per interrogare il nostro rapporto con il visibile. Ogni quadro è una proposta su cosa può essere la pittura nel XXI secolo.
Le sue opere più recenti, esposte in particolare alla Whitechapel Gallery e da Hauser & Wirth, mostrano un artista al culmine della sua maturità che continua però a correre rischi. Non esita ad affrontare temi scottanti come la crisi dei rifugiati o la crescita dei populismi in Europa, ma sempre con quella distanza critica che caratterizza il suo lavoro sin dall’inizio. Queste opere ci ricordano ciò che diceva Hannah Arendt sulla “banalità del male”, come le più grandi tragedie possano emergere dalle situazioni più ordinarie. Sasnal ci mostra che l’arte contemporanea può ancora essere politicamente impegnata senza cadere nel didatticismo o nella propaganda.
Sasnal ci fa vedere l’incredibile nell’ordinario, il politico nel personale, lo storico nel quotidiano. Non cerca di darci risposte facili o giudizi morali già fatti. Al contrario, ci costringe a mettere in discussione la nostra stessa posizione di spettatori, la nostra stessa complicità nei sistemi di rappresentazione che mette in scena. È ciò che Jacques Derrida chiamava la “decostruzione”, quel processo costante di mettere in discussione le nostre certezze più fondamentali. Ogni quadro è un invito a ripensare il nostro rapporto con le immagini, la storia, la memoria.
L’importanza del suo lavoro va ben oltre il quadro dell’arte contemporanea polacca o anche europea. Sasnal è riuscito a creare un linguaggio visivo che parla in modo universale pur restando profondamente radicato nel suo contesto culturale e storico specifico. È ciò che il filosofo Paul Ricoeur chiamava il “paradosso dell’universale e del particolare”, come un’esperienza singolare possa acquisire una portata universale. Le sue opere parlano della Polonia post-comunista, ma anche della nostra condizione contemporanea globale, delle nostre ansie collettive, delle nostre speranze e paure.
Wilhelm Sasnal è molto più di un semplice pittore talentuoso, è un vero e proprio filosofo dell’immagine, un pensatore che usa la pittura come strumento di indagine del reale. Quando tutto sembra già stato mostrato, fotografato, filmato, riesce ancora a sorprenderci, a destabilizzarci, a farci vedere in modo diverso. La sua opera ci ricorda che l’arte non è qui per confortarci nelle nostre certezze, ma per scuoterle, per costringerci a guardare ciò che a volte preferiremmo non vedere.
Allora sì, banda di snob, Wilhelm Sasnal è forse uno degli artisti più importanti della sua generazione, non perché realizzi “belle” pitture o perché sia quotato sul mercato dell’arte, ma perché ci costringe a ripensare il nostro rapporto con le immagini, la storia, la memoria e il presente. Quando l’immagine nella nostra epoca è diventata allo stesso tempo onnipresente e insignificante, il suo lavoro ci ricorda che la pittura può ancora essere uno strumento critico potente, un mezzo di resistenza contro la banalizzazione generalizzata della nostra esperienza visiva. Sasnal ci mostra che è ancora possibile creare immagini che contano, immagini che ci costringono a pensare, a sentire, a ricordare. E questa è forse la sua più grande riuscita: aver restituito alla pittura la capacità di commuoverci e farci riflettere, in un mondo che sembra aver perso la capacità di fare l’uno e l’altro.