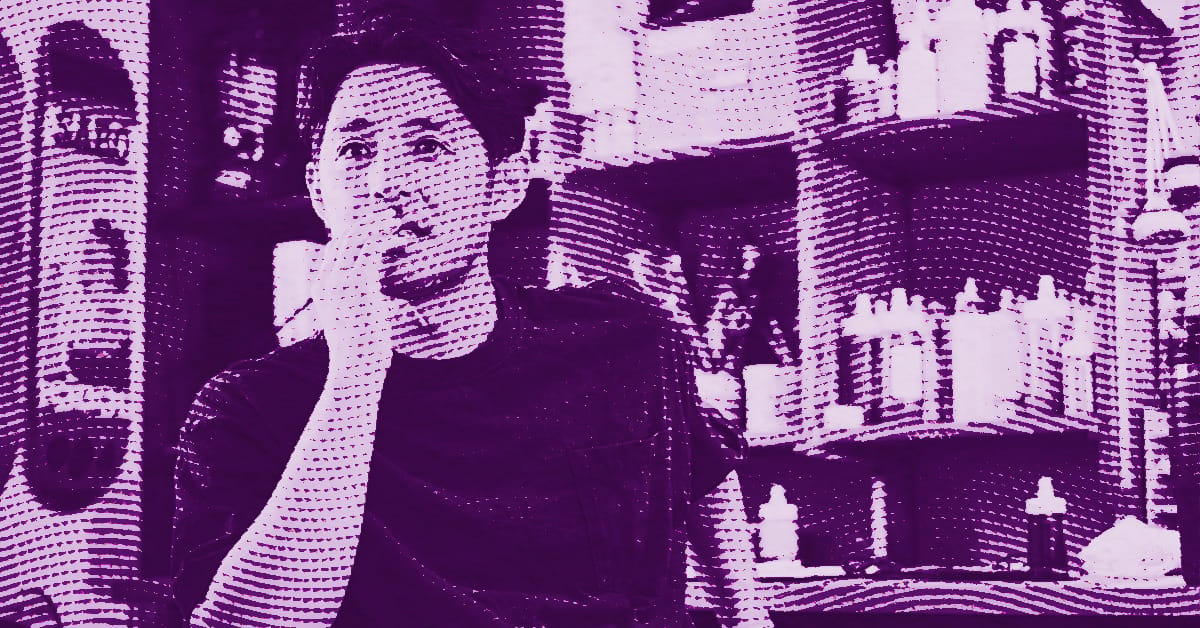Ascoltatemi bene, banda di snob, vi parlerò di Yusuke Hanai, nato nel 1978, questo artista giapponese che disegna personaggi depressi come se fosse il nuovo Charles Schulz sotto acido. Sapete, quelle figure malinconiche dalle proporzioni strane che invadono le nostre gallerie con la loro presunta profondità esistenziale?
Iniziamo con la sua prima ossessione: questa fissazione morbosa per la controcultura americana degli anni ’60. Hanai si presenta come l’erede spirituale di Rick Griffin, ma il suo lavoro non è che una pallida copia nostalgica di un’epoca che non ha nemmeno vissuto. È come se Sartre avesse tentato di filosofare sulla Rivoluzione francese, si può teorizzare quanto si vuole, ma l’autenticità dell’esperienza manca crudelmente. I suoi personaggi con sguardi vuoti, presi a incarnare lo spirito beat di Kerouac, non sono che caricature superficiali di una controcultura che fantasia dal suo Giappone natale.
Questa appropriazione culturale a buon mercato mi ricorda quei ristoranti sushi gestiti da californiani che non hanno mai messo piede in Giappone. La differenza? Almeno il cibo non pretende di essere autentico. Il che mi porta alla sua seconda ossessione: questa pseudo-celebrazione delle “persone comuni” attraverso i suoi personaggi malinconici.
Le sue figure barbute e depresse dovrebbero rappresentare l’umanità in tutta la sua vulnerabilità, ma non sono che una collezione di cliché visivi riciclati. È come se Camus avesse deciso di disegnare L’Étranger a fumetti, con soltanto personaggi che sembrano surfisti depressi. Walter Benjamin ci aveva avvertito della perdita di autenticità nell’era della riproduzione meccanica, ma Hanai spinge il concetto ancora più avanti: riproduce meccanicamente la malinconia stessa.
Ciò che è particolarmente irritante è questo modo che ha di servirci sempre la stessa minestra emotiva in ogni opera. I suoi personaggi con le spalle cadenti e gli sguardi persi sono diventati la sua firma, come se la tristezza fosse un prodotto da commercializzare in serie. Roland Barthes avrebbe avuto molto da dire su questa mitologia moderna del “looser cool”. È diventato un marchio prevedibile quanto le zuppe Campbell’s di Warhol, ma senza l’ironia critica che rendeva queste ultime interessanti.
E non fatemi parlare delle sue collaborazioni con marchi di streetwear. Theodor Adorno si rivolterebbe nella tomba vedendo come la malinconia è diventata un accessorio di moda, un motivo decorativo per felpe con cappuccio vendute a 250 euro. La controcultura, che dovrebbe essere una forma di resistenza, è ridotta a un semplice esercizio di stile, un’estetica Instagram-friendly per millennial in cerca di senso.
La tecnica? Certo, c’è. Hanai domina il suo tratto, glielo concedo. Ma è come avere una bella calligrafia per non dire nulla di interessante. Le sue composizioni sono efficaci, le sue linee sicure, ma tutto ciò è al servizio di una visione del mondo profonda quanto una pozza d’acqua sulla spiaggia di Malibu. Michel Foucault ci ha insegnato a cercare le strutture di potere nascoste dietro le rappresentazioni culturali. In Hanai, queste strutture sono così evidenti da risultare imbarazzanti: il male gaze onnipresente, la fetishizzazione della malinconia, la commercializzazione della controcultura.
Le sue esposizioni sembrano installazioni di merchandising di alta gamma, dove ogni opera è calibrata per piacere a un pubblico che confonde profondità con depressione stilizzata. È l’equivalente artistico di un album dei Radiohead ascoltato in loop da un adolescente che ha appena scoperto l’esistenzialismo, forse toccante, ma fondamentalmente superficiale.
La cosa più frustrante è che Hanai ha talento. Lo si vede in alcuni dettagli, nel modo in cui cattura la tensione di un corpo, nelle sue composizioni che, a volte, raggiungono una vera potenza evocativa. Ma sembra essersi rinchiuso nella propria mitologia, prigioniero di uno stile che è diventato la sua prigione dorata. Guy Debord ci aveva avvertiti: la società dello spettacolo trasforma tutto in merce, persino la malinconia, persino la ribellione.
Non posso fare a meno di pensare a cosa avrebbe detto Jean Baudrillard su tutto questo. In questo simulacro di controcultura, dove la tristezza è un filtro Instagram e la ribellione un motivo per una t-shirt, Hanai è diventato l’artista perfetto del nostro tempo, non perché la critichi, ma perché la incarna perfettamente, con tutte le sue contraddizioni e superficialità.
I suoi personaggi guardano sempre verso il basso o lontano, come se cercassero disperatamente un senso che sfugge loro. Forse è l’unica cosa autentica nel suo lavoro: questa ricerca perpetua di una profondità che rimane sfuggente. Ma a forza di riciclare le stesse pose, le stesse espressioni, le stesse atmosfere, Hanai ha trasformato questa ricerca esistenziale in una formula di marketing tanto prevedibile quanto le onde che ama tanto disegnare.
Il problema non è che Hanai sia un cattivo artista, non lo è. Il problema è che è diventato esattamente ciò contro cui la controcultura che tanto venera lottava: un produttore di contenuti calibrati, di malinconia preconfezionata, di ribellione pronta da indossare. Se i beatnik che ammira tanto potessero vedere come il loro patrimonio è stato trasformato in merce di lusso, probabilmente piangerebbero, non per quella tristezza elegante che Hanai ama tanto rappresentare, ma per un vero sconforto di fronte al recupero della loro lotta.
E mentre contempliamo le sue opere in gallerie climatizzate, sorseggiando champagne in un calice di cristallo, partecipiamo tutti a questa grande mascherata. Applaudiamo la trasformazione della malinconia in prodotto di consumo, della controcultura in accessorio di moda. Forse questa è, in fondo, la vera tristezza nell’arte di Hanai: non quella che disegna, ma quella che rappresenta nonostante sé, la tragedia di un’epoca in cui persino la ribellione è diventata un marchio registrato.
Pierre Bourdieu avrebbe probabilmente visto nel successo di Hanai una perfetta illustrazione della distinzione sociale tramite il capitale culturale. Le sue opere sono diventate simboli di status per una certa borghesia che vuole apparire contemporaneamente coltivata e ribelle, sensibile e cool. È l’equivalente artistico di un’auto ibrida di lusso, un prodotto che permette di mostrare la propria coscienza sociale restando comodamente installati nei propri privilegi.
E sapete qual è la cosa più ironica di tutto ciò? Mentre discutiamo della profondità o meno della sua arte nei nostri circoli privilegiati, le sue immagini vengono riprodotte all’infinito sui social network, trasformate in meme, sfondi, avatar e persino miserabili NFT. La riproduzione meccanica di cui parlava Benjamin è diventata riproduzione digitale, e la perdita di aura si è trasformata in guadagno di follower. I suoi personaggi tristi sono diventati emoji esistenziali per una generazione che confonde malinconia e filtro in bianco e nero.
A volte mi chiedo se Hanai sia consapevole di tutto ciò, se ride sotto i baffi vedendo come la sua arte sia diventata esattamente ciò che pretende di criticare. O forse è sincero nel suo percorso, anch’egli prigioniero di questo sistema che alimenta mentre vuole denunciarlo. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: un’arte che si morde la coda, che gira in tondo in una spirale di auto-referenzialità senza fine.
Allora sì, andate a vedere le sue mostre, acquistate le sue stampe, indossate le sue t-shirt. Ma non venite a dirmi che è arte sovversiva, che è una critica sociale profonda. È design emotivo di alta gamma, marketing esistenziale, ribellione in edizione limitata. E forse è esattamente quello che meritiamo: un’arte che riflette perfettamente la nostra epoca, non in ciò che denuncia, ma in ciò che è diventata.