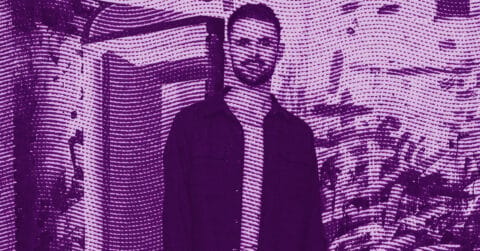Ascoltatemi bene, banda di snob: sta succedendo qualcosa di autentico nello studio di Zhang Nan, e merita attenzione con la rigorosità critica dovuta agli artisti che rifiutano le facilità. Questa giovane pittrice cinese, diplomata all’ENSAD Nancy nel giugno 2025 e che si può scoprire questa settimana alla Luxembourg Art Week 2025 grazie all’Institut Français du Luxembourg e all’Associazione Victor Hugo, propone con la sua serie Brothers una meditazione pittorica sulla violenza e l’assurdo che va ben oltre il semplice esercizio accademico.
Quando Zhang Nan afferma di aver riletto Au bord de l’eau prima di concepire questa serie, non parla di un’ispirazione superficiale, ma di un vero confronto con uno dei testi fondatori dell’immaginario cinese. Questo romanzo classico del XIV secolo, attribuito a Shi Nai’an, racconta le peripezie di centootto banditi riuniti intorno a una palude per sfidare un impero corrotto [1]. Ma Zhang Nan non cerca di illustrare il racconto. Ne estrae ciò che lei stessa definisce “una certa intensità, una violenza cruda, spesso inconscia”, respingendo deliberatamente i marcatori storici per raggiungere qualcosa di più essenziale. Questa decisione estetica non è casuale: colloca il suo lavoro in una genealogia che privilegia l’espressione della condizione umana rispetto alla ricostruzione documentaria.
Ciò che colpisce all’istante nella sua serie Brothers è la capacità dell’artista di mantenere un equilibrio precario tra narrazione e astrazione. Le tele di grande formato, oli su tela di 160 x 120 centimetri, evocano scene di omicidio e crudeltà tratte dal romanzo classico, ma Zhang Nan rifiuta sistematicamente lo spettacolare. “Ho volutamente evitato immagini sanguinanti, ad esempio cambiando il colore del sangue”, spiega. Questa strategia di svuotamento cromatico non è una pudicizia mal riposta, ma un rifiuto categorico della compiacenza nell’orrore. L’artista non vuole che lo spettatore sia “distratto da uno choc visivo diretto”, perché ciò che le interessa non è la violenza in quanto tale, ma ciò che essa rivela dell’assurdità umana.
È proprio qui che la sua parentela con Max Beckmann prende tutto il suo senso. L’artista tedesco, esiliato ad Amsterdam e poi negli Stati Uniti, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a dipingere trittici monumentali che mescolavano allegoria personale e commento sulla condizione umana in un secolo lacerato dalle guerre. Opere come Départ (1933-1935), Les Acteurs (1941-1942) o Le Carnaval (1942-1943) testimoniano un’ossessione per la rappresentazione di un’umanità compressa in spazi claustrofobici, dove la violenza convive con una forma di dignità tragica [2]. Beckmann scriveva nel 1918: “Cerco di catturare il terribile mostro palpitante della vitalità della vita e di confinarlo, sottometterlo e strangolarlo con linee cristalline e piani taglienti come un rasoio” [3]. Questa tensione tra la cattura dell’energia vitale e la sua messa in forma rigorosa risuona profondamente con il progetto di Zhang Nan.
Ma attenzione: non si tratta di un semplice pastiche. Dove Beckmann dispiegava le sue composizioni in trittici, giocando sugli echi formali e simbolici tra i pannelli laterali e il pannello centrale, Zhang Nan sceglie deliberatamente di frammentare la narrazione in tele autonome che rifiutano qualsiasi ordine fisso. “Questa serie non ha un ordine fisso”, insiste, “i numeri nei titoli corrispondono solo all’ordine di realizzazione”. Questa decisione di rifiutare la gerarchia narrativa pone lo spettatore in una posizione scomoda: di fronte a queste scene di violenza senza contesto preciso, senza riferimenti storici identificabili, siamo costretti a cercare il senso altrove rispetto alla sequenza cronologica degli eventi.
Le figure dipinte da Zhang Nan sono corpi in crisi, anatomie deformate che portano la traccia di un’educazione accademica rigorosa, ha seguito la sua formazione iniziale all’Accademia di Belle Arti di Xi’an, ma che sono state sottoposte a un processo di decostruzione radicale. “Mi è anche capitato di pensare di abbandonare gli studi d’arte”, confida. Questo periodo di dubbio ha prodotto una rottura feconda: invece di riprodurre l’anatomia reale, Zhang Nan ricostruisce “un’altra forma di struttura mediante la pittura, una struttura che non si basa sull’apparenza esteriore, ma sull’interiorità”. I corpi che dipinge quindi non sono errori o approssimazioni, ma costruzioni intenzionali che cercano di rendere visibile ciò che solitamente rimane nascosto.
Il riferimento a Francis Bacon, che lei stessa menziona nella sua dichiarazione d’artista, non è casuale. Come il pittore irlandese, Zhang Nan cerca di “cogliere una nuova forma di realtà in un’epoca segnata dal dominio dell’immagine fotografica”. Ma anche in questo caso, bisogna evitare assimilazioni troppo rapide. Se Bacon si interessava alla deformazione come mezzo per rivelare la verità della carne, Zhang Nan lavora la deformazione come strumento di depersonalizzazione. Cancellando “volontariamente alcuni marcatori come l’età, l’origine o anche talvolta il genere”, crea figure che aspirano a una forma di universalità. Paradossalmente, è spogliandole dei loro attributi individuali che le rende capaci di “entrare in risonanza con una diversità di sguardi e di storie personali”.
Questa ambizione di universalità potrebbe sembrare ingenua o presuntuosa se non fosse sostenuta da una coscienza acuta dei propri limiti e contraddizioni. Zhang Nan non pretende di aver trovato una formula definitiva; esplora, tentenna, costruisce il suo linguaggio visivo lungo le tele. La serie Brothers resta infatti incompiuta, in continua espansione, il che testimonia una maturità artistica notevole per un’artista neolaureata. Comprende che alcune questioni non possono essere risolte, solo riformulate con sempre maggiore precisione.
La scelta di stabilirsi a Berlino dopo i suoi studi all’ENSAD Nancy merita di essere approfondita. Questa città, con la sua storia tormentata e la sua posizione attuale di crocevia artistico europeo, offre un contesto particolarmente favorevole per un’artista che lavora sulla memoria, la violenza e l’identità. Lungi dall’essere una semplice decisione pratica, questa scelta geografica si inserisce in una logica coerente: Zhang Nan si posiziona deliberatamente in uno spazio culturale che valorizza la sperimentazione e il dialogo critico. “Mi sento più affine al contesto artistico europeo”, spiega, “più ricco, più diversificato e più favorevole alla sperimentazione e al dialogo”.
C’è qualcosa di profondamente onesto nell’approccio di Zhang Nan. Lei non pretende di risolvere le tensioni che esplora; le espone con una franchezza che può a volte risultare sconcertante. I suoi dipinti non sono confortevoli. Non offrono una catarsi facile né una risoluzione narrativa soddisfacente. Ci confrontano con una visione dell’umanità in cui la lealtà e la fraternità, questi valori celebrati in superficie da Au bord de l’eau, coesistono con una violenza primordiale e un assurdo congenito. È proprio questa ambivalenza che dà forza al suo lavoro.
Si potrebbe rimproverare a Zhang Nan una certa pesantezza nel trattamento dei suoi soggetti, una tendenza all’enfasi che a volte appesantisce la composizione. Alcune tele della serie Brothers sembrano esitare tra il desiderio di chiarezza formale e la tentazione del pathos espressionista. Ma questi squilibri fanno parte del processo. Questa artista non ha ancora raggiunto la fine del suo percorso; sta costruendo qualcosa, tela dopo tela, errore dopo errore, ed è proprio questo che rende il suo lavoro appassionante da seguire.
Ciò che rende singolare Zhang Nan nel panorama artistico contemporaneo è la sua capacità di articolare più eredità senza gerarchizzarle né opporle artificialmente. Ella attinge dalla letteratura classica cinese con la stessa naturalezza con cui fa riferimento all’espressionismo tedesco, e questa doppia appartenenza non è mai vissuta come una contraddizione. Al contrario, è proprio in questo intermedio, in questa zona di attrito produttivo tra le tradizioni, che il suo lavoro trova la sua voce più autentica.
Quando si osserva l’allestimento che ha proposto per la sua laurea, tre tele della serie Brothers disposte fianco a fianco, si comprende immediatamente la sua padronanza dello spazio espositivo. I dipinti dialogano senza spiegarsi reciprocamente, creando una tensione formale e cromatica che amplifica l’impatto di ogni singola opera. Questa intelligenza della disposizione nello spazio, questa comprensione intuitiva del modo in cui i dipinti interagiscono tra loro, è il segno di un’artista che pensa il suo lavoro oltre il semplice gesto pittorico.
Zhang Nan appartiene a quella generazione di artisti che rifiutano le facilità del commento sociale esplicito senza tuttavia rifugiarsi nell’astrazione pura. Ella mantiene un legame con la figurazione, ma una figurazione costantemente messa in crisi, interrogata, destabilizzata. I suoi personaggi non sono né eroi né vittime; sono presenze ambigue che portano in sé tutta la complessità e tutta l’assurdità della condizione umana.
Sarebbe prematuro prevedere dove la condurrà questa ricerca. Ma una cosa è certa: con la serie Brothers, Zhang Nan ha posto le basi di un linguaggio pittorico che merita di essere seguito con attenzione. Il suo lavoro non rivoluziona la pittura figurativa, e non è questa la sua ambizione, ma vi apporta una voce singolare, una prospettiva che arricchisce la nostra comprensione di ciò che può essere la pittura oggi. In un mondo saturo di immagini, Zhang Nan ci ricorda che la pittura a olio, questa tecnologia ancestrale, possiede ancora risorse inesplorate per confrontarci con ciò che ci costituisce e ci disturba.
Di fronte ai suoi dipinti, non si esce indenni. Non si parte consolati. Ma si parte con delle domande, ed è precisamente questo che ci si può aspettare da un’arte che rifiuta i compromessi. Zhang Nan non ci offre risposte. Ci tende uno specchio deformante nel quale possiamo, se accettiamo di guardare davvero, scorgere qualcosa della nostra stessa violenza, del nostro stesso assurdo, della nostra stessa umanità. È già molto. È forse anche l’essenziale.
- Shi Nai’an, Ai margini dell’acqua, traduzione Jacques Dars, Gallimard, collezione La Pléiade, 1978
- Stephan Lackner, Max Beckmann 1884-1950 Die Neun Triptychen, Safari-Verlag, Berlino, 1965
- Max Beckmann, “Una confessione”, 1918, citato in Carla Hoffmann-Schulz e Judith C. Weitz, Max Beckmann: Retrospective, St. Louis Art Museum e Prestel-Verlag, 1984