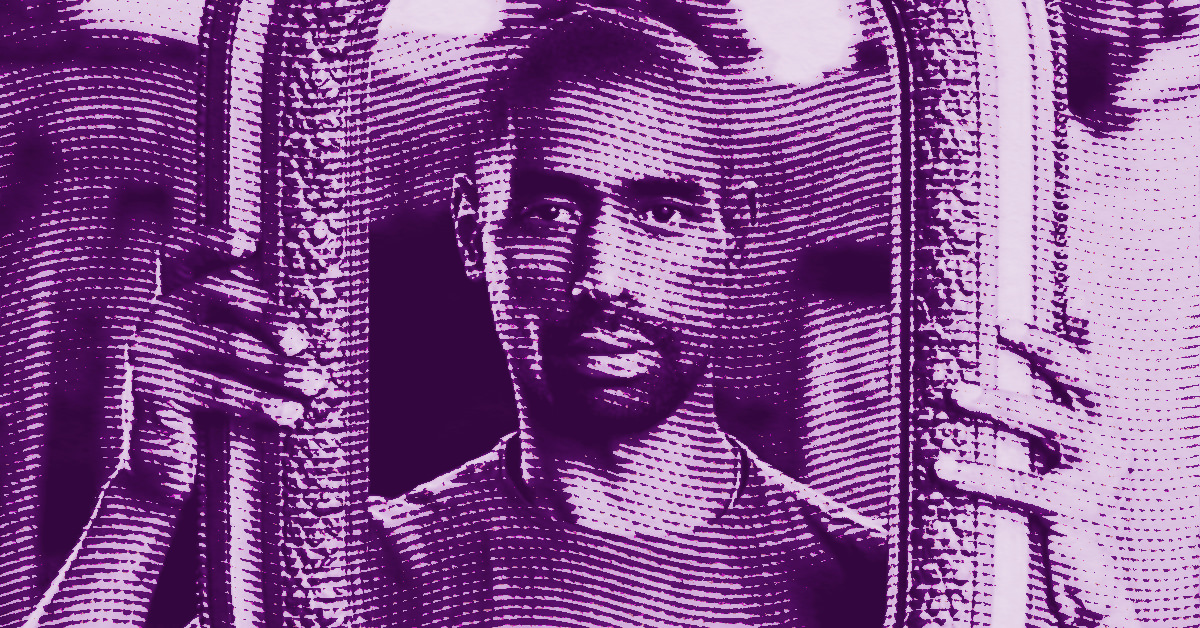Ascoltatemi bene, banda di snob: mentre vi inebriate delle vostre certezze estetiche e delle vostre classificazioni binarie, un uomo nato nella periferia di Brasília sconvolge silenziosamente i codici della rappresentazione contemporanea. Antonio Obá, figlio di un fattorino del gas e di una cuoca, nato nel 1983 a Ceilândia, non cerca di piacere al mercato dell’arte internazionale. Cerca di riconciliare i corpi feriti con la loro memoria. E credetemi, questa ambizione vale più di tutte le vostre speculazioni sull’ultimo genio newyorkese del momento.
Formatosi nelle arti visive dopo un breve passaggio nella pubblicità, Obá ha insegnato disegno per venti anni prima di dedicarsi interamente alla sua pratica artistica. Questo percorso non è casuale: testimonia una pazienza, una maturazione lenta, un rifiuto della fretta carriera. Vincitore del premio PIPA nel 2017, presente nelle collezioni della Tate Modern, della Fondation Pinault e del Museo Reina Sofía, l’artista brasiliano costruisce un’opera dove pittura, scultura, installazione e performance dialogano con un’intensità rara. Ma ciò che colpisce subito nel suo lavoro è questa capacità di evocare simultaneamente il dolore storico e la speranza spirituale, senza mai cadere nel patetismo facile.
La capoeira come grammatica della resistenza
Per comprendere l’approccio di Antonio Obá, bisogna prima capire cosa rappresenta la capoeira nell’immaginario afro-brasiliano. Quest’arte marziale mascherata da danza costituisce una delle invenzioni più brillanti della resistenza schiavista. I corpi incatenati degli schiavi hanno saputo creare un linguaggio di combattimento che sfuggiva alla sorveglianza dei padroni nascondendosi sotto le apparenze di una semplice coreografia festosa. Questa duplicità fondante, questa capacità di trasformare l’oppressione in movimento creativo, permea tutta la pratica di Obá.
La capoeira non è solo un riferimento culturale nella sua opera: ne costituisce il principio strutturale. Come i capoeiristi che si muovono nel cerchio senza mai toccarsi, mantenendo una tensione permanente tra attacco potenziale e ritiro strategico, Obá costruisce i suoi dipinti in un equilibrio precario tra violenza e grazia. I suoi personaggi addormentati o come sotto l’effetto di un incantesimo incarnano questa sospensione, quel momento prima del movimento in cui tutte le possibilità rimangono aperte. Sono morti, sognano, meditano? L’artista rifiuta di decidere, mantenendo lo spettatore in questa incertezza feconda che caratterizza appunto la roda, questo cerchio di capoeira.
Lo storico della danza potrebbe vederci un’appropriazione dei codici della performance contemporanea. Sarebbe però perdere di vista l’essenziale: Obá non performa per il white cube occidentale, attualizza una tradizione di resistenza corporea che risale ai fondi delle navi negriere. Quando nel 2016 realizza questa performance scandalosa in cui raschia una scultura della Vergine Maria in cera bianca e si copre il corpo con questa polvere, non si tratta di una provocazione gratuita. Compie un gesto di capoeira spirituale: trasformare l’immagine della dominazione coloniale in ornamento identitario, rovesciare il simbolo dell’oppressione religiosa in materiale di riappropriazione corporea.
Questa performance gli valse un tale scatenarsi di odio in Brasile che fu costretto a esiliarsi per diversi mesi a Bruxelles. Ma anche qui, il parallelo con la capoeira è evidente: la schivata non è fuga, è un riposizionamento tattico. Il corpo nero impara molto presto che deve navigare tra i colpi, anticipare la violenza, calcolare i suoi movimenti per sopravvivere. Obá trasforma questa necessità storica in metodo artistico. Le sue opere non sono mai frontali: aggirano, suggeriscono, spostano. Danzano attorno al loro soggetto piuttosto che affrontarlo direttamente.
Nei suoi dipinti recenti, i personaggi sembrano fluttuare in uno spazio indeterminato, i loro corpi sono disegnati con quella precisione che tradisce anni di osservazione e pratica del disegno accademico. Ma questa maestria tecnica è immediatamente sovvertita dall’introduzione di elementi perturbatori: dei búzios (coni di mare) al posto degli occhi, rami spogli che evocano le impiccagioni degli schiavi, animali simbolici come corvi o scimmie. Queste intrusioni rompono l’armonia classica della composizione, vi introducono una dissonanza che ricorda i colpi di berimbau, quel singolo strumento a corda brasiliano che scandisce il ritmo di una roda di capoeira. Lo sguardo non può riposare: deve costantemente adattarsi, anticipare, interpretare.
Quell’estetica della tensione permanente trova la sua espressione più compiuta nelle installazioni di Obá. I suoi oratori composti da ex-voto, campane in ottone e oggetti trovati creano spazi dove il sacro non si concede mai del tutto. Come nella capoeira, dove la finta fa parte integrante del gioco, queste installazioni promettono una rivelazione spirituale che non donano mai completamente. Il visitatore deve negoziare la sua relazione con l’opera, trovare la propria posizione, compiere il proprio movimento di ginga, quel dondolio caratteristico della capoeira che mantiene il corpo in stato di allerta permanente.
Il sincretismo critico e la tradizione pittorica
Ma ridurre Obá alla sua brasilianità sarebbe un’offesa. Quest’artista conosce perfettamente la storia della pittura occidentale e dialoga con essa a pari livello. Le sue grandi tele convocano i codici del Rinascimento italiano, i chiaroscuri caravaggeschi, le composizioni monumentali della pittura religiosa europea. Solo che invece di rappresentare santi biondi dagli occhi azzurri, vi colloca corpi neri e meticci, carichi di una spiritualità che rifiuta di scegliere tra il cattolicesimo dei suoi genitori e le tradizioni Yoruba dei suoi antenati.
Quello che alcuni chiamano pigramente “sincretismo”, Obá lo pratica come una critica in atto. I suoi dipinti non fondono ingenuamente diverse tradizioni spirituali: espongono le violenze storiche che hanno reso necessaria questa fusione. Quando rappresenta un giovane in piedi, i capelli coperti di popcorn, con una colomba e un nido a forma di aureola, non si limita a sovrapporre l’iconografia cristiana dello Spirito Santo e il riferimento al dio Omoulou, divinità yoruba associata alle epidemie e ai cimiteri. Mostra come i corpi neri brasiliani hanno dovuto negoziare la loro sopravvivenza adottando i segni del colonizzatore pur preservando segretamente le proprie credenze.
L’artista stesso l’ha espresso con rara precisione: “Lavorare la terra, raccogliere, conoscere le piante dall’odore, dal nome, dal disegno delle foglie, vedere gli animali, catturare galline scappate, aiutare nei lavori domestici, grattugiare il mais per fare la pamonha, camminare in silenzio nella boscaglia… ho già detto ad altre occasioni che sono un po’ rustico e, naturalmente, porto questi aspetti quasi come un’eredità immateriale che mi lega agli esseri scomparsi” [1]. Questa “eredità immateriale” di cui parla non è una nostalgia folkloristica: è un metodo di lavoro, un modo di avvicinarsi alla pittura come si farebbe con una pianta, attraverso il tatto, l’odore, l’intuizione corporea piuttosto che con il concetto astratto.
Obá sceglie inoltre i suoi colori nella tavolozza delle case rurali brasiliane: questi gialli, rosa, blu e verdi sbiaditi ottenuti mescolando acqua, calce e polvere di gesso. Queste tonalità popolari, che il tempo ha reso irregolari, portano con sé una memoria collettiva. Inseriscono i suoi personaggi in una continuità storica che trascende l’individuo per toccare intere collettività. Questa attenzione ai materiali da costruzione, ai pigmenti della vita quotidiana, rivela un artista che rifiuta la separazione modernista tra arte colta e cultura popolare.
Pizzi bianchi che avvolgono i suoi personaggi neri non sono semplici ornamenti decorativi. Evocano i sudari mortuari, le lenzuola dei corpi scomparsi nel traversare l’Atlantico, milioni di africani i cui corpi hanno nutrito i pesci dell’oceano. I búzios che a volte sostituiscono gli occhi delle sue figure non sono solo conchiglie per la divinazione: furono anche usati come moneta, ricordando che i corpi neri sono stati a lungo valutati in base al loro valore commerciale. Ogni elemento iconografico in Obá opera su più livelli, rifiuta una lettura univoca, esige che lo spettatore scavi sotto la superficie.
Questa complessità semiotica non è gratuita. Corrisponde alla realtà di un’identità brasiliana costruita su strati di violenza, meticciato forzato, appropriazioni culturali e resistenze ostinate. Obá non cerca di districare questi fili: li presenta nel loro intreccio, nella loro confusione produttiva. I suoi dipinti sono accumuli stratificati in cui ogni strato di significato ne ricopre e rivela uno altro simultaneamente.
Al contrario degli artisti che si richiamano a un’autenticità africana idealizzata o a una completa assimilazione alle norme occidentali, Obá assume pienamente la sua posizione di via di mezzo. Ha studiato la storia dell’arte europea, padroneggia le tecniche accademiche del disegno e della pittura, conosce le regole della composizione classica. Ma invece di applicarle servilmente, le devia per raccontare storie che questa tradizione non ha mai voluto ascoltare. Usa la grammatica del maestro per parlare la lingua dello schiavo.
In un’intervista recente, Obá ha dichiarato: “La poesia non ha fine. Se ne avesse una, saremmo esseri con una lingua morta” [2]. Questa frase riassume perfettamente il suo approccio artistico: rifiutare la chiusura del significato, mantenere l’opera aperta a molteplici interpretazioni, preservare quel potenziale di vita che caratterizza ogni vera creazione. I suoi dipinti non offrono un messaggio definitivo, pongono domande che ogni spettatore deve risolvere secondo la propria esperienza, la propria storia.
Un’intimità politica
Ciò che distingue Antonio Obá da tanti artisti contemporanei che strumentalizzano le questioni razziali per costruirsi una legittimità di mercato è questa capacità di mantenere l’opera in un registro di intimità pur portando un carico politico innegabile. I suoi quadri non urlano il loro impegno: lo sussurrano, lo suggeriscono, lo incarnano in gesti discreti che risultano ancora più incisivi.
Guardate questo dipinto dove una bambina di quattro anni, uccisa dalla polizia in una favela, sostituisce sant’Antonio in una scena familiare ispirata da una fotografia d’infanzia dell’artista. Questa sostituzione opera un corto circuito temporale vertiginoso: l’innocenza dell’infanzia si scontra con la violenza della polizia, la sfera intima del ricordo personale si carica di una memoria collettiva traumatica, l’iconografia religiosa rivela la sua impotenza di fronte all’ingiustizia sociale. Tutto questo senza una parola di spiegazione, senza uno slogan, senza quell’enfasi militante che indebolisce tante opere impegnate.
Obá lavora nel Cerrado, questa regione di savana del centro-ovest brasiliano, lontano dalle metropoli artistiche. Questa scelta geografica non è casuale: testimonia un rifiuto della centralità, una volontà di pensare dalle margini. Per vent’anni ha insegnato arti visive a giovani svantaggiati, trasmettendo un sapere tecnico pur sviluppando la propria ricerca. Questa pazienza, questa fedeltà a un territorio e a una comunità, si legge in ogni opera. Nulla è precipitoso, nulla è sacrificato all’urgenza del riconoscimento.
I corpi che rappresenta portano il segno di questa durata. Non sono mai nell’azione spettacolare: dormono, sognano, meditano o aspettano. Questa immobilità apparente nasconde una tensione interiore formidabile. Come quelle piante del Cerrado che sviluppano radici immense sotto terra prima di produrre la minima germoglia visibile, i personaggi di Obá sembrano attingere la loro energia da profondità invisibili. Incarnano una resistenza che non passa per la dimostrazione di forza, ma per la perseveranza, la resistenza, la capacità di attraversare il tempo senza rinnegarsi.
L’artista non mitizza il corpo nero. Lo mostra nella sua complessità, nelle sue contraddizioni e nelle sue zone d’ombra. I suoi autoritratti travestiti, poiché molti dei suoi personaggi maschili gli somigliano, non sfociano mai nel narcisismo. Piuttosto interrogano ciò che significa abitare un corpo nero nel Brasile contemporaneo, quel corpo che è allo stesso tempo feticizzato e disprezzato, erotizzato e criminalizzato, celebrato negli stadi di calcio e abbattuto nelle favelas. Obá dipinge questa schizofrenia identitaria con una lucidità che rifiuta ogni facile consolazione.
Ecco perché la sua opera merita di più delle letture riduttive che talvolta le vengono applicate. Obá non è né un semplice etnografo della propria cultura, né un imprenditore identitario abile a negoziare la propria differenza nel mercato dell’arte globale. È un artista nel senso pieno del termine: qualcuno che inventa forme capaci di contenere ed esprimere un’esperienza del mondo irriducibile alle categorie esistenti. Qualcuno che rifiuta di scegliere tra tradizione e modernità, tra locale e universale, tra impegno e poesia.
Le sue opere recenti, esposte al Centre d’Art Contemporain de Genève nel 2024 e poi al Grand Palais nel 2025, confermano questa traiettoria singolare. Mostrano un artista che approfondisce la sua ricerca senza ripetersi, che esplora nuove vie pur restando fedele alle sue preoccupazioni fondamentali. La maturità del suo tratto, la sofisticazione delle sue composizioni, la ricchezza delle sue referenze culturali testimoniano di un creatore entrato nella sua piena potenza.
Eppure, nonostante il riconoscimento internazionale (la Fondation Pinault, la Tate Modern, le biennali), Obá continua a vivere e lavorare a Brasília. Questo rifiuto dell’esilio volontario, questa ostinazione a restare radicato nel suo territorio d’origine, dice qualcosa di essenziale sulla sua concezione dell’arte. Per lui, creare non è un’attività che si eserciterebbe fuori dal contesto, nello spazio neutralizzato e climatizzato delle istituzioni internazionali. È un gesto che si ancora in una geografia precisa, una storia particolare, una rete di relazioni concrete.
Le nuove generazioni di artisti brasiliani lo riconoscono come un anziano che ha aperto strade senza imporle, che ha dimostrato che è possibile conquistare un posto nel mondo dell’arte globale senza rinunciare alla propria singolarità. Questa trasmissione discreta, quasi invisibile, costituisce forse l’aspetto più politico del suo lavoro. In un paese dove le disuguaglianze sociali e razziali rimangono abissali, dove l’accesso all’educazione artistica resta un privilegio di classe, Obá incarna la possibilità di un’altra traiettoria.
Allora sì, potete continuare a speculare sul suo valore sul mercato, a collezionare i suoi dipinti come trofei esotici o a ridurli alla loro dimensione decorativa. Oppure potete accettare di lasciarvi destabilizzare dalla complessità di ciò che essi propongono. Potete acconsentire al disagio di un’opera che rifiuta di rassicurarvi, che non consegna immediatamente le sue chiavi, che esige che siate voi a fare il movimento verso di essa piuttosto che il contrario. Questo è ciò che fanno i grandi artisti: non ci danno ciò che ci aspettiamo, ci costringono a riconfigurare le nostre aspettative.
Antonio Obá appartiene a quella ristretta schiera di creatori che trasformano la necessità biografica in necessità estetica, che fanno della loro posizione marginale non un handicap da compensare ma una prospettiva unica da cui guardare il mondo. La sua opera non fa appelli, non rivendica e non si scusa: esiste, semplicemente, potentemente, incontestabilmente. Ed è proprio questa presenza sovrana, questo rifiuto della supplica così come della spettacolare confrontazione, che ne fa un contributo importante all’arte contemporanea.
- Citazione di Antonio Obá, Mendes Wood DM, São Paulo, disponibile sul sito della galleria Mendes Wood DM.
- Antonio Obá, intervista con Nicolas Trembley, Numéro Magazine, febbraio 2025.