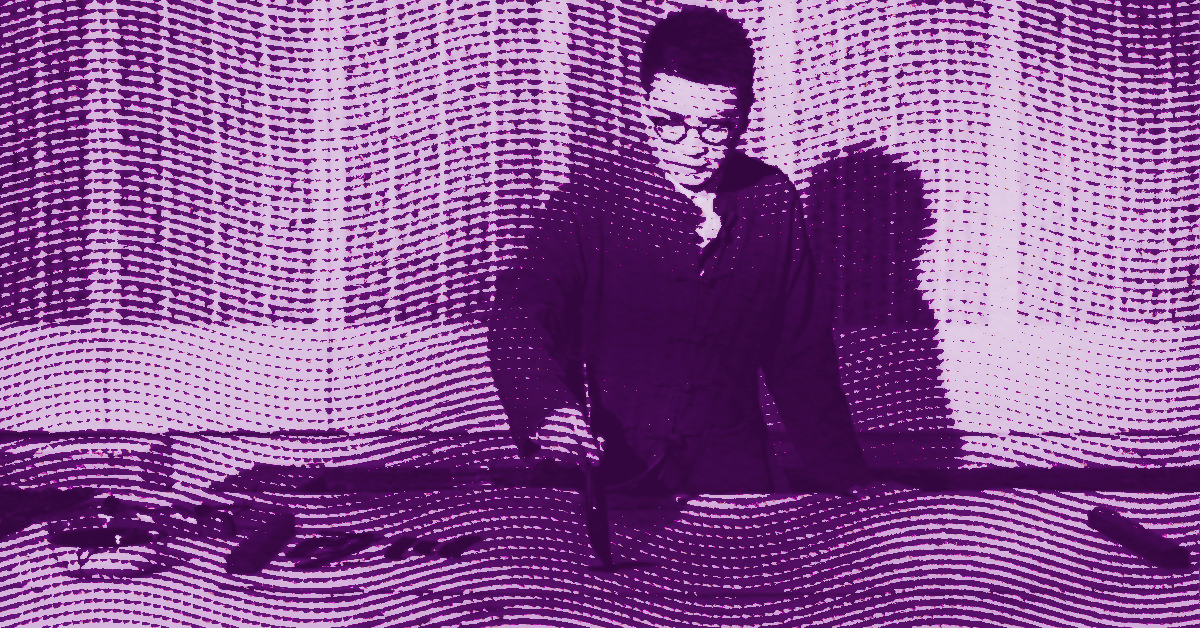Ascoltatemi bene, banda di snob : l’opera di Chen Jia merita molto più di uno sguardo distratto. Questo artista cinese, formato nelle discipline secolari della calligrafia e della pittura di paesaggio, incarna una continuità esigente. Nato nella regione montuosa dell’est del Sichuan, tra le imponenti formazioni dei monti Daba, è cresciuto dove la geografia stessa diventa pedagogia. La sua formazione segue un percorso classico: fin dall’infanzia si dedica alla copia minuziosa dei maestri antichi. Questo approccio del “linmo” costituisce un metodo di indagine approfondita. Riproducendo le composizioni monumentali di Fan Kuan, Chen Jia penetra lo spirito stesso del maestro Song.
L’opera pittorica recente di Chen Jia testimonia una maturità notevole. I suoi paesaggi monumentali in tecnica Xieyi, che usa tratti minimalisti per cogliere l’essenza del soggetto, manifestano una potenza espressiva in cui l’inchiostro scorre con libertà controllata. Il critico Xia Chao nota che alcune composizioni raggiungono “un territorio di spessore arcaico”, qualità rara in un artista della sua generazione. Al di là della sua produzione plastica, Chen Jia si afferma come teorico. Il suo saggio storico sulla calligrafia cinese dimostra una erudizione considerevole.
La calligrafia come danza fissata
Per comprendere appieno la dimensione dell’opera di Chen Jia, è opportuno richiamare le riflessioni di Zong Baihua, il cui libro “Promenade esthétique” resta un riferimento imprescindibile. Zong Baihua propone una lettura singolarmente illuminante quando afferma che la pittura cinese, il teatro e soprattutto la calligrafia condividono una caratteristica comune: sono attraversati dallo spirito della danza [1]. Questa intuizione permette di considerare l’arte di Chen Jia da un’angolazione che ne rivela tutta la profondità coreografica.
La calligrafia, come la pratica Chen Jia, non è una semplice iscrizione di segni. È movimento incarnato, gesto che si dispiega nello spazio e imprime sulla materia il ritmo stesso della vita. Zong Baihua scrive che la calligrafia cinese è “accompagnata dal ritmo musicale della danza”. Quando Chen Jia maneggia il suo pennello carico d’inchiostro, non si limita a scrivere: danza con il suo strumento. Ogni gesto del polso, ogni inflessione del braccio partecipa a una coreografia invisibile di cui resta soltanto la traccia nera sul bianco immacolato della carta. Questa dimensione coreografica della scrittura cinese trova origine nella struttura stessa della lingua.
I caratteri cinesi, al contrario degli alfabeti fonetici occidentali, conservano una dimensione iconica. Sono “azioni disegnate”, dove il movimento che li ha generati resta percepibile. Quando Chen Jia traccia un carattere complesso, l’occhio esperto può ricostruire il balletto del pennello, le sue esitazioni calcolate, le sue accelerazioni controllate. La calligrafia diventa così una danza pietrificata, un movimento catturato nell’istante del suo compimento. L’analogia tra calligrafia e danza si approfondisce ulteriormente se si considera la nozione di spazio. La danza crea uno “spazio spirituale e vuoto” che si dispiega attraverso il movimento del danzatore.
In modo simile, la calligrafia cinese non si limita a riempire la pagina: crea uno spazio dinamico dove il bianco non è mai un semplice sfondo, ma un elemento attivo della composizione. Chen Jia, nelle sue opere calligrafiche come nei suoi dipinti, domina ammirabilmente quest’arte del vuoto. Gli spazi non inchiostrati non sono assenze, ma presenze silenziose, momenti di riposo nella coreografia generale dell’opera. Questa concezione dello spazio trova un’eco particolare nelle arti visive cinesi. Zong Baihua osserva che persino l’architettura cinese, con i suoi tetti dai cornicioni rialzati, esprime un “atteggiamento di danza”. I dipinti di paesaggi monumentali di Chen Jia partecipano alla stessa estetica del movimento sospeso.
L’associazione tra calligrafia e danza illumina anche la questione del tempo nell’arte di Chen Jia. La danza è un’arte del tempo, che si svolge nella durata. La calligrafia, sebbene produca un oggetto permanente, conserva questa dimensione temporale. L’esecuzione di un carattere si inscrive in un tempo irreversibile. Il calligrafo non può tornare indietro: ogni gesto è definitivo. Questa irreversibilità conferisce alla calligrafia la sua tensione drammatica. Chen Jia, quando traccia i suoi grandi formati, gioca con questa temporalità pericolosa. Ogni opera diventa una performance unica, un istante di danza catturato per l’eternità.
La respirazione costituisce un altro punto di convergenza tra danza e calligrafia. Il ballerino ritma il suo movimento sulla respirazione, che diventa visibile nella fluidità dei suoi gesti. Il calligrafo cinese coordina anch’egli il suo tratto con il respiro. Chen Jia, formato alle discipline tradizionali, conosce questa tecnica del “qi”, il soffio vitale, che anima tanto il corpo del danzatore quanto la mano del calligrafo. Nelle sue opere più compiute, si percepisce questa respirazione: i tratti potenti si alternano a passaggi più leggeri, creando un ritmo respiratorio che conferisce all’insieme la sua organicità.
L’arte di Chen Jia manifesta quella qualità che Zong Baihua considera l’essenza stessa dell’arte cinese: la capacità di esprimere il movimento nell’immobilità, di suggerire il flusso temporale nella permanenza dell’oggetto. Le sue montagne sembrano sul punto di muoversi, i suoi caratteri calligrafici vibrano di un’energia contenuta. Questa tensione dinamica colloca la sua opera nella linea dei grandi maestri che hanno compreso che l’arte cinese non è mai statica.
La scrittura del carattere e la forgia del carattere
La seconda dimensione essenziale per comprendere l’opera di Chen Jia risiede nella concezione tradizionale cinese che stabilisce un legame organico tra la pratica della calligrafia e il perfezionamento morale dell’individuo. Questa idea, in particolare sostenuta dal teorico Liu Xizai nel suo trattato “Yigai”, postula che la calligrafia sia l’espressione visibile del carattere profondo di chi scrive [2]. Liu Xizai, critico letterario e calligrafo del XIX secolo, formulò una frase diventata celebre: “La scrittura somiglia alla sua conoscenza, al suo talento, alle sue aspirazioni. In sostanza, somiglia alla persona nella sua interezza”.
Questa affermazione costituisce un principio fondamentale dell’estetica calligrafica cinese. Suggerisce che ogni tratto tracciato riveli qualcosa dell’interiorità del calligrafo. Chen Jia, nutrendosi alle sorgenti di questa tradizione, non potrebbe ignorare questa esigenza etica. Quando si dedica alla copia degli antichi maestri, non cerca solo di acquisire le loro tecniche: tenta di impregnarsi della loro virtù. La calligrafia diventa così un esercizio spirituale, un’ascetismo paragonabile alle pratiche meditative.
Questa concezione etica della calligrafia affonda le radici nella filosofia confuciana, che valorizza l’armonia tra interno ed esterno. Un uomo colto deve assicurarsi che le sue azioni esteriori riflettano fedelmente le sue disposizioni interiori. La calligrafia, arte visibile per eccellenza, diventa così una prova di sincerità. Il tratto rivela implacabilmente ogni affettazione, ogni pretesa. Liu Xizai sottolinea questo punto quando afferma che “l’intenzione è la natura prima, il fondamento della calligrafia”.
Per Chen Jia, questa esigente morale non rappresenta un peso, ma una fonte di profondità. Lo obbliga a mantenersi in uno stato di vigilanza interiore, a coltivare le qualità che desidera far trasparire nella sua arte. La forza dei suoi tratti potenti può nascere solo da una forza interiore autentica. L’equilibrio delle sue composizioni può emergere solo da un equilibrio psichico reale. Questa dimensione etica illumina l’importanza attribuita dalla tradizione cinese alla biografia degli artisti. Le storie dell’arte cinese raccontano la vita dei creatori, le loro virtù, le loro prove. Perché non si può veramente comprendere un’opera senza conoscere l’uomo che l’ha prodotta.
Il percorso di Chen Jia, la sua perseveranza nello studio, la sua modestia nonostante i riconoscimenti ottenuti, il suo attaccamento ai valori tradizionali: tutto ciò non è accessorio alla sua arte, ma ne costituisce la sostanza stessa. La pratica intensiva della calligrafia da parte di Chen Jia fa parte di una disciplina di vita globale. Struttura il suo rapporto con il tempo, esige da lui una regolarità. Lo conduce alla pazienza, virtù rara nella nostra epoca di immediatezza. Gli insegna l’umiltà davanti alla grandezza degli antichi, dandogli allo stesso tempo la fiducia necessaria per stabilire la propria voce.
Liu Xizai avanza anche l’idea che la calligrafia debba manifestare un'”armonia del mezzo”, concetto preso in prestito dal pensiero confuciano. Si tratta di un equilibrio dinamico tra forze contrarie: la forza e la dolcezza, la rigore e la libertà. Chen Jia, nelle sue opere migliori, raggiunge precisamente questo equilibrio. I suoi paesaggi monumentali coniugano potenza espressiva e raffinatezza tecnica. Le sue calligrafie uniscono rispetto delle norme classiche e vigore personale. Non è né un imitatore servile, né un iconoclasta gratuito. Questa esigenza di coerenza tra arte e vita ci mette a disagio. La nostra epoca infatti ha dissociato il giudizio estetico dal giudizio etico, rendendo sospetta ogni pretesa di leggere il valore morale di un artista nella sua opera. Tuttavia, la prospettiva cinese tradizionale mantiene questa correlazione come ideale regolatore.
Una via di mezzo
Chen Jia opera in un contesto complesso. L’arte cinese contemporanea si trova divisa tra la pressione della tradizione millenaria, l’attrazione dei modelli occidentali e le esigenze del mercato globalizzato. In questo paesaggio confuso, alcuni rompono con il passato, cercando un’originalità effimera. Altri si rifugiano in una ripetizione accademica delle forme antiche. Chen Jia traccia la propria strada. Non rifiuta la tradizione: la prolunga. Non rinnega la modernità: la integra a modo suo.
Le sue grandi composizioni di paesaggi, con la loro energia grezza, non sono esercizi passatisti. Parlano al nostro tempo. In un mondo saturato da immagini digitali superficiali, la materialità dell’inchiostro, l’irreversibilità del gesto, la profondità storica della forma: tutto questo acquisisce un nuovo valore. Il critico Xia Chao osserva che Chen Jia manifesta un “atteggiamento di ricerca eseguito con perseveranza”, qualità che contrasta con “l’aria agitata di alcuni giovani di oggi”. Chen Jia non cerca il successo rapido. Si inserisce nella durata, accetta la lentezza della maturazione. In una cultura dell’istantaneità, questa pazienza diventa quasi sovversiva.
L’opera di Chen Jia ricorda che alcuni valori tradizionali conservano la loro pertinenza. La rigorosità della formazione, l’importanza della trasmissione, il rispetto per i maestri antichi: tutti principi che forse costituiscono antidoti necessari alle derive contemporanee. Chen Jia dimostra che si può essere un artista autenticamente contemporaneo pur radicandosi in una tradizione millenaria. Le sue opere non sono ricostruzioni storiche: sono vive e attuali. Provano che la grande tradizione pittorica cinese non è un patrimonio morto, ma un organismo vivente capace di rinnovarsi.
L’artista ci invita anche a riconsiderare il nostro rapporto col tempo. In un’epoca ossessionata dalla novità, ricorda il valore della ripetizione e dell’approfondimento. Gli anni trascorsi a copiare i vecchi maestri non sono tempo perso: costituiscono l’humus fertile da cui è emersa la sua creatività. Questa lezione vale oltre il dominio artistico: interroga il nostro culto dell’innovazione permanente e il nostro disprezzo per ciò che dura.
L’opera di Chen Jia ci confronta con le nostre contraddizioni. Espone l’incostanza delle nostre pretese di originalità radicale. Suggerisce che una vera creazione presuppone sempre un radicamento, un dialogo con chi ci ha preceduto. Ricorda che siamo meno gli autori sovrani delle nostre opere che gli anelli di una catena che ci supera, e che questa umile posizione, lontano dal limitare il nostro potere creativo, ne è la condizione. Nel tratto vigoroso di Chen Jia risuona l’eco di mille anni di storia, ed è proprio questa profondità temporale che conferisce al suo gesto il suo pieno significato. Questa è una lezione che la nostra epoca amnesica farebbe bene a meditare.
- Zong Baihua, Promenade esthétique, Shanghai Renmin Chubanshe, 1981.
- Liu Xizai, Yigai, XIX secolo.