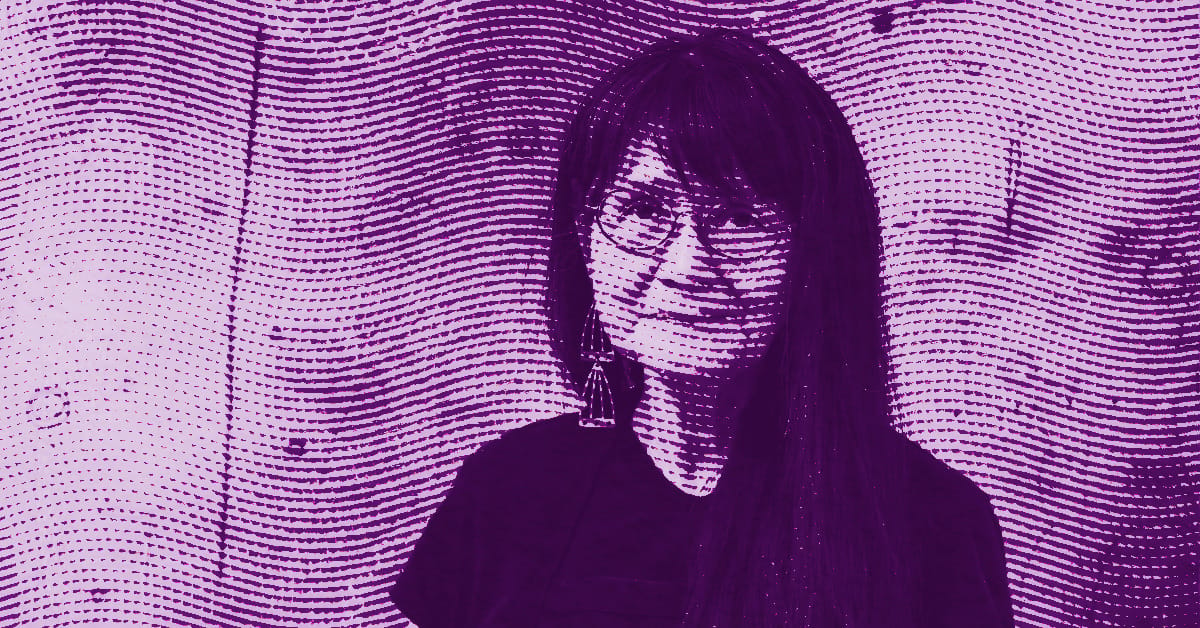Ascoltatemi bene, banda di snob : Emmi Whitehorse dipinge come i suoi antenati tessessero, con quella pazienza meticolosa che trasforma i fili colorati in cartografie spirituali. Da più di quarant’anni, questa donna, membro della Nazione Navajo, compone sinfonie visive dove la natura si rivela nella sua nudità più intima, lontano dalle convenzioni pittoriche occidentali che pretendono ancora di definire cosa sia o non sia l’arte contemporanea.
Nata nel 1956 a Crownpoint, nel Nuovo Messico, Whitehorse appartiene a quella generazione di artisti autoctoni che hanno rifiutato le assegnazioni identitarie per inventare il proprio linguaggio plastico. La sua formazione all’Università del Nuovo Messico, dove ottiene successivamente una laurea in pittura e poi un master in incisione, la confronta fin dall’inizio con questa tensione fondamentale fra eredità culturale e modernità artistica. Ma a differenza dei suoi contemporanei che optano per la denuncia o la riappropriazione polemica, Whitehorse sceglie la via dell’immersione contemplativa.
L’architettura dell’impermanenza
L’opera di Whitehorse si sviluppa secondo una logica che evoca irresistibilmente l’architettura gotica nella sua concezione dello spazio sacro. Come i costruttori di cattedrali che cercavano di materializzare l’invisibile divino, l’artista navajo costruisce le sue composizioni secondo una geometria spirituale dove ogni elemento partecipa di un equilibrio cosmico. Le sue tele rivelano quella stessa aspirazione verticale, quella stessa ricerca di trascendenza che si ritrova nelle volte di Chartres o nelle rosacee di Notre-Dame. Ma là dove l’arte gotica si eleva verso un Dio cristiano, Whitehorse scende verso le profondità telluriche della sua terra ancestrale.
Questa parentela con l’architettura religiosa medievale non è casuale. I dipinti di Whitehorse funzionano come spazi liturgici dove lo spettatore è invitato a una forma di raccoglimento estetico. Le sue composizioni astratte, attraversate da segni e simboli fluttuanti, ricordano quei manoscritti miniati dove il testo sacro si mescola ai marginalia ornamentali. Ogni opera diventa un libro delle ore contemporaneo, un breviario visivo che ordina il caos del mondo secondo i ritmi cosmici navajo.
L’artista procede per accumuli successivi, sovrapponendo gli strati pittorici come i maestri vetrai assemblavano le loro vetrate policrome. Questa tecnica di stratificazione crea una profondità ottica che evoca i giochi di luce filtrata dei grandi edifici religiosi. Nelle sue opere recenti esposte alla Biennale di Venezia 2024, in particolare “Typography of Standing Ruins #3”, Whitehorse spinge questa analogia architettonica al suo limite concettuale: le sue “rovine erette” suggeriscono quei resti di cappelle abbandonate dove la natura riprende i suoi diritti, dove l’arte umana ritorna al suo substrato organico.
Ma Whitehorse non si limita a imitare l’estetica gotica. Ella sovverte la logica teologica per sostituirla con una cosmogenesi autoctona dove l’orizzontalità prevale sulla verticalità, dove l’immanenza soppianta l’incarnazione. Le sue “cattedrali” sono praterie, le sue “navate” canyon, le sue “volte” i cieli infiniti del Sud-Ovest americano. Questa inversione paradigmatica costituisce uno degli aspetti più sovversivi del suo lavoro: smonta silenziosamente l’egemonia spirituale occidentale opponendole una spiritualità che attinge alle sorgenti precristiane dell’umanità.
L’architettura diventa in Whitehorse una metafora della memoria culturale. Come quei monumenti gotici che portano in sé la traccia di tutte le loro successive ristrutturazioni, le sue tele conservano la memoria stratificata della terra navajo. Ogni strato pittorico equivale a un’epoca geologica, ogni simbolo a un evento storico inciso nel paesaggio. Questa concezione stratificata della pittura fa di Whitehorse un’archeologa del sensibile, un’esploratrice d’anime che riesuma le verità sepolte sotto i sedimenti della colonizzazione.
La luce svolge nelle sue opere lo stesso ruolo strutturante che ha nell’arte gotica: rivela, gerarchizza, santifica. Ma mentre la luce gotica scende dal cielo verso la terra, quella di Whitehorse irradia dalle profondità geologiche per bagnare le sue composizioni di una fosforescenza minerale. Questa inversione della sorgente luminosa traduce perfettamente la differenza tra una spiritualità dell’elevazione e una spiritualità dell’ancoraggio.
L’alchimia della poesia americana
Se l’architettura gotica fornisce a Whitehorse il suo vocabolario spaziale, è nella poesia americana che ella attinge il suo ritmo temporale. Le sue composizioni evocano irresistibilmente la prosodia di Walt Whitman, quella cadenza ampia e respirata che abbraccia le vaste distese del continente americano. Come l’autore di “Foglie d’erba”, Whitehorse pratica un’estetica dell’inventario cosmico dove ogni elemento naturale trova il proprio posto in una sinfonia d’insieme.
Questa filiazione poetica supera la semplice analogia stilistica per toccare i fondamenti filosofici della creazione artistica. Whitman rivoluzionava la poesia americana abbandonando le forme metriche ereditate dall’Europa per inventare un verso libero che segue i ritmi naturali della parola e del paesaggio. Allo stesso modo Whitehorse libera la pittura autoctona dai canoni estetici imposti dall’arte occidentale per ritrovare quell’organicitá primitiva che fa dell’arte un prolungamento della natura piuttosto che un’imitazione.
La nozione whitmaniana del “Io cosmico” trova in Whitehorse la sua traduzione plastica. I suoi autoritratti astratti della serie “Self Surrender” rivelano un soggetto artistico che si dissolve nella natura circostante per rigenerarsi meglio. Questa dissoluzione dell’io individuale nel grande Tutto cosmico ricorda le estasi panteiste di Whitman, quei momenti in cui il poeta si sente “attraversato” dall’energia universale. In Whitehorse questa fusione avviene per mediazione del colore: i suoi gialli incandescente, i suoi blu abissali, i suoi rossi tellurici funzionano come vettori di comunione mistica con le forze elementali.
La tecnica stessa di Whitehorse evoca la scrittura whitmaniana per il suo carattere processuale e generativo. Come Whitman che non cessava di riscrivere e aumentare le sue “Foglie d’erba”, l’artista navajo procede per riprese e variazioni infinite sugli stessi motivi organici. I suoi semi, i suoi pollini, i suoi filamenti vegetali si trasformano da una tela all’altra secondo una logica evolutiva che riproduce i cicli naturali di crescita e rigenerazione.
Questa poetica della variazione perpetua iscrive l’opera di Whitehorse nella grande tradizione della poesia orale autoctona, dove ogni recitazione attualizza il mito secondo le circostanze dell’enunciazione. I suoi dipinti funzionano come poesie visive che si reinventano a ogni sguardo, rivelando associazioni inedite secondo lo stato d’animo dello spettatore e le condizioni di illuminazione della mostra.
L’influenza della poesia americana traspare anche nella concezione del tempo di Whitehorse. Come in Whitman o Emily Dickinson, il tempo non è lineare ma ciclico, scandito dai ritmi biologici e cosmici piuttosto che dalla storia umana. Le sue opere recenti della serie “Sanctum”, dipinte durante la pandemia, rivelano questa temporalità alternativa in cui l’isolamento sociale diventa l’occasione per una riconnessione con i ritmi fondamentali dell’esistenza [1].
Questa concezione poetica del tempo spiega perché Whitehorse rifiuti qualsiasi orientamento definitivo ai suoi quadri, ruotandoli costantemente durante il processo creativo. Questa rotazione permanente imita i cicli stagionali e diurni che strutturano l’esperienza temporale autoctona. Ogni posizione del quadro rivela un aspetto diverso della realtà rappresentata, come quelle poesie di Dickinson che cambiano senso a seconda dell’accento posto su questo o quel verso.
La rivelazione del microcosmo
“I miei dipinti raccontano la storia di conoscere la terra nel tempo, di essere completamente, microcosmicamente in un luogo” [2], confida Whitehorse in una delle sue rare interviste. Questa formula condensa l’essenza del suo approccio artistico: rivelare l’infinità del piccolo, dare a vedere l’invisibile pullulare della vita elementare che anima ogni porzione di territorio. Le sue composizioni funzionano come microscopi poetici che ingrandiscono l’impercettibile fino a farne un’epifania visiva.
Questa estetica del microcosmo affonda le radici nell’infanzia dell’artista, trascorsa a sorvegliare le pecore nelle vaste distese desertiche del New Mexico. Questa solitudine precoce ha affinato la sua percezione delle minime variazioni luminose, dei micromovimenti della vegetazione, di tutti quei fenomeni sottili che sfuggono generalmente all’attenzione umana. Le sue opere traducono questa ipersensibilità sensoriale in un linguaggio plastico di estrema sottigliezza, dove ogni sfumatura cromatica corrisponde a una sensazione particolare.
Il lavoro di Whitehorse rivela una conoscenza intima degli ecosistemi del Sud-Ovest americano che va ben oltre l’osservazione superficiale del turista o anche del proprietario di ranch. I suoi riferimenti alle piante endemiche, “Ice Plant XIV”, “Needle and Thread Grass III” e “Prickly Green II”, testimoniano una familiarità quasi scientifica con la flora locale. Ma questa precisione botanica si accompagna a una dimensione spirituale che fa di ogni specie vegetale un attore del dramma cosmico navajo.
La filosofia del hózhó, centrale nella cosmologia navajo, trova nell’arte di Whitehorse la sua traduzione plastica più compiuta. Questo concetto, intraducibile nella nostra lingua, designa l’armonia dinamica che connette tutti gli esseri viventi in una rete di interdipendenze sottili. Whitehorse materializza questa visione olistica tramite la sua tecnica della sovrapposizione: i suoi diversi strati pittorici interagiscono secondo una logica ecosistemica in cui ogni elemento influenza e modifica tutti gli altri.
Questo approccio sistemico alla pittura fa di Whitehorse una pioniera dell’arte ecologica contemporanea. Molto prima che la crisi climatica sensibilizzasse il mondo artistico alle questioni ambientali, lei sviluppava un linguaggio plastico capace di rendere visibile l’interconnessione di tutti i fenomeni naturali. Le sue opere funzionano come modelli in scala della biosfera, ecosistemi pittorici dove si sperimentano nuovi rapporti tra l’umano e il suo ambiente.
Questa dimensione ecologica prende una risonanza particolare nel contesto attuale della sesta estinzione di massa. Gli equilibri fragili che rivelano le tele di Whitehorse ci ricordano la precarietà del nostro mondo naturale e l’urgenza di inventare nuovi modi di convivenza con le altre specie. La sua arte diventa così un silenzioso appello per un riconoscimento della dignità intrinseca del vivente, al di là della sua utilità per la specie umana.
Verso una sintesi critica
L’opera di Emmi Whitehorse resiste alle categorizzazioni affrettate che vorrebbero racchiuderla nel ghetto dell”arte autoctona” o annessa alla corrente dominante dell”astrattismo contemporaneo. La sua unicità sta proprio in questa capacità di sintesi che fa dialogare le tradizioni plastiche più diverse senza mai gerarchizzarle né opporle. Dimostra per esempio che è possibile essere radicalmente moderne senza rinnegare le proprie radici culturali, innovare senza iconoclastia.
Questa posizione da funambola fa di Whitehorse una figura emblematica della postmodernità artistica, intesa non come una corrente estetica particolare, ma come un’attitudine critica che rifiuta i grandi racconti unificatori della modernità occidentale. La sua arte propone un’alternativa all’universalismo astratto della Scuola di New York opponendogli un particolarismo concreto che non esclude però la comunicazione interculturale.
Il riconoscimento internazionale di cui gode ormai Whitehorse, la sua inclusione alla Biennale di Venezia 2024 e le sue mostre nei più grandi musei americani testimoniano questa evoluzione del gusto contemporaneo verso estetiche più inclusive e meno eurocentriche. Ma questa consacrazione istituzionale non deve far dimenticare la dimensione sovversiva del suo lavoro, la sua silenziosa messa in discussione delle gerarchie culturali consolidate.
Perché l’arte di Whitehorse opera una rivoluzione copernicana nel nostro rapporto con il paesaggio e la natura. Dove la tradizione pittorica occidentale impone il suo punto di vista antropocentrico, lei sostituisce una visione ecocentrica che sposta l’umano dalla sua posizione dominante per reintegrarlo nella comunità del vivente. Questa decentramento ontologico costituisce forse il contributo più prezioso della sua opera all’arte contemporanea: insegnarci a vedere il mondo diversamente dal prisma delle nostre proiezioni narcisistiche.
L’eredità di Whitehorse si misura meno sull’influenza stilistica che potrebbe esercitare sulla giovane generazione che sulla sua capacità di aprire nuovi territori all’esperienza estetica. Rivelando la bellezza delle infinitesimali, dando forma plastica alle intuizioni spirituali della sua cultura d’origine, inventando un linguaggio astratto capace di dire l’invisibile, arricchisce il nostro vocabolario percettivo e ci rende più sensibili alle sottigliezze del mondo naturale.
Questa educazione dello sguardo costituisce una sfida politica importante nell’epoca in cui l’umanità deve reinventare i suoi rapporti con la biosfera. L’arte di Whitehorse ci prepara a questa mutazione necessaria coltivando quell’attenzione fluttuante, quella disponibilità contemplativa che permette di percepire la vita in tutte le sue forme. Ci ricorda che l’arte non è solo un divertimento estetico ma uno strumento di conoscenza e rigenerazione spirituale.
In un mondo saturo di immagini spettacolari ed emozioni false, i dipinti di Whitehorse offrono un rifugio di silenzio e autenticità. Ci invitano a riscoprire quella lentezza percettiva, quella pazienza meditativa che permette di accedere alle verità essenziali. Ci insegnano che l’arte vera non si limita a rappresentare la realtà ma la rivela nella sua dimensione sacra, riconciliandoci con il mistero fondamentale dell’esistenza.
L’opera di Emmi Whitehorse rappresenta un prezioso antidoto alla desacralizzazione del mondo contemporaneo. Restituendo alla natura la sua dimensione sacra, rivelando la poesia nascosta dei fenomeni più umili, ci aiuta a rinvigorire il nostro rapporto con il reale. La sua arte ci ricorda che non siamo solo consumatori di immagini ma partecipanti al grande dialogo cosmico che unisce tutti gli esseri in una stessa comunità di destino. Questa lezione di saggezza, impartita da una donna che ha saputo preservare le intuizioni ancestrali del suo popolo aggiornandole nel linguaggio dell’arte contemporanea, risuona come un messaggio di speranza nella nostra epoca travagliata.
- Michael Abatemarco, “Depth of Field: Artist Emmi Whitehorse”, The Santa Fe New Mexican, 8 gennaio 2021
- Elisa Carollo, “Navajo Artist Emmi Whitehorse’s Symbolic Landscapes Offer a Path to Reconnection With Nature”, Observer, ottobre 2024