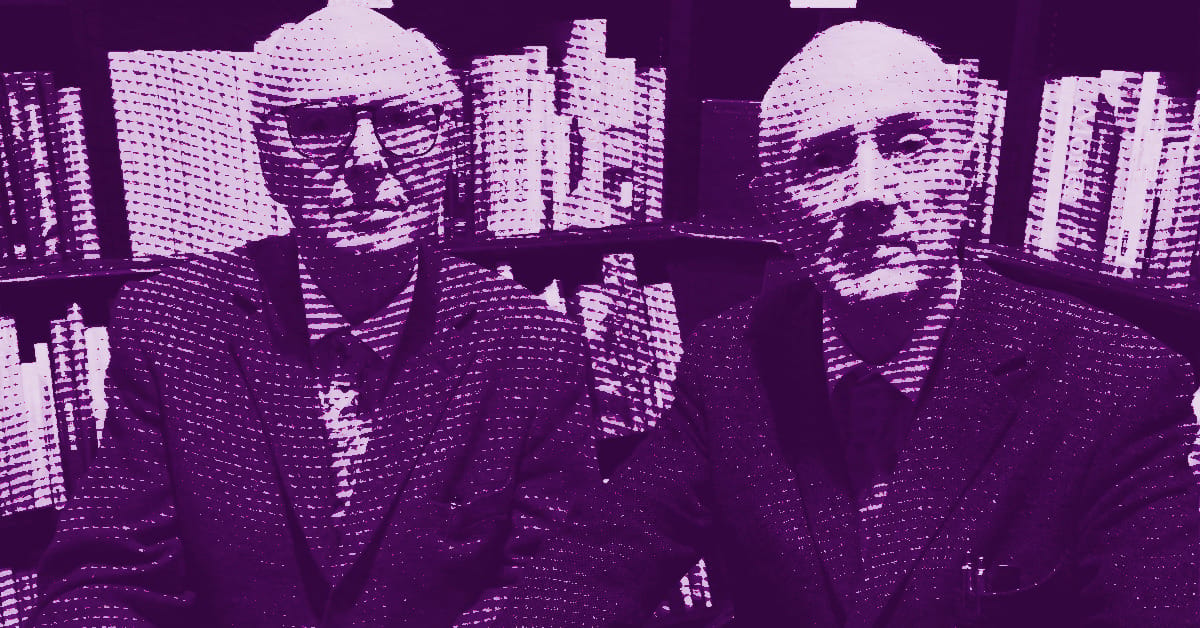Ascoltatemi bene, banda di snob: Gilbert & George non sono artisti ordinari, e pretendere di comprenderli attraverso il prisma convenzionale della storia dell’arte contemporanea sarebbe un errore tanto grossolano quanto giudicare una cattedrale dal colore delle sue vetrate. Questo duo improbabile, formato nel 1967 alla Saint Martin’s School of Art, ha metodicamente costruito un’opera che sfida qualsiasi classificazione affrettata, ogni tentativo di riduzione a un movimento, a una scuola o a una tendenza passeggera.
Gilbert Prousch, nato nel Tirolo del Sud italiano nel 1943, e George Passmore, nato a Plymouth nel 1942, incarnano da più di mezzo secolo una singolarità artistica che merita di essere esaminata con rigore. Il loro approccio si inscrive in una temporalità lunga, quasi architettonica, dove ogni opera costituisce una pietra aggiuntiva nell’edificio che essi erigono pazientemente. La dimensione architettonica del loro lavoro non deriva da una metafora banale ma da una realtà strutturale profonda. La loro casa di Fournier Street a Spitalfields, questa dimora georgiana del XVIII secolo che abitano dal 1968, non è semplicemente un luogo di residenza ma il crogiolo stesso della loro pratica artistica. L’architettura diventa per loro linguaggio, metodo, filosofia. Il restauro minuzioso che hanno intrapreso di questo edificio, restituendogli il suo decoro originario, testimonia una coscienza acuta del rapporto tra struttura e contenuto, tra forma ed esistenza. Questa casa non è un décor ma un’estensione del loro corpo artistico, uno spazio in cui vita e arte si fondono fino all’indistinguenza.
Le griglie nere che strutturano i loro fotomontaggi dagli anni 1970 evocano immediatamente l’ordinamento delle vetrate medievali, queste composizioni frammentate che raccontano storie sacre attraverso pannelli colorati. Ma dove la vetrata gotica eleva l’anima verso il divino, le griglie di Gilbert & George la riportano brutalmente verso il terrestre, il corporale, l’osceno persino. La loro serie dei Pictures, inaugurata all’inizio degli anni 1970, impone un sistema di composizione rigoroso dove ogni opera si dispiega come una finestra aperta sull’East End londinese. Questa strutturazione geometrica, lontana dall’essere una semplice scelta estetica, stabilisce un ordine nel caos della vita urbana che documentano con una costanza quasi maniaca. I colori saturi, spesso striduli, rinchiusi dietro queste sbarre nere, creano una tensione tra contenzione e traboccamento, tra l’apollineo della struttura e il dionisiaco del contenuto. L’architettura delle loro opere imita quella stessa della città, con le sue finestre, le facciate, le divisioni spaziali che organizzano la promiscuità umana.
La questione sociologica attraversa la loro opera con un’acuità che sorprende in artisti spesso accusati di frivolezza. Gilbert & George non si limitano a osservare il loro quartiere, ne fanno un laboratorio di studio delle mutazioni sociali contemporanee. La loro affermazione secondo cui “nulla accade nel mondo che non accada nell’East End” [1] potrebbe sembrare presuntuosa se non fosse accompagnata da una produzione di immagini che documenta metodicamente le stratificazioni sociali di questo territorio. L’East End londinese, con la sua storia di immigrazione successiva, povertà endemica e gentrificazione galoppante, offre infatti un concentrato delle tensioni che attraversano le metropoli occidentali. Gli artisti si posizionano lì come etnografi in abito tre pezzi, raccogliendo i rifiuti della modernità urbana: cartucce di protossido di azoto, graffiti, annunci di lavoratori sessuali, titoli sensazionalistici dei giornali. Questa accumulazione non è casuale ma segue una metodologia quasi scientifica. Ogni elemento prelevato dal loro ambiente immediato diventa un sintomo, un indizio delle relazioni di classe, razza, genere che strutturano la società britannica.
Il loro uso del linguaggio, soprattutto nelle serie come Ages del 2001 o le Jack Freak Pictures del 2009, rivela una comprensione profonda dei meccanismi di dominazione simbolica. Riproducendo annunci di prostituzione maschile, espongono crudelmente la mercificazione dei corpi nell’economia neoliberale. Raccogliendo i titoli isterici dell’Evening Standard, mettono a nudo la fabbrica della paura e del risentimento che alimenta il populismo. La ripetizione ossessiva delle parole “Murder”, “Victim”, “Gangs” nelle loro composizioni sottolinea la funzione ideologica del discorso mediatico che costruisce una realtà in cui la violenza diventa la modalità dominante di comprensione del sociale. Gilbert & George non denunciano esplicitamente questi meccanismi, la loro neutralità apparente li preserva da ogni didatticismo, ma il loro montaggio produce una distanza critica. Lo spettatore si trova confrontato con la materialità cruda del linguaggio sociale, decontestualizzato e reificato nello spazio dell’opera d’arte.
La questione della classe sociale attraversa clandestinamente la loro pratica. La loro uniforme, quei completi demodé che indossano fin da The Singing Sculpture nel 1969, costituisce un gesto sociologico tanto quanto estetico. Il completo rappresenta storicamente il vestito della rispettabilità della piccola borghesia, quello del commesso, dell’impiegato d’ufficio, del funzionario subordinato. Rinchiudendosi quotidianamente in esso, Gilbert & George interpretano un’identità di classe ambigua, né proletaria né aristocratica, che corrisponde esattamente alla loro posizione nel campo artistico. Rivendicano un’accessibilità popolare con il loro slogan “Art for All” [2], ma producono opere vendute a prezzi d’oro ai collezionisti internazionali. Questa contraddizione non è un’ipocrisia bensì il riflesso onesto della posizione impossibile dell’artista contemporaneo, preso tra aspirazione democratica e integrazione nel mercato del lusso. Il loro quartiere di Spitalfields incarna proprio questa tensione: ex territorio operaio dell’industria tessile, è diventato uno dei settori più borghesi di Londra, dove le case georgiane raggiungono diversi milioni di sterline. Gilbert & George abitano fisicamente e simbolicamente questa contraddizione.
Il loro trattamento della religione come istituzione sociale è particolarmente interessante. Le opere della serie Sonofagod Pictures del 2005 non si limitano a bestemmiare per il piacere di scioccare. Esse interrogano la persistenza del fatto religioso nelle società secolarizzate e il modo in cui i simboli sacri continuano a esercitare un’influenza sull’immaginario collettivo. Giustapponendo croci cristiane, motivi islamici e i loro stessi corpi in pose cristiche, sottolineano la funzione antropologica universale del religioso demolendone le pretese trascendenti. La religione appare come un sistema di segni tra gli altri, né più né meno legittimo del linguaggio pubblicitario o pornografico. Questa equivalenza generalizzata dei sistemi simbolici, caratteristica della condizione postmoderna, trova nel loro lavoro un’espressione particolarmente esplicita.
La questione razziale, onnipresente nella loro opera degli anni 1980 e 2000, solleva ambiguità che gli artisti assumono con una forma di provocazione calcolata. Titoli come Paki per designare il ritratto di un uomo asiatico hanno suscitato accuse di razzismo, accuse che essi spazzano via con un colpo di mano invocando la loro funzione di specchio sociale. Non creano il razzismo, argomentano, lo documentano. Questa posizione di neutralità etnografica è ovviamente problematica, poiché oscura il fatto che la riproduzione, anche critica, di stereotipi razziali contribuisce alla loro circolazione. Tuttavia, la loro insistenza a rappresentare la diversità etnica dell’East End, a dare visibilità a popolazioni emarginate, partecipa a una forma di inclusività, anche se goffa. I loro ultimi lavori, esposti fino all’11 gennaio 2026 alla Hayward Gallery di Londra, continuano a interrogare le linee di frattura identitarie che attraversano la società britannica post-Brexit, quella società che osservano da più di mezzo secolo con una costanza ammirevole.
Il gesto artistico di Gilbert & George consiste fondamentalmente nel trasformare la loro stessa esistenza in scultura vivente. Questa decisione presa alla fine degli anni 1960 di non apparire mai separati, di indossare costantemente lo stesso tipo di abito, di rifiutare la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita privata, denota una radicalità di cui spesso si sottovaluta l’esigenza. Si sono letteralmente costruiti come monumenti, figure pubbliche la cui identità artistica prevale su ogni identità personale. Questa auto-monumentalizzazione trova il suo compimento logico nell’apertura nel 2023 del Gilbert & George Centre in Heneage Street, spazio dedicato esclusivamente alla loro opera, prefigurazione di un mausoleo dove la loro memoria sarà conservata dopo la loro morte. Perché la morte si aggira ormai nelle loro composizioni recenti. La serie The Corpsing Pictures del 2023 li mostra distesi su ossa, vestiti con costumi color sangue. A più di ottant’anni, affrontano la loro finitezza con la stessa assenza di affettazione che hanno applicato a tutti gli altri soggetti.
Il loro rapporto con la sessualità merita attenzione. Sposati civilmente nel 2008 dopo quarant’anni di convivenza, hanno fatto della loro relazione omosessuale un elemento costitutivo della loro opera molto prima che ciò diventasse socialmente accettabile. Le Naked Shit Pictures del 1994, che li mostrano nudi in mezzo a rappresentazioni di escrementi, affermano la dimensione carnale, corporea, triviale dell’esistenza umana. Rifiutano la sublimazione romantica dell’amore così come della sessualità, preferendo mostrarli nella loro materialità prosaica. Questo approccio disincantato può sembrare cinico, ma porta anche una forma di tenerezza. La loro affermazione che le loro opere sono “una sorta di lettera d’amore visiva da parte nostra allo spettatore” [3] suggerisce che dietro la provocazione e l’oscenità si nasconde un desiderio di connessione umana, una volontà di condividere un’esperienza del mondo senza veli né menzogne.
L’opera di Gilbert & George resiste a ogni facile recupero. Conservatori autoproclamati, ammiratori di Margaret Thatcher, sostenitori della Brexit e della monarchia, disattendono le aspettative politiche dell’ambiente dell’arte contemporanea generalmente progressista. Questa posizione eterodossa ha suscitato l’ostilità di una parte della critica che li accusa di compiacenza verso le forze reazionarie. Eppure, le loro opere sul fascismo o sull’omofobia testimoniano un impegno senza ambiguità contro l’oppressione. Questa apparente contraddizione rivela soprattutto la povertà delle categorie politiche binarie per comprendere la complessità della realtà. Gilbert & George sfuggono alle classificazioni, ed è proprio questo che rende il loro lavoro necessario. Ci ricordano che la vita sociale non si lascia ridurre a slogan, che gli individui non sono astrazioni ideologiche ma esseri di carne attraversati da contraddizioni.
Il loro lascito supera di gran lunga il campo della storia dell’arte britannica. Hanno influenzato generazioni di artisti, da Kraftwerk che si ispirò al loro aspetto per creare la sua estetica robotica, a Grant Morrison che li parodierà nella sua serie a fumetti The Filth. La loro longevità eccezionale, più di cinquantacinque anni di collaborazione ininterrotta, costituisce in sé una performance notevole in un mondo dell’arte caratterizzato dall’effimero e dalla corsa alla novità. Hanno metodicamente costruito un’opera-cattedrale, pietra dopo pietra, immagine dopo immagine, con una disciplina monacale. Questa pazienza, questa fedeltà a una visione, questa ostinazione a scavare lo stesso solco decennio dopo decennio impone rispetto, anche se si possono contestare alcuni aspetti del loro lavoro.
Al termine di questo percorso nell’universo di Gilbert & George, un’evidenza si impone: la loro opera non si lascia domare attraverso le griglie di analisi convenzionali. Esige che venga affrontata con gli strumenti dell’architettura per comprenderne la struttura, con quelli della sociologia per coglierne l’ancoraggio nel reale, con quelli dell’antropologia per apprezzarne la dimensione documentaria. Ma richiede anche che si accetti la sua parte irriducibile di mistero, quella zona opaca dove due vite si sono fuse in un’unica entità artistica la cui logica intima ci sfugge necessariamente. La loro casa di Fournier Street, tempio e laboratorio, archivio e santuario, diventerà dopo la loro scomparsa un luogo di pellegrinaggio per coloro che cercheranno di penetrare il segreto di questa fusione. Ma forse questo segreto non esiste, forse Gilbert & George hanno semplicemente scelto di vivere la loro arte piuttosto che produrla, e questa decisione originaria contiene già tutta la chiave del loro enigma. In un’epoca saturata da discorsi teorici e giustificazioni concettuali, offrono lo spettacolo raro di una pratica artistica che si basta a se stessa, che non ha bisogno che venga tradotta o spiegata perché è lì, massiccia, inevitabile, a volte irritante, ma innegabilmente viva. Ed è forse questa la loro vittoria ultima: essere riusciti a sopravvivere a tutte le mode, a tutti i movimenti, a tutte le teorie, restando ostinatamente se stessi, due uomini in abito che guardano il mondo sfilare dalla loro strada di Spitalfields, raccogliendone i detriti per farne cattedrali di luce e fango.
- Anna van Praagh, “Gilbert and George: ‘Margaret Thatcher did a lot for art'”, The Daily Telegraph, 5 luglio 2009
- Slogan adottato dagli artisti fin dagli inizi, menzionato in particolare in Wolf Jahn, The art of Gilbert & George, or, An aesthetic of existence, Thames & Hudson, 1989
- Citazione degli artisti riportata in “Gilbert & George deshock at Rivoli”, ITALY Magazine, archivio del 28 gennaio 2013