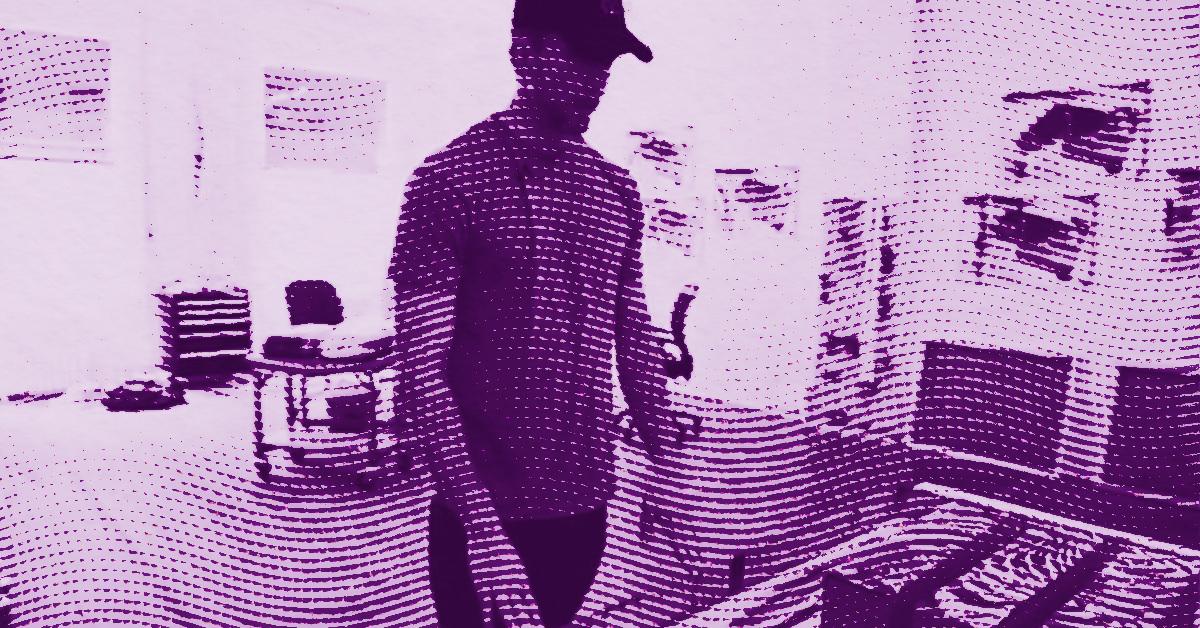Ascoltatemi bene, banda di snob : Kelley Walker non è solo un altro artista contemporaneo americano che gioca con l’appropriazione delle immagini. Incarnà una generazione di artisti che navigano nell’oceano tossico della nostra cultura mediatica, armati di scanner, schermi serigrafici e una coscienza acuta dei meccanismi perversi del capitalismo. Nato nel 1969, Walker appartiene a quella coorte che è cresciuta con l’esplosione dei media di massa e l’avvento del digitale, un periodo storico in cui le immagini hanno cominciato a proliferare esponenzialmente, perdendo progressivamente il loro ancoraggio referenziale per diventare pura circolazione.
L’opera di Walker si articola attorno a una proposta semplice ma terribilmente efficace : cosa diventa un’immagine quando transita attraverso i circuiti di riproduzione industriale ? Come si trasformano i segni culturali in merci e viceversa ? Le sue serie più conosciute, Black Star Press, Schema, o i suoi Rorschach a specchio, costituiscono altrettanti laboratori di sperimentazione sulla materialità delle immagini e la loro circolazione nell’economia simbolica contemporanea.
In Black Star Press (2004-2005), Walker si appropria di una fotografia emblematica del movimento per i diritti civili : quella scattata da Bill Hudson nel 1963 a Birmingham, che mostra un giovane manifestante nero, Walter Gadsden, attaccato da un cane poliziotto. Questa immagine, già appropriata da Andy Warhol nelle sue Race Riot del 1963-1964, subisce in Walker una serie di manipolazioni : rotazione, inversione, serigrafia a colori Coca-Cola, e soprattutto sovrapposizione di colate di cioccolato fuso (bianco, al latte, fondente) riprodotte meccanicamente. Il gesto non è innocente : interroga il modo in cui la storia della violenza razziale americana viene edulcorata, “cioccolatizzata”, trasformata in prodotto consumabile.
La serie Schema (2006) procede secondo una logica simile ma sposta il campo verso la sessualizzazione dei corpi femminili neri. Walker si appropria delle copertine della rivista maschile King, che mostrano donne nere in pose erotiche convenzionali, le quali vengono ricoperte da tracce di dentifricio scannerizzate e integrate digitalmente. Il riferimento all’igiene orale non è casuale : evoca allo stesso tempo pulizia, sbiancamento e, per estensione metaforica, i processi di asepsi mediatica.
La critica istituzionale come programma estetico
L’approccio di Walker si inserisce in una tradizione critica che ha origine nell’arte concettuale degli anni 1960-1970, ma si distingue per la sua consapevolezza delle mutazioni del capitalismo contemporaneo. Contrariamente agli artisti della critica istituzionale classica, Walker non si limita a denunciare i meccanismi del mondo dell’arte ; li integra nella sua pratica stessa, creando un’arte che funziona simultaneamente come merce e come critica della mercificazione.
Questa posizione ambivalente trova la sua espressione più compiuta nelle sue opere distribuite su CD-ROM, accompagnate dall’istruzione che l’acquirente può modificare, riprodurre e diffondere le immagini a suo piacimento. Walker radicalizza così la logica mercantile fino all’assurdo: il cliente diventa co-produttore, l’opera si moltiplica all’infinito, la proprietà artistica si dissolve. Questa strategia richiama le analisi che Guy Debord sviluppava in La Société du spectacle [1], dove mostrava come il capitalismo avanzato trasformi ogni esperienza in immagine consumabile. In Walker, questa logica spettacolare è spinta fino al suo punto di rottura, rivelandone le contraddizioni interne.
L’artista americano non si limita a criticare; egli performa la logica mercantile stessa. I suoi oggetti-sculture, come i suoi medaglioni dorati a forma di simbolo di riciclaggio o i suoi Rorschach a specchio, funzionano come prodotti di lusso pur rivelando i meccanismi di desiderio e proiezione che attivano. Lo spettatore si trova coinvolto in un dispositivo che lo istituisce simultaneamente come voyeur, consumatore e complice.
Questa strategia di “suridentificazione”, per riprendere un termine di Slavoj Žižek, permette a Walker di rivelare le contraddizioni del sistema senza porsi in una posizione di superiorità morale. Non c’è in lui nostalgia per un’età dell’oro dell’arte né critica frontale al capitalismo, ma piuttosto un’esplorazione paziente delle zone grigie in cui si negoziano i nostri desideri e le nostre repulsioni.
Architettura della memoria e politica dell’oblio
L’opera di Walker dialoga costantemente con la storia dell’arte americana, ma secondo una modalità particolare che richiama le riflessioni dello storico Pierre Nora sui “luoghi della memoria”. In Nora, i luoghi della memoria emergono proprio quando la memoria vivente scompare, quando è necessario costruire artificialmente ciò che non esiste più spontaneamente. Walker procede in modo simile con le immagini: le riesuma dal flusso mediatico nel momento stesso in cui rischiano di cadere nell’oblio, ma questa resurrezione passa attraverso la loro trasformazione in oggetti estetici ambigui.
I suoi riferimenti a Warhol non sono un omaggio ma un’archeologia critica. Quando Walker riprende la fotografia di Birmingham utilizzata da Warhol, non cerca di restaurarne la carica politica originaria ma di interrogare i meccanismi attraverso cui questa carica si è progressivamente smussata. Il cioccolato che ricopre l’immagine funziona come una testimonianza soggettiva: maschera e rivela simultaneamente, crea una distanza temporale che ci permette di misurare il cammino percorso tra gli anni 1960 e oggi.
Questa dialettica della memoria e dell’oblio attraversa l’intera sua opera. Nella sua serie Disasters (2002), Walker si appropria di immagini di catastrofi pubblicate nelle compilazioni fotografiche di Time-Life, che copre con punti colorati che ricordano i dipinti di Larry Poons. Questi punti funzionano come degli “otturatori” visivi che rendono l’immagine quasi illeggibile pur attirando l’attenzione su di essa. La catastrofe diventa motivo decorativo, ma questo stesso processo rivela il nostro rapporto anestetizzato con la violenza mediata.
L’approccio di Walker trova qui un’eco particolare nei lavori di Pierre Nora sulla trasformazione della storia in patrimonio [2]. Come lo storico francese ha mostrato, le nostre società contemporanee sono ossessionate dalla memoria proprio perché hanno perso il contatto diretto con il loro passato. Walker sembra illustrare visivamente questo paradosso: le sue opere sono “monumenti” a immagini in via di scomparsa, ma monumenti che rivelano l’artificialità stessa della loro costruzione.
La dimensione memoriale del suo lavoro permette di comprendere perché le sue opere hanno suscitato tali polemiche, in particolare durante la sua mostra al Contemporary Art Museum di Saint-Louis nel 2016. I manifestanti che chiedevano il ritiro delle sue opere rimproveravano a Walker di “disumanizzare” le vittime della violenza razziale. Questa critica, sebbene comprensibile sul piano emotivo, potrebbe però non cogliere la vera questione: Walker non disumanizza queste immagini, rivela la loro disumanizzazione già avvenuta nei circuiti mediatici. Il suo gesto artistico funziona come un rivelatore chimico che fa emergere processi generalmente invisibili.
Il modernismo alla prova del digitale
La pratica di Walker interroga anche le categorie estetiche ereditate dal modernismo, in particolare la distinzione tra originale e riproduzione, autenticità e simulazione. Le sue opere funzionano secondo una logica post-auratica assunta: sono fin dall’inizio concepite per essere riprodotte, modificate, adattate. Questa posizione prolunga le intuizioni di Walter Benjamin sull’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, ma in un contesto in cui questa riproducibilità è diventata totale e istantanea.
L’uso di software come Photoshop o Rhino 3D nel suo processo creativo non è un semplice strumento tecnico ma una dimensione costitutiva della sua estetica. Walker delega alcune decisioni formali all’algoritmo, creando un’arte della “post-produzione” dove la distinzione tra creazione e manipolazione si sfuma. Questo approccio lo avvicina ad artisti come Seth Price o Wade Guyton, con cui ha collaborato nel collettivo Continuous Project.
Ma Walker non si limita a esplorare le possibilità del digitale; ne rivela anche le impasse. Le sue opere su CD-ROM, per esempio, interrogano il sogno della democratizzazione tecnologica: che cosa succede all’arte quando tutti possono diventare produttori di immagini? La risposta di Walker è sfumata: questa democratizzazione formale si accompagna a una standardizzazione estetica che riproduce, a un altro livello, le logiche di dominazione che pretende di sovvertire.
I suoi simboli di riciclo, ricorrenti nella sua opera, funzionano come metafore di questa economia circolare delle immagini. Ma contrariamente al riciclo materiale, il riciclo simbolico non produce alcuna economia di mezzi: genera al contrario una proliferazione infinita di segni che finiscono per auto-annullarsi. Walker rivela così il carattere potenzialmente entropico della nostra cultura digitale.
Questa tensione tra possibilità tecnologiche e limiti simbolici attraversa l’intera sua opera. Le sue installazioni alla Paula Cooper Gallery, dove presenta centinaia di pannelli derivati da pubblicità Volkswagen, incarnano fisicamente questa problematica: l’abbondanza formale confina alla saturazione, la ricchezza informativa si trasforma in rumore bianco. L’esperienza estetica oscilla tra fascinazione e esaurimento, rivelando il nostro rapporto ambivalente con il sovraccarico informativo contemporaneo.
Verso un’estetica della complicità critica
L’opera di Kelley Walker non propone né soluzione né alternativa al capitalismo contemporaneo. Rivela piuttosto i suoi meccanismi intimi, i modi in cui colonizza il nostro immaginario e plasma i nostri desideri. Questa posizione può sembrare scomoda, persino cinica, ma possiede un valore euristico indiscutibile: ci permette di comprendere come tutti noi siamo diventati, più o meno, complici attivi del sistema che pretendiamo di criticare.
Walker pratica quella che potremmo chiamare un”estetica della complicità critica”. Non si pone in posizione di esteriorità rispetto alle logiche di mercato, ma ne rivela le contraddizioni dall’interno. Le sue opere funzionano come virus nel sistema: ne adottano i codici per meglio perturbare. Questa strategia non è senza rischi, può facilmente essere recuperata dal mercato che pretende di criticare, ma possiede il vantaggio della lucidità.
Nel momento in cui le immagini circolano a una velocità e secondo logiche che superano di molto la nostra capacità di comprensione, l’arte di Walker offre una preziosa pausa riflessiva. Ci obbliga a rallentare, a guardare più da vicino queste immagini che consumiamo meccanicamente. Rivela la densità storica e politica di segni apparentemente anodini. Ci ricorda che dietro ogni immagine si nasconde un”economia complessa di desideri, poteri e affetti.
L’arte contemporanea è spesso stata accusata di complicità con le logiche di mercato che pretende di criticare. Walker assume pienamente questa contraddizione e ne fa il materiale stesso della sua pratica artistica. Questa onestà paradossale costituisce forse la sua principale forza: invece di cullarci di illusioni sulla possibile purezza dell’arte, ci confronta con la nostra condizione comune di esseri presi nelle reti dello spettacolo di mercato. Questo confronto, per quanto scomodo, costituisce senza dubbio un presupposto necessario a ogni vera trasformazione dei nostri rapporti con il mondo e con le immagini.
In un contesto in cui le questioni della rappresentazione e dell’appropriazione culturale sono diventate centrali nei dibattiti artistici, l’opera di Walker invita a superare le posizioni moralistiche per interrogare più profondamente le condizioni materiali e simboliche di produzione delle immagini. La sua arte non risponde alla domanda su chi abbia il diritto di rappresentare cosa, ma rivela i meccanismi attraverso cui questa stessa domanda viene prodotta e strumentalizzata dalle logiche spettacolari contemporanee.
- Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel, 1967.
- Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992, 3 volumi.