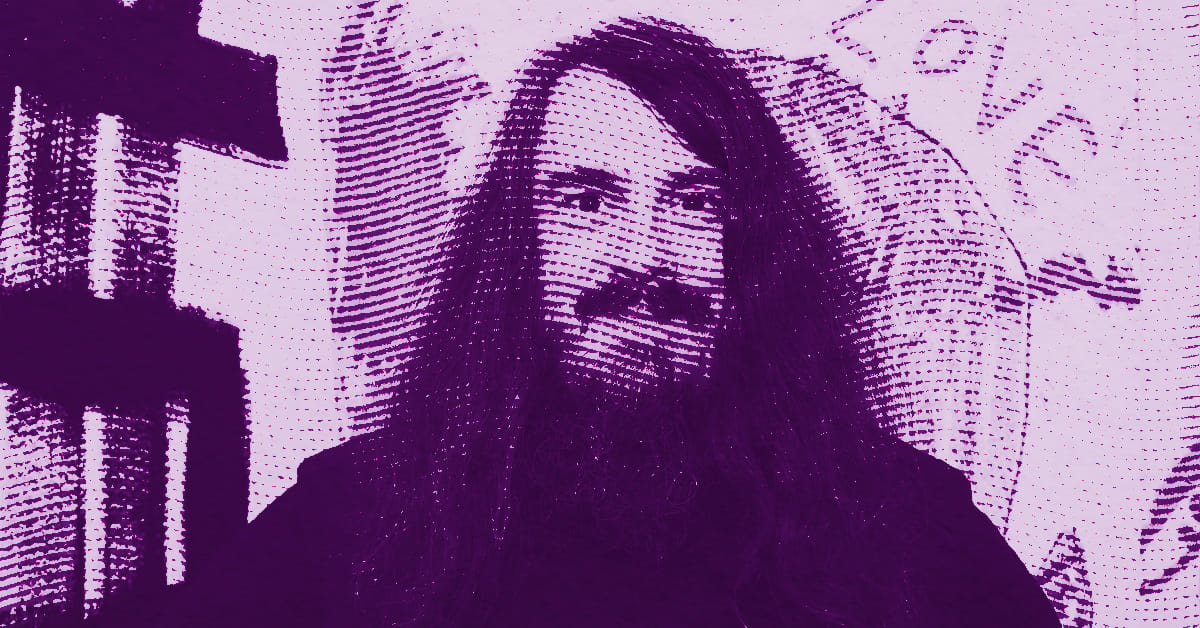Ascoltatemi bene, banda di snob. Ecco uno dei fenomeni artistici più sconcertanti e necessari del nostro tempo: Jonathan Meese, questo tedesco nato a Tokyo nel 1970, che da oltre due decenni martella le nostre certezze estetiche con una costanza ammirevole. Nel suo atelier-bunker di Berlino, circondato da sua madre Brigitte che svolge il ruolo di sergente istruttore dell’ordine creativo, Meese crea un’arte che si rifiuta ostinatamente di essere domata dalle nostre consuete griglie di lettura. Il suo universo pittorico, popolato da figure storiche scomposte e riferimenti pop massacrati a colpi di pennello furioso, costituisce un’esperienza visiva che ci confronta brutalmente con i nostri limiti concettuali.
L’opera di Meese non si limita a occupare lo spazio museale con l’arroganza disinvolta di uno squatter di lusso. Impone la sua presenza con una violenza cromatica e formale che stupisce tanto quanto rivolta, creando quella particolare sensazione di essere intrappolati in un incubo tecnicolor la cui uscita rimane ostinatamente invisibile. Le sue tele, veri campi di battaglia dove si scontrano paste colorate e figure contorte, testimoniano un’urgenza espressiva che attraversa la storia dell’arte tedesca come una lama incandescente. Questa urgenza trova le sue radici in un rapporto complesso con il potere, l’autorità, e soprattutto con quella “Dittatura dell’Arte” che proclama con l’ardore di un evangelista allucinato.
L’inconscio in azione: Jonathan Meese e la macchina psicoanalitica
L’approccio di Jonathan Meese rivela corrispondenze inquietanti con i meccanismi dell’inconscio freudiano, in particolare nella sua capacità di trasformare traumi collettivi in materia pittorica. L’arte contemporanea, flirtando con l’astrazione o proponendo opere concettuali, invita ciascuno a proiettare le proprie esperienze, paure e desideri sull’opera [1], e Meese spinge questa logica ai suoi limiti più estremi. I suoi dipinti funzionano come schermi di proiezione dove si cristallizzano le nostre angosce più profonde riguardo all’autorità, alla violenza e alla sottomissione.
L’artista sviluppa un processo creativo che richiama irresistibilmente il lavoro di condensazione e spostamento alla base della formazione dei sogni. I suoi personaggi storici, Hitler, Napoleone e Wagner, subiscono trasformazioni plastiche che li spogliano della loro gravità storica per trasformarli in figure grottesche, quasi clownesche. Questa operazione di svalutazione simbolica richiama i meccanismi di difesa psichica con cui l’individuo neutralizza ciò che lo minaccia. Meese non distrugge queste figure, le rende ridicole, svuotandole del loro potere fantastico proprio nell’eccesso della loro rappresentazione.
La presenza ossessiva di sua madre nel suo processo creativo costituisce un elemento fondamentale per comprendere la dimensione psicoanalitica della sua opera. Brigitte Meese non è solo la sua assistente, incarna un’autorità materna che struttura e canalizza le pulsioni distruttive dell’artista. Questa configurazione familiare richiama le analisi freudiane sulla sublimazione, processo tramite il quale le pulsioni aggressive trovano una via socialmente accettabile nella creazione artistica. Lo stesso Meese riconosce che sua madre “porta ordine” nella sua vita e nel suo atelier, svolgendo il ruolo di super-io benevolo che permette all’artista di dare forma alle sue ossessioni senza cadere nell’autodistruzione.
Il rapporto complesso che Meese intrattiene con l’ideologia si illumina anche sotto l’angolo psicoanalitico. La sua “Dittatura dell’Arte” funziona come una formazione di compromesso, consentendo di esprimere fantasie di onnipotenza pur smorzandole per il loro carattere apertamente delirante. L’artista proietta sull’arte stessa le sue pulsioni dominanti, creando una finzione teorica che gli permette di evitare l’impegno politico diretto. Questa strategia di evitamento rivela una struttura psichica particolarmente sofisticata, capace di trasformare l’angoscia in energia creativa mantenendo una distanza critica rispetto alle proprie ossessioni.
L’analisi dei suoi autoritratti rivela anche una dimensione narcisistica assunta che richiama le descrizioni freudiane del narcisismo primario. Meese si rappresenta costantemente nelle sue opere, ma sempre sotto tratti deformati, grotteschi, che testimoniano un rapporto ambivalente con la propria immagine. Questa auto-rappresentazione compulsiva richiama il Fort-Da descritto da Freud, quel gioco di ripetizione con cui il bambino controlla simbolicamente ciò che gli sfugge. Meese scompare e riappare nelle sue tele come se tentasse di controllare la propria esistenza ripetendo la sua immagine.
La dimensione pulsionale del suo lavoro si manifesta anche nella sua tecnica pittorica brutale, dove la pittura è direttamente spremuta dal tubetto sulla tela, evitando qualsiasi mediazione tramite il pennello tradizionale. Questa immediatezza del gesto evoca l’espressione diretta della libido, senza le sublimazioni abituali della pratica artistica classica. Meese dipinge come si scarica una tensione, nell’urgenza di un sollievo che non può essere rimandato.
L’ossessione ricorrente per figure maschili di potere, dittatori, imperatori ed eroi wagneriani, rivela una fascinazione per l’autorità paterna che l’artista si appropria e al contempo decostruisce. Questi personaggi funzionano come sostituti del padre simbolico, che può sia venerare che distruggere senza rischiare vere conseguenze. La psicoanalisi ci insegna che l’arte può servire da spazio transizionale dove si elaborano i nostri rapporti più conflittuali con l’autorità, e l’opera di Meese costituisce un laboratorio privilegiato per osservare questi meccanismi allo stato puro.
Wagner e la tentazione dell’opera d’arte totale
La relazione di Jonathan Meese con Richard Wagner rivela un’altra dimensione essenziale del suo progetto artistico: l’aspirazione al Gesamtkunstwerk, quell’opera d’arte totale che ossessiona la cultura tedesca dal XIX secolo. Questa ambizione wagneriana permea profondamente la pratica di Meese, che rifiuta di limitarsi a un unico medium e sviluppa simultaneamente pittura, scultura, performance, scrittura teorica e messa in scena lirica. Il suo approccio multidisciplinare testimonia una volontà di saturare lo spazio artistico, di creare un ambiente totale dove lo spettatore si immerge in un universo coerente e opprimente.
L’influenza wagneriana traspare particolarmente nelle dimensioni epiche delle sue installazioni, che trasformano lo spazio espositivo in teatro delle sue ossessioni personali. Come Wagner costruiva le sue opere secondo una drammaturgia totalizzante dove musica, testo, scenografia e interpretazione concorrevano a un effetto unico, Meese concepisce le sue esposizioni come spettacoli globali dove ogni elemento, dipinti, sculture, video e performance, partecipa a una messa in scena d’insieme. Questo approccio orchestrale all’arte contemporanea rivela un’ambizione demiurgica che non è senza richiamare i sogni di rigenerazione culturale cari al compositore.
La produzione operistica di Meese, in particolare la sua versione di Parsifal creata alle Wiener Festwochen nel 2017, costituisce l’elogio logico di questo approccio totalizzante. Affrontando l’ultimo opera di Wagner, Meese si inserisce in una linea di artisti tedeschi ossessionati dall’eredità del maestro di Bayreuth. Ma dove i registi tradizionali tentano generalmente di domare la dimensione mitologica wagneriana attraverso letture psicologiche o sociologiche, Meese spinge invece questa mitologia verso i suoi estremi più deliranti. Il suo Parsifal futuristico, popolato da personaggi di fantascienza e ambientato in una base lunare, radicalizza l’estetica wagneriana invece di neutralizzarla.
Questa strategia di amplificazione rivela una comprensione sottile delle questioni estetiche e ideologiche dell’opera wagneriana. Piuttosto che tentare di purificare Wagner dai suoi aspetti più problematici, Meese sceglie di esasperarli fino all’assurdo, creando una sorta di vaccinazione artistica contro le tentazioni totalitarie. Il suo Parsifal diventa una parodia delle aspirazioni alla redenzione collettiva, trasformando il dramma sacro in opera dello spazio scatenato dove la ricerca del Graal si trasforma in avventura da serie B.
L’approccio scenografico di Meese rivela anche una padronanza consumata dei codici visivi wagneriani che devia a scopi critici. I costumi, le scenografie, le luci prendono in prestito dal vocabolario estetico di Bayreuth pur parasitandolo con elementi pop e di fantascienza che ne rivelano l’artificialità. Questa contaminazione stilistica crea un effetto di distanziamento che permette allo spettatore di percepire i meccanismi di seduzione all’opera nell’arte di Wagner senza tuttavia soccombere.
La dimensione temporale costituisce un altro punto di convergenza tra Wagner e Meese. Come le opere di Wagner sviluppano i loro effetti su durate insolite che saturano la percezione dello spettatore, le installazioni di Meese creano una temporalità specifica, dilatata, dove l’accumulo di elementi visivi finisce per produrre una forma di esaurimento sensoriale. Questa strategia di immersione prolungata mira a superare le resistenze razionali del pubblico per raggiungere zone di ricezione più primitive, più direttamente emotive.
L’ambizione wagneriana di rigenerazione culturale trova in Meese una traduzione contemporanea nella sua teoria della “Dictature de l’Art”. Come Wagner sognava un’arte capace di rifondare la società tedesca, Meese profetizza l’avvento di un regno estetico che supererebbe le divisioni politiche tradizionali. Questa utopia artistica, per quanto delirante, testimonia una persistenza delle aspirazioni totalizzanti nella cultura tedesca, aspirazioni che Meese riattiva svuotandole però del loro pericolo proprio con l’eccesso della loro formulazione.
L’eredità di Wagner traspare anche nella concezione che Meese ha del ruolo dell’artista. Come Wagner si poneva come riformatore culturale totale, teorico tanto quanto creatore, Meese sviluppa un corpus teorico prolifico dove espone la sua visione del mondo e dell’arte. I suoi manifesti, le sue interviste, le sue performance teoriche partecipano a questa ambizione pedagogica che fa dell’artista una guida spirituale del suo tempo. Questa postura profetica, ereditata dal romanticismo tedesco e amplificata da Wagner, trova in Meese un’espressione contemporanea che ne rivela sia la necessità sia i limiti.
L’estetica della contraddizione
Ciò che colpisce subito nell’universo di Jonathan Meese è la sua capacità di mantenere in tensione elementi apparentemente incompatibili. Da un lato, quest’uomo di più di cinquanta anni che vive ancora con sua madre proclama la necessità di una “Dittatura dell’Arte” con la veemenza di un tribuno rivoluzionario. Dall’altro, sviluppa una pratica pittorica di una tenerezza inattesa, dove i colori vivaci e le forme biomorfe evocano tanto l’universo dell’infanzia quanto gli incubi dell’età adulta. Questa schizofrenia assunta costituisce forse la chiave di volta del suo sistema estetico: rifiutare ogni conforto interpretativo, mantenere lo spettatore in uno stato di incertezza produttiva.
Le sue pitture recenti, in particolare quelle dedicate a Scarlett Johansson o alle figure materne, rivelano una sensibilità cromatica che non ha nulla da invidiare ai grandi coloristi della storia dell’arte. Ma questa padronanza tecnica è costantemente sabotata da elementi volutamente grossolani: scritte a pennarello, collage avventurosi, impasti brutali che trasformano ogni tela in un campo di battaglia estetico. Meese sembra incapace di creare bellezza senza immediatamente contaminarla, come se temesse gli incantesimi della seduzione artistica.
Questa estetica dell’autosabotaggio trova la sua espressione più radicale nelle sue performance, dove l’artista assume alternativamente i ruoli di buffone e dittatore, di profeta e ciarlatano. Le sue apparizioni pubbliche, sempre spettacolari, creano un disagio produttivo che interroga le nostre aspettative rispetto alla figura dell’artista contemporaneo. Rifiutando la postura dell’intellettuale distinto così come quella del ribelle romantico, Meese inventa una persona artistica inedita, allo stesso tempo grottesca e carismatica, che destabilizza le nostre abitudini di ricezione.
Il suo rapporto con la storia tedesca illustra perfettamente questa logica contraddittoria. Piuttosto che evitare i simboli compromettenti o denunciarli frontalmente, sceglie di incorporarli nel suo universo estetico svuotandoli della loro carica drammatica attraverso la ripetizione e la deformazione. Questa strategia di esaurimento simbolico rivela un’intelligenza tattica notevole: trasformando le icone del male in marionette colorate, Meese ne toglie il potere di fascinazione preservandone la funzione critica.
L’accumulo di oggetti eterogenei nelle sue installazioni partecipa a questa medesima logica di saturazione semantica. Giocattoli, artefatti militari, riferimenti pop, frammenti di opere classiche convivono in un caos organizzato che sfida ogni tentativo di gerarchizzazione culturale. Questa parificazione per eccesso produce un effetto vertiginoso che ci confronta con l’arbitrarietà delle nostre scale di valore estetico. Per Meese, una maschera di Dark Vador vale un busto di Napoleone, e questa equivalenza assunta costituisce forse il suo contributo più sovversivo al dibattito artistico contemporaneo.
Oltre lo spettacolo: la questione della necessità
Dietro il circo mediatico e le provocazioni calcolate, l’opera di Jonathan Meese pone una questione fondamentale: quella della necessità dell’arte nelle nostre società disincantate. La sua “Dittatura dell’Arte”, nonostante i suoi aspetti deliranti, formula una legittima esigenza: che l’arte ritrovi una funzione sociale che superi il semplice intrattenimento culturale o l’investimento speculativo. Proclamando che solo l’arte può salvare l’umanità dalle ideologie mortifere, Meese riattiva una tradizione utopica che attraversa la storia della modernità artistica, dall’avanguardia russa al surrealismo francese.
Questa dimensione profetica non deve oscurare la rigore del suo approccio formale. Meese padroneggia perfettamente i codici dell’arte contemporanea internazionale, ma sceglie di deviarli al servizio di un progetto personale che sfugge alle categorie critiche abituali. Le sue collaborazioni con Albert Oehlen, Daniel Richter o Tal R testimoniano una capacità di dialogo con i suoi pari che contraddice l’immagine di un artista isolato nelle sue ossessioni. Questa dimensione collettiva del suo lavoro rivela una strategia di resistenza di fronte all’individualismo sfrenato del mercato dell’arte contemporanea.
L’evoluzione recente della sua pratica, segnata da un rifiuto di spostarsi per le sue esposizioni e da un ricentramento sul suo atelier berlinese, suggerisce una maturazione che merita attenzione. Scegliendo la sedentarietà contro il nomadismo artistico, Meese afferma la preminenza del processo creativo sulla sua mediaticità. Questa saggezza inattesa, in un artista noto per i suoi eccessi, testimonia una crescente lucidità sulle trappole del sistema artistico attuale.
Le sue opere recenti, meno cariche simbolicamente rispetto alle sue produzioni degli anni 2000, rivelano un rilassamento relativo che non esclude l’intensità espressiva. Le serie dedicate alle maschere in ceramica o ai paesaggi mentali mostrano un artista capace di evolvere senza rinnegare le sue ossessioni fondamentali. Questa capacità di rinnovamento, rara nell’ambito dell’arte contemporanea, suggerisce che Meese potrebbe ben superare lo status di enfant terrible che gli è attaccato alla pelle per accedere a un riconoscimento più duraturo.
Perché è proprio di questo che si tratta alla fine: Jonathan Meese ci mette di fronte ai nostri limiti, alle nostre paure, ai nostri desideri repressi con una brutalità salutare che fa di ogni confronto con la sua opera un’esperienza trasformativa. In un paesaggio artistico spesso addomesticato dagli imperativi mercantili e dalle convenienze istituzionali, egli mantiene viva questa funzione scomoda dell’arte che ci obbliga a mettere in discussione le nostre certezze. E per questo, paradossalmente, possiamo essergli grati. Anche se, soprattutto se, la sua arte ci mette profondamente a disagio mettendoci di fronte ai nostri limiti.
- “Il soggetto, la psicoanalisi e l’arte contemporanea”, Cairn.info, 2012