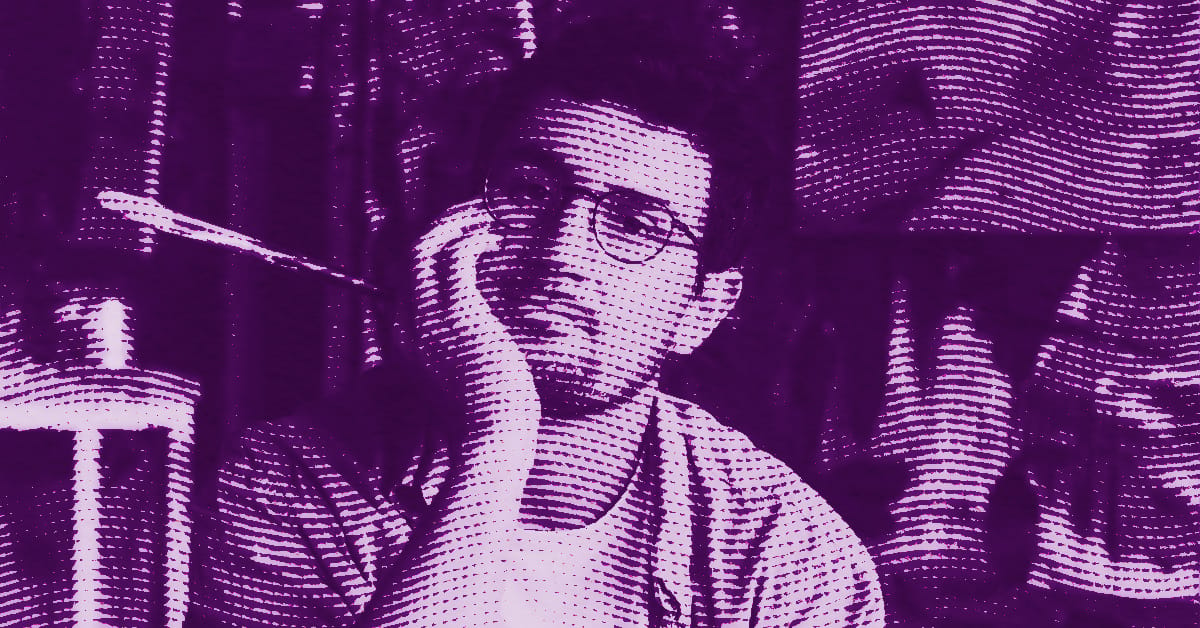Ascoltatemi bene, banda di snob, Louis Fratino è uno dei pochi artisti contemporanei che comprende davvero cosa significa abitare un corpo. Non solo possedere un corpo, ma abitarlo pienamente, con tutte le sue sensazioni, i suoi desideri, le sue vulnerabilità. Osservando la sua opera, ci si trova di fronte a una fenomenologia pittorica che richiama le più grandi intuizioni di Maurice Merleau-Ponty sul nostro rapporto con il mondo attraverso la carne. Fratino ci ricorda che la vera missione dell’arte è farci sentire la nostra stessa corporeità. La sua opera non è semplicemente una celebrazione del corpo maschile o dell’omoerotismo, sarebbe una lettura terribilmente riduttiva, ma una profonda esplorazione di cosa significhi essere incarnati in un mondo dove la virtualità e la distanza sono diventate la nostra seconda natura.
La carne in Fratino non è mai anonima. Porta sempre un nome, una storia, un’intimità. Che dipinga un amante addormentato in “Four Poster Bed” (2021) o corpi abbracciati in “Kissing Couple” (2019), ogni soggetto è allo stesso tempo specifico e universale. Guardate come tratta i dettagli fisici, peli, pieghe, articolazioni, con un’attenzione che trasforma l’anatomia in topografia emotiva. La critica Roberta Smith ha colto perfettamente questa qualità quando scrive che i suoi dipinti sono “caldi del piacere della domesticità del trascorrere il tempo a casa, dell’intimità condivisa. E sono caldi anche di attenzione pittorica e di erudizione, invitando a un esame similare da parte dello spettatore. Quasi ogni pennellata e segno, ogni dettaglio di arredamento e peli corporei, ha una vita propria.”[1]
Questo impegno con la fenomenologia del corpo non è senza precedenti nella storia dell’arte. Ma là dove Fratino si distingue è nella sua capacità di fondere questa preoccupazione con una rivalutazione radicale delle tradizioni moderniste. Non si limita a imitare Picasso, Matisse o Hartley, ma li assimila e li riconfigura attraverso il prisma di un’esperienza contemporanea queer. Prendiamo “I keep my treasure in my ass” (2019), titolo tratto dal libro “Verso un comunismo gay” di Mario Mieli. L’opera rappresenta l’artista che si dà alla luce da sé attraverso il retto, una potente metafora visiva che trasforma un organo spesso ridotto alla sua funzione sessuale o scatologica in un luogo di creazione identitaria e generazione del sé.
Questa tela, esposta alla 60ª Biennale di Venezia, illustra perfettamente come Fratino dispieghi un vocabolario modernista, i volti dalla geometria cubista, le distorsioni espressioniste del corpo, per articolare un’esperienza che i modernisti come Picasso, nonostante il loro genio, non avrebbero mai osato esprimere. Un critico ha osservato che davanti a quest’opera “le persone facevano quasi la fila per posarsi davanti a questo dipinto, poi facevano smorfie o avevano reazioni fisiche.”[2] Questa reazione viscerale è precisamente ciò che Merleau-Ponty descriveva come “la carne del mondo”, quel momento in cui la nostra percezione e il mondo percepito si incontrano in una danza di riconoscimento reciproco.
La fenomenologia merleau-pontiana ci insegna che non siamo spiriti disincarnati che osservano il mondo dall’esterno, ma esseri incarnati, integrati nel tessuto stesso della realtà. Il nostro corpo non è un semplice oggetto fra gli altri oggetti, ma il nostro mezzo per avere un mondo. Fratino sembra comprendere questa verità a un livello istintivo. In “Washing in the Sink”, un uomo nudo si lava dopo l’amore, un atto banale trasformato in un rito di riabitazione del corpo. Non è l’atto sessuale che interessa l’artista qui, ma il momento che segue, quando torniamo pienamente consapevoli della nostra corporeità.
Merleau-Ponty scrive in “L’Oeil et l’Esprit”: “Il pittore ‘porta il suo corpo’, dice Valéry. E, in effetti, non si vede come uno Spirito potrebbe dipingere. È prestando il suo corpo al mondo che il pittore trasforma il mondo in pittura.”[3] Fratino certamente apporta il suo corpo in ogni tela, non come esercizio narcisistico, ma come offerta fenomenologica. La sua tecnica pittorica stessa, la materialità densa della sua pittura, le sue pennellate testurizzate, la sua tavolozza che alterna calore terroso e freschezza oceanica, riflettono questa preoccupazione per l’esperienza vissuta del corpo.
Questo approccio fenomenologico si estende oltre le scene esplicitamente erotiche per comprendere tutti gli aspetti dell’esistenza incarnata. Le nature morte di Fratino, come “My Meal” (2019) o “Polaroids on the kitchen counter” (2020), rivelano una sensibilità simile. Gli oggetti quotidiani, un uovo su pane tostato, un pomodorino ciliegia, polaroid sparse, sono rappresentati con la stessa attenzione amorosa dei corpi nudi. Perché per Merleau-Ponty come per Fratino, non c’è separazione ontologica tra il corpo e il mondo che abita; entrambi sono tessuti nella stessa stoffa carnale della realtà.
“Mi piace che i dipinti siano crostosi, spessi e corporei”, confida l’artista.[4] Questa dichiarazione rivela il suo impegno verso una pittura che non è semplicemente rappresentazione, ma incarnazione. I suoi quadri non mostrano solo corpi; sono essi stessi corpi, con la loro propria trama, peso e presenza.
Ciò che Fratino condivide con Merleau-Ponty è la convinzione che il nostro rapporto col mondo sia fondamentalmente preriflessivo, radicato nella percezione sensoriale prima di qualsiasi analisi intellettuale. Quando guardiamo “Metropolitan” (2019), una scena in un bar gay dove i corpi si intrecciano in uno spazio compresso, non “leggiamo” semplicemente una rappresentazione della socialità queer; sentiamo visceralmente il calore, la prossimità, la texture di quell’esperienza. L’opera si rivolge direttamente al nostro corpo, bypassando l’interpretazione puramente cognitiva.
Ma la fenomenologia di Merleau-Ponty non è solo una semplice teoria della percezione; è anche una teoria dell’intersoggettività. Il nostro corpo non è solo ciò che ci dà accesso al mondo, ma anche ciò che ci permette di riconoscere l’altro come un soggetto incarnato simile a noi stessi. È proprio questa dimensione intersoggettiva che Fratino esplora nei suoi ritratti di amanti e amici. In “Me and Ray” o “Tom”, lo sguardo non è mai oggettivante; riconosce sempre l’altro come un soggetto incarnato, con una propria interiorità.
Come scrive Merleau-Ponty in “Phénoménologie de la perception”: “Il corpo dell’altro non è un oggetto per me, né il mio per lui… È un altro modo di essere corpo.”[5] Le figure nei quadri di Fratino non sono mai ridotte a oggetti del desiderio; conservano sempre il loro mistero, la loro autonomia. Anche nelle scene più esplicitamente sessuali, come “Kiss” dove un uomo pratica l’anilingus su un altro, c’è un riconoscimento dell’altro come soggetto.
Questo riconoscimento intersoggettivo si estende oltre i partner sessuali per includere la famiglia. In “My sister’s boys”, Fratino dipinge due ragazzi nudi incorniciati da una porta scura. Quest’opera potrebbe facilmente essere fraintesa nella nostra cultura ipervigilante, ma come indica il titolo, sono i suoi nipoti. Dipingendoli così, Fratino rifiuta la sessualizzazione eccessiva della nudità infantile, riconoscendo allo stesso tempo che anche i bambini sono esseri incarnati. Stabilisce una continuità tra tutte le forme di incarnazione, quella dell’amante, dell’amico, del bambino, senza ridurle tutte allo stesso livello.
Questo approccio fenomenologico assume una particolare risonanza nel contesto italiano dove si svolge la mostra “Satura”. In un paese dove il governo di destra estrema di Giorgia Meloni ha imposto severe restrizioni ai genitori omosessuali, arrivando a rimuovere alcune madri lesbiche dai certificati di nascita dei loro figli, i quadri di Fratino diventano atti di resistenza fenomenologica. Affermano che l’esperienza corporea trascende le categorie imposte dallo Stato o dalla religione.
Fratino stesso riconosce questa dimensione politica, pur rifiutando di ridurla a un messaggio esplicito: “Sentivo molta pressione conoscendo la situazione politica in Italia, quanto sia difficile per le persone queer avere una famiglia. Forse c’era una mia responsabilità nel creare qualcosa di molto chiaro sulla sua posizione. Ma alla fine, non è così che dipingo. Creo un’opera in modo intuitivo o inconscio, mai molto chiaro sul suo punto di vista. Si tratta di essere in una vita vissuta.”[6]
Questa insistenza sulla “vita vissuta” piuttosto che sulla postura ideologica è profondamente fenomenologica. Per Merleau-Ponty, l’esperienza precede sempre la teorizzazione; il nostro essere-nel-mondo è sempre più ricco e più ambiguo delle nostre tentativi di concettualizzarlo. Allo stesso modo, i dipinti di Fratino non sono mai riducibili a un messaggio politico, anche quando inevitabilmente si inseriscono in un contesto politico.
Questo approccio ha talvolta attirato critiche verso Fratino, in particolare per la sua presunta mancanza di rappresentazione delle persone transgender o razzializzate. La sua risposta è rivelatrice: “I dipinti hanno un pubblico, ma quando li creo, non ne hanno. Sono io che parlo a me stesso, quindi non ho obblighi verso un’idea di comunità nel mio studio, che è l’unico luogo privato e sacro che ho al mondo.”[7] Questa affermazione dello studio come spazio fenomenologico primario, dove l’artista si impegna in un dialogo incarnato con la propria esperienza, risuona profondamente con il pensiero di Merleau-Ponty.
Perché per il filosofo come per l’artista, la verità non è una costruzione astratta imposta al mondo, ma una rivelazione che emerge dal nostro coinvolgimento corporeo con esso. Fratino lavora “intuitivamente o inconsciamente”, lasciando che il suo corpo pittorico dialoghi con il mondo piuttosto che imporre una visione preconcetta. Come spiega: “Dipingere è un piacere e voglio che resti così. Come faresti la pelle? Come faresti il legno? O questa foglia piuttosto che quell’altra? È colore puro, è texture, e provo molto piacere nel cercare di risolvere questi enigmi.”[8]
Questa gioia nel risolvere gli “enigmi” materiali della pittura richiama ciò che Merleau-Ponty chiamava “l’interrogazione della pittura”, quel modo in cui l’arte visiva pone domande al visibile che la filosofia concettuale non può porre. Quando Fratino si domanda come rendere la pelle o il legno, non si tratta semplicemente di un problema tecnico, ma di un’interrogazione ontologica sulla natura stessa di queste sostanze, sul loro modo di apparire alla nostra coscienza incarnata.
La critica Durga Chew-Bose ha colto questa qualità quando scrive che “lo sguardo lunare di Fratino sull’erotico è concentrato su dettagli che eccitano prospettive altrimenti banali.”[9] Questa attenzione ai dettagli sensoriali che trasformano il banale in rivelazione è al cuore dell’approccio fenomenologico. Per Merleau-Ponty, il miracolo della percezione è proprio la sua capacità di rivelare l’extraordinario nell’ordinario, di farci vedere il mondo come se fosse la prima volta.
Fratino condivide questa fascinazione per l’ordinario trasfigurato. I suoi dipinti di scene domestiche, colazione, riposo, lettura, sono impregnati di una qualità di presenza che li eleva al di sopra del quotidiano senza distaccarsene. In “Garden at Dusk” (2024), un uomo sonnecchia a un tavolo mentre un altro si occupa dei fiori sullo sfondo. Questa scena apparentemente banale diventa una meditazione sulle diverse forme di abitazione corporea del mondo, l’abbandono al sonno da una parte, l’impegno tattile con le piante dall’altra.
Questa trasfigurazione del quotidiano si inscrive in una lunga tradizione pittorica, da Vermeer a Bonnard, che Fratino riconosce come influenza. Ma lì dove si distingue è nella sua capacità di infondere questa tradizione di una sensibilità queer contemporanea senza ridurla a una semplice politica identitaria. Come osserva Harry Tafoya, i suoi dipinti sono “meno preoccupati di questioni formali che dell’estasi di catturare scorci impetuosi di stati dell’essere alternativi e di inseguirli verso la luce.”[10]
Questa ricerca verso la luce è letterale in molte opere di Fratino, dove la luce naturale gioca un ruolo importante. In “Waking up first, hard morning light” (2020), i raggi del sole mattutino trasformano una scena ordinaria, un uomo addormentato, in una rivelazione fenomenologica. Questa attenzione alla luce ricorda le riflessioni di Merleau-Ponty sulla pittura di Cézanne, dove la luce non è semplicemente un fenomeno ottico ma una manifestazione della “carne del mondo”.
Per Fratino, questa luce ha una qualità personale e geografica specifica. “Per tutta l’estate, la luce è la luce del Maryland”, dice, riferendosi al suo Stato natale.[11] Questa osservazione risuona con ciò che Merleau-Ponty chiama “stile”, quel modo unico in cui ogni corpo abita e percepisce il mondo. La nostra percezione non è mai neutra o universale; è sempre colorata dalla nostra storia incarnata, dai nostri ricordi, dalle nostre abitudini percettive.
La nozione merleau-pontiana di “stile” permette anche di comprendere l’approccio pittorico eclettico di Fratino. La sua opera mescola liberamente influenze moderniste, Picasso, Matisse, Hartley, De Pisis, senza mai cadere nel pastiche o nella citazione sterile. Queste influenze sono completamente assimilate, trasformate dal suo proprio “stile” percettivo. Come spiega: “Penso che la pittura consista sempre nel reinterpretare, o riciclare, qualcosa che hai visto in precedenza. Nel mio caso specifico, vorrei prendere in prestito la composizione o il soggetto del modernismo, Picasso o Matisse, ma reimmaginando le figure come persone che conosco intimamente.”[12]
Questa reimmaginazione trasforma radicalmente il vocabolario modernista. I corpi cubisti di Picasso, spesso marcati da una violenta oggettivazione del corpo femminile, diventano per Fratino siti di riconoscimento intersoggettivo tra uomini. Le odalische orientaliste sono riconfigurate come uomini gay contemporanei nel loro proprio spazio domestico, sovvertendo la tradizione dello sguardo maschile eterosessuale. Come osserva Joseph Henry, “Se una sensibilità gay mantiene intatto il modernismo, una variante queer invece ne attacca i difetti, sfrutta appieno le sue strategie, o relegano il modernismo al rango di semplice categoria storica.”[13]
Fratino oscilla tra queste posizioni, a volte mantenendo intatto il modernismo, a volte sovvertendolo radicalmente. Ma ciò che rimane costante è il suo impegno verso una fenomenologia incarnata del quotidiano. I suoi dipinti non sono mai semplicemente esercizi di stile o commentari intellettuali sulla storia dell’arte; sono sempre ancorati nell’esperienza vissuta.
Come ha scritto Merleau-Ponty: “Il mondo fenomenologico non è l’esplicitazione di un essere precedente, ma la fondazione dell’essere.”[14] Allo stesso modo, i quadri di Fratino non sono la spiegazione di una realtà preesistente, ma la creazione di un mondo percettivo in cui emergono nuove possibilità di essere. I suoi uomini nudi non “rappresentano” semplicemente l’omoerotismo contemporaneo; fondano uno spazio fenomenologico in cui il desiderio tra uomini diventa una modalità legittima di essere-nel-mondo.
Questa fondazione fenomenologica spiega perché le opere di Fratino hanno provocato reazioni così forti, sia positive che negative. La sua esposizione prevista al Des Moines Art Center in Iowa è stata cancellata quando ha insistito per includere “New Bedroom”, che mostra due uomini nudi che hanno rapporti sessuali. Ciò che lo ha sorpreso non era tanto l’offesa potenziale quanto “la paura che potesse esserci. Lo trovo davvero triste perché dimostrava una aspettativa davvero bassa per la comunità che forse avrebbe celebrato questo.”[15]
Quest’aneddoto rivela il potere persistente dell’arte incarnata di disturbare le norme stabilite. In una cultura sempre più virtuale e disincarnata, dove l’esperienza corporea è o mercificata o cancellata, i dipinti risolutamente carnali di Fratino costituiscono un atto di resistenza fenomenologica. Essi insistono sul fatto che il corpo, in tutta la sua specificità sessuale, sensuale e sociale, rimane il sito primario del nostro essere-nel-mondo.
Questa resistenza non è semplicemente politica o identitaria; è ontologica. In “Fenomenologia della percezione”, Merleau-Ponty scrive: “Non sono davanti al mio corpo, sono nel mio corpo, o meglio sono il mio corpo.”[16] Questa dichiarazione radicale riassume perfettamente ciò che i dipinti di Fratino ci invitano a riconoscere: che non siamo spiriti disincarnati che osservano i nostri corpi dall’esterno, ma esseri fondamentalmente incarnati la cui esperienza è plasmata e resa possibile dalla nostra esistenza corporea.
In un mondo in cui la virtualità digitale e l’astrazione concettuale dominano sempre più la nostra esperienza, questo riconoscimento fenomenologico diventa un atto quasi rivoluzionario. I quadri di Fratino, con la loro celebrazione sensuale della carne, della texture, della luce e dell’intimità corporea, ci ricordano ciò che rischiamo di perdere quando ci allontaniamo troppo dal nostro ancoraggio nel mondo materiale.
Ma ci offrono anche una visione di ciò che potrebbe essere un’esistenza più pienamente incarnata, un’esistenza in cui il piacere, la tenerezza, la curiosità sensoriale e il riconoscimento intersoggettivo non sarebbero eccezioni, ma la norma. Come scrive l’artista stesso: “C’è una ricerca di una bella vita nella pittura, penso che io usi la pittura per avvicinarmici.”[17]
Questa ricerca di una “bella vita” attraverso l’impegno fenomenologico con il mondo risuona profondamente con il progetto filosofico di Merleau-Ponty. Per lui e per Fratino, l’obiettivo non è semplicemente teorizzare o rappresentare il mondo, ma abitarlo più pienamente, più consapevolmente, più sensualmente.
I dipinti di Louis Fratino ci invitano a riscoprire la nostra stessa carne, non come un oggetto che possediamo, ma come il mezzo stesso attraverso cui abbiamo un mondo. Ci ricordano che il nostro corpo non è semplicemente un contenitore di sensazioni o uno strumento di desiderio, ma il luogo stesso del nostro essere, il punto in cui noi e il mondo ci incontriamo e ci creiamo reciprocamente. In un panorama artistico spesso dominato dalla concettualizzazione astratta o dalla provocazione superficiale, questo invito fenomenologico è forse il contributo più prezioso e duraturo di Fratino all’arte contemporanea.
- Roberta Smith, citata in “Louis Fratino”, Wikipedia.
- Alex Needham, “Non vedo l’ora di dipingermi quando sarò vecchio e nodoso”: il mondo sensuale di Louis Fratino, intervista all’artista.
- Maurice Merleau-Ponty, “L’occhio e lo spirito”, Éditions Gallimard, 1964.
- Simon Chilvers, “Louis Fratino vorrebbe diventare intimo”, The Financial Times, 27 settembre 2024.
- Maurice Merleau-Ponty, “Fenomenologia della percezione”, Éditions Gallimard, 1945.
- Alex Needham, “Non vedo l’ora di dipingermi quando sarò vecchio e nodoso”: il mondo sensuale di Louis Fratino, The Guardian, 29 ottobre 2024.
- Ibid.
- Ibid.
- Durga Chew-Bose, “Openings: Louis Fratino”, Artforum, marzo 2021.
- Harry Tafoya, “Quadri di amici e amanti le cui vite interiori splendono intorno a loro”, Hyperallergic, 16 maggio 2019.
- Durga Chew-Bose, “Openings: Louis Fratino”, Artforum, marzo 2021.
- Stefano Pirovano, “Artisti emergenti da osservare: Louis Fratino”, Conceptual Fine Arts, 20 febbraio 2018.
- Joseph Henry, “Amore e solitudine: mettere in discussione i modernismi nella pittura figurativa”, Momus, 1 agosto 2019.
- Maurice Merleau-Ponty, “Fenomenologia della percezione”, Éditions Gallimard, 1945.
- Alex Needham, “Non vedo l’ora di dipingermi quando sarò vecchio e nodoso”: il mondo sensuale di Louis Fratino, The Guardian, 29 ottobre 2024.
- Maurice Merleau-Ponty, “Fenomenologia della percezione”, Éditions Gallimard, 1945.
- Alex Needham, “Non vedo l’ora di dipingermi quando sarò vecchio e nodoso”: il mondo sensuale di Louis Fratino, The Guardian, 29 ottobre 2024.