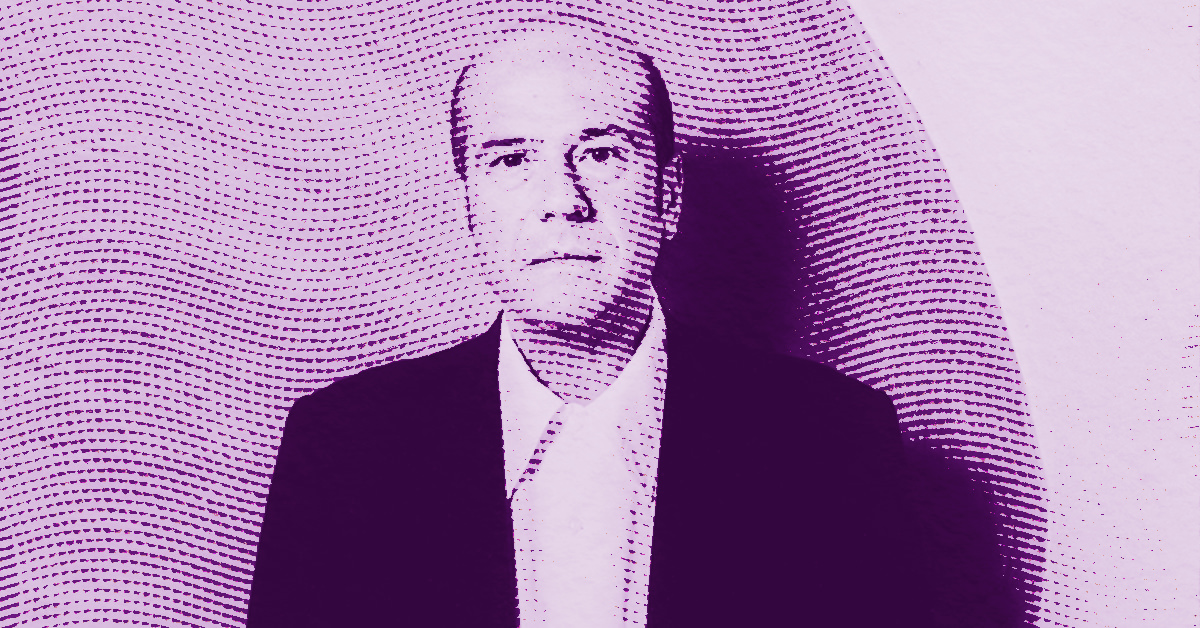Ascoltatemi bene, banda di snob. Esistono ancora in questo mondo asettico dell’arte contemporanea territori preservati dove l’emozione pura resiste ai calcoli mercantili e alle pose concettuali. Nicola De Maria ne è un guardiano tenace. Da più di quarant’anni, quest’uomo nato nel 1954 a Foglianise sviluppa sui muri di tutto il mondo un universo cromatico dove la poesia incontra l’architettura, dove la pittura trabocca dal suo quadro per invadere lo spazio e reinventare il nostro rapporto con il luogo.
In questo mercato dell’arte dove le tendenze si succedono con la velocità di un algoritmo, De Maria mantiene una costanza sconcertante. La sua serie Regno dei Fiori [1], iniziata negli anni 1980, continua a fiorire oggi con un’ostinazione che sfiora il sacro. Questi “regni di fiori” non sono semplici giardini dipinti, ma territori psichici dove l’artista dispiega una mitologia personale fatta di colori primari, stelle stilizzate e case simboliche.
Il percorso di De Maria comincia con una resistenza. Formatosi in medicina con una specializzazione in psichiatria che non ha mai esercitato, sceglie la pittura nel 1977 nel contesto concettuale di Torino degli anni Settanta, quando tutti proclamavano la morte della pittura. Primo atto di ribellione: creare il suo primo dipinto murale a Milano nello stesso anno, poi partecipare alla Biennale di Parigi. Gestualità profetica di un uomo che rifiuta le frontiere tra discipline e supporti.
Il suo riconoscimento arriva nel 1979 con l’integrazione al movimento della Transavanguardia teorizzata da Achille Bonito Oliva. Accanto a Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi e Mimmo Paladino, De Maria incarna però una via singolare: dove i suoi compagni esplorano la figurazione ironica o neoespressionista, lui sviluppa un’astrazione lirica che attinge all’inconscio collettivo. Questa differenza non è aneddotica. Rivela un artista che, sin dall’origine, rifiuta le etichette per scavare il proprio solco.
L’inconscio collettivo
L’opera di Nicola De Maria rivela una comprensione intuitiva dei meccanismi dell’inconscio collettivo teorizzati da Carl Gustav Jung [2]. Questa dimensione psicoanalitica del suo lavoro supera il semplice uso decorativo di simboli universali per raggiungere una vera e propria attivazione degli archetipi di Jung. Egli descriveva l’inconscio collettivo come “una base condivisa dall’umanità, contenente gli archetipi: modelli universali” che si manifestano nelle narrazioni mitologiche e nelle creazioni artistiche. In De Maria questa teoria trova un’applicazione pittorica di rara coerenza.
Le sue stelle non sono semplici motivi ornamentali ma manifestazioni dell’archetipo del cosmo interiore, quella ricerca di orientamento nell’immensità psichica che Jung identificava come fondamentale nell’essere umano. Le case che punteggiano le sue tele evocano l’archetipo del rifugio, del temenos sacro dove può compiersi l’individuazione. Quanto ai fiori onnipresenti, essi incarnano l’archetipo della rinascita perpetua, del ciclo eterno che governa sia la natura sia la psiche.
Questa lettura di Jung si arricchisce osservando la tecnica murale dell’artista. I suoi “Space Paintings”, che invadono le pareti delle gallerie, riproducono il processo di individuazione descritto da Jung: lo spettatore, immerso in questi ambienti colorati, vive un’esperienza di trasformazione in cui i confini tra il sé e lo spazio si dissolvono temporaneamente. Questa dissoluzione non è patologica ma terapeutica, permettendo all’inconscio personale di dialogare con l’inconscio collettivo.
L’uso che fa De Maria dei colori primari si inserisce anch’esso in questa logica archetipica. Il rosso evoca l’energia vitale, la libido nel senso di Jung. Il blu richiama l’infinito spirituale, la trascendenza. Il giallo irradia la coscienza solare, la chiarezza del risveglio. Questi colori, applicati in spesse mani secondo la tecnica dell’antico affresco, non cercano la sofisticazione cromatica ma l’impatto primordiale sulla psiche.
Jung osservava che “gli archetipi appaiono talvolta nelle loro forme più primitive e più ingenue (nei sogni), talvolta anche in una forma molto più complessa dovuta a un’elaborazione conscia (nei miti)”. L’arte di De Maria naviga costantemente tra questi due poli. I suoi disegni su carta conservano la spontaneità del sogno, mentre le sue installazioni murali raggiungono la complessità del mito elaborato.
Questa dimensione psicoanalitica spiega perché le opere di De Maria producono un effetto così particolare sullo spettatore. Esse non si rivolgono solo all’occhio ma a quella “memoria della specie” che Jung collocava nell’inconscio collettivo. Di fronte a un Regno dei Fiori, non contempliamo una semplice astrazione decorativa ma un mandala contemporaneo che attiva le nostre strutture psichiche più profonde. Lo stesso De Maria lo esprime con precisione quando si definisce “colui che scrive poesie con le sue mani immerse nei colori” [3]. Questa formula rivela la consapevolezza dell’artista di attingere a un linguaggio universale che supera la semplice tecnica pittorica.
L’installazione Angeli proteggono il mio lavoro (1986), creata per la sua prima esposizione americana, illustra perfettamente questo approccio. Dipingendo direttamente sulle pareti e sul soffitto dello spazio espositivo, De Maria trasforma l’architettura in un ventre materno colorato dove lo spettatore fa l’esperienza di una regressione positiva verso gli archetipi di protezione e rinascita. Quest’opera non si limita a decorare lo spazio: lo riconsacra attivando la nostra memoria collettiva del luogo protetto.
L’architettura come territorio spirituale
La seconda dimensione fondamentale dell’opera di De Maria risiede nel suo rapporto rivoluzionario con l’architettura e la spazialità. Questo approccio trova le sue radici nella tradizione italiana dell’arte murale, ma la reinventa secondo una logica contemporanea che riecheggia le ricerche architettoniche del Rinascimento italiano. Come Brunelleschi rivoluzionava nel XV secolo l’arte di costruire sottoponendo l’architettura “a una regola che determina le proporzioni tra le diverse parti dell’edificio”, De Maria sviluppa un sistema pittorico che ripensa completamente la relazione tra l’opera e il suo ambiente spaziale.
L’innovazione di De Maria consiste nel trattare l’architettura non come un semplice supporto ma come un partner creativo. I suoi dipinti murali non si limitano a occupare la superficie delle pareti: ne trasformano la natura stessa. Quando dipinge le pareti e i soffitti di una galleria, non decora lo spazio ma lo rifonda simbolicamente. Questo approccio ricorda la rivoluzione di Brunelleschi che, secondo gli storici dell’arte, “coltiva particolarmente la rigore e la sobrietà dei piani” per “creare un effetto d’ottica molto armonioso”.
La tecnica dell’affresco che rivendica De Maria stabilisce un collegamento diretto con i maestri del Rinascimento italiano, ma seguendo una logica inversa. Dove i frescanti del Rinascimento cercavano di creare l’illusione della profondità su una superficie piana, De Maria usa il colore puro per abolire la percezione tradizionale dello spazio architettonico. Le sue pareti colorate non sfuggono più verso un punto di fuga ma irradiano verso lo spettatore, creando un effetto di espansione spaziale che trasforma l’architettura in un cosmo interiore.
Questa rivoluzione spaziale trova la sua espressione più compiuta nelle sue installazioni pubbliche, in particolare Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime (2004), creata per le Luci d’Artista di Torino. Trasformando i lampioni di piazza San Carlo in fiori luminosi, De Maria compie un gesto architettonico di rara audacia: reinventa l’illuminazione urbana come un sistema poetico che trasforma la percezione dello spazio pubblico. Quest’intervento non si limita ad abbellire la piazza: ne rivela la dimensione spirituale nascosta.
L’approccio spaziale di De Maria si inserisce nelle ricerche degli architetti contemporanei italiani che, secondo gli analisti, “uniscono tradizione e innovazione” sviluppando “un uso audace di materiali contemporanei”. Ma laddove l’architettura contemporanea usa il vetro e l’acciaio, De Maria impiega il colore puro come materiale architettonico. I suoi pigmenti naturali applicati secondo la tecnica tradizionale dell’affresco creano superfici che trasformano letteralmente le proprietà luminose e acustiche dello spazio.
Questa dimensione architettonica spiega perché De Maria spesso preferisce esporre in luoghi storici anziché in white cube neutri. Ha bisogno del dialogo con un’architettura preesistente per rivelare la propria visione spaziale. Le sue interventi in palazzi, chiese o spazi industriali riconvertiti creano tensioni feconde tra antico e contemporaneo, sacro e profano.
Il colore diventa per lui un vero linguaggio architettonico. Ogni tonalità possiede una funzione spaziale specifica: i rossi dilatano lo spazio e creano una sensazione di intimità calda, i blu lo elevano verso l’infinito spirituale, i gialli lo illuminano di una luce interna. Questo uso funzionale del colore richiama le ricerche dell’architettura moderna sull’effetto psicologico dei materiali, ma lo applica secondo una logica puramente pittorica.
L’installazione diventa per De Maria un’arte totale che comprende pittura, architettura e poesia. I suoi titoli, spesso lunghi e poetici, non descrivono l’opera ma ne costituiscono un’estensione verbale. “La testa allegra di un angelo bello” o “Universo senza bombe” funzionano come mantra che orientano la percezione spaziale dello spettatore. Queste parole dipinte o scritte sui muri creano una dimensione letteraria dello spazio che ricorda le iscrizioni sacre delle architetture religiose.
Quest’approccio globale dello spazio rivela in De Maria una concezione dell’arte come trasformazione del mondo vissuto. Le sue opere non si limitano ad essere osservate: modificano fisicamente e psicologicamente l’esperienza che abbiamo del luogo. In questo senso, De Maria realizza il sogno dell’architettura moderna di creare spazi che trasformino i loro abitanti, ma attraverso mezzi puramente artistici.
La resistenza del sensibile
In un mercato dell’arte ossessionato dalla novità e dalla trasgressione, De Maria contrappone la costanza di una ricerca che approfondisce incessantemente le stesse questioni fondamentali. I suoi “Teste Orfiche” presentati alla Biennale di Venezia del 1990 [4], tele monumentali di oltre cinque metri di larghezza, rivelano una maturità artistica che assume pienamente le sue ossessioni. Queste opere non cercano né la provocazione né l’effetto moda, ma scavano instancabilmente nella questione dell’emozione pura nella pittura.
La critica americana ha talvolta rimproverato a De Maria il suo rifiuto dell’ironia post-moderna e della decostruzione critica. Questa incomprensione rivela piuttosto la singolarità della sua posizione: in un mondo artistico dominato dalla sfiducia verso l’emozione, egli mantiene una fede incrollabile nel potere trasformativo dell’arte. Le sue opere degli anni 2000 e 2010 confermano questa direzione con titoli espliciti come “Universo senza bombe” o “Salvezza possibile con l’arte”.
Questa posizione non ha nulla di ingenuo. Deriva da una lucidità particolare sulle sfide contemporanee dell’arte. De Maria comprende che la vera sovversione consiste oggi nel riabilitare valori estetici che il cinismo dominante ha discreditato. Il suo uso di colori primari e forme semplici non è frutto di un primitivismo regressivo ma di una strategia sofisticata di resistenza culturale.
L’evoluzione recente del suo lavoro conferma questa orientazione. Le sue opere su carta moltiplicano le notazioni poetiche e i riferimenti alla musica, creando partiture visive dove ogni colore corrisponde a una nota, ogni forma a un ritmo. Questa sinestesia assunta colloca De Maria nella linea dei grandi coloristi che, da Kandinsky a Rothko, hanno cercato di fare della pittura un’arte totale.
Le sue installazioni recenti sviluppano anche una dimensione ecologica che arricchisce il suo discorso senza tradirlo. Regno dei fiori musicali. Universo senza bombe (2023) integra elementi sonori che trasformano lo spazio espositivo in un ambiente sensoriale completo. Questa evoluzione verso l’arte totale rispetta la logica profonda di un artista che ha sempre rifiutato le frontiere tra le discipline.
La longevità della carriera di De Maria, le sue esposizioni nelle più grandi istituzioni internazionali, la sua presenza regolare nelle collezioni pubbliche testimoniano un riconoscimento che supera i fenomeni di moda. La sua arte attraversa le generazioni perché si rivolge a bisogni antropologici costanti: il bisogno di bellezza, di spiritualità, di connessione con le forze vitali.
Questa permanenza in un mondo dell’arte volatile rivela la pertinenza profetica di De Maria. Quarant’anni fa, la sua scelta della pittura nel Torino concettuale sembrava anacronistica. Oggi, mentre le nuove generazioni riscoprono il bisogno di spiritualità e di connessione con la natura, la sua opera appare come visionaria. I suoi “regni di fiori” offrono rifugi psichici in un mondo sempre più disumanizzato.
L’arte come preghiera laica
L’opera di Nicola De Maria compie questo colpo di forza di riabilitare la dimensione spirituale dell’arte senza scadere nel misticismo di basso profilo. Le sue installazioni creano spazi di raccoglimento laico dove la contemplazione estetica si unisce all’esperienza meditativa. Questa dimensione spirituale non deriva da alcun dogma religioso ma da una fiducia fondamentale nel potere riparatore della bellezza.
Quando De Maria dipinge “Regno dei Fiori”, non rappresenta fiori ma crea le condizioni di una fioritura psichica nello spettatore. I suoi colori puri agiscono come mantra visivi che placano l’agitazione mentale e riconnettono con i ritmi naturali. Questa funzione terapeutica dell’arte si collega alle ricerche contemporanee sull’arteterapia, ma la realizza con mezzi puramente estetici.
La ripetizione ossessiva degli stessi motivi, stelle, case e fiori, crea un effetto ipnotico che facilita l’accesso a stati di coscienza modificati. Questa ripetizione non è monotonia ma rimuginio creativo che approfondisce progressivamente la comprensione. Ogni nuovo “Regno dei Fiori” rivela aspetti inediti di questo universo poetico che sembra inesauribile.
L’iscrizione di parole e frasi poetiche nelle sue tele aggiunge una dimensione letteraria che arricchisce l’esperienza estetica. Questi testi non descrivono l’immagine ma creano un controcanto verbale che guida la meditazione. Quando De Maria scrive “La montagna mi ha nascosto la luna, cosa devo fare?”, non pone una domanda aneddotica ma formula l’inquietudine esistenziale fondamentale dell’uomo di fronte all’immensità cosmica.
Questa dimensione spirituale spiega l’attrazione che l’opera di De Maria esercita su pubblici molto diversi. Le sue installazioni attirano tanto gli amanti dell’arte contemporanea quanto i ricercatori spirituali, i bambini quanto le persone anziane. Questa trasversalità rivela la correttezza della sua intuizione: la vera arte si rivolge a ciò che è universale in ogni essere umano.
L’arte di De Maria propone un’alternativa concreta al nichilismo contemporaneo. Di fronte a un mondo disincantato, mantiene viva la possibilità di un’esperienza del sacro attraverso la bellezza. I suoi “universi senza bombe” non sono utopie ingenue ma laboratori di sperimentazione di modalità di essere pacificate. Nelle sue installazioni, per qualche istante, la violenza del mondo si sospende e viene sostituita da un’armonia fragile ma reale.
Quest’opera ci ricorda che l’arte possiede ancora, nonostante la sua mercificazione, un potere di trasformazione spirituale che resiste a ogni recupero. Mantenendo viva questa dimensione sacrale dell’arte, Nicola De Maria compie un atto di resistenza culturale di enorme portata. Ci dimostra che è ancora possibile, nel XXI secolo, creare opere che elevano l’anima senza rinnegare l’intelligenza.
L’eterno presente della creazione
Si impone una evidenza: siamo davanti a un artista di rilievo la cui opera guadagnerà ancora riconoscimento nei decenni a venire. La sua capacità di mantenere viva una tradizione pittorica millenaria adattandola alle sfide contemporanee rivela una rara padronanza artistica. Il suo rifiuto delle facilità concettuali e delle provocazioni gratuite testimonia un’esigenza etica che onora l’arte contemporanea.
L’opera di Nicola De Maria ci insegna che la vera avanguardia consiste talvolta nel preservare ciò che la modernità minaccia di distruggere. Mantenendo vivo il legame tra arte e spiritualità, tra pittura e architettura, tra individuale e collettivo, compie un lavoro di salvaguardia culturale essenziale. I suoi “regni di fiori” costituiscono tanti rifugi dove si preservano valori estetici e spirituali che la nostra epoca ha troppo rapidamente abbandonato.
Quest’opera ci invita inoltre a ripensare i nostri criteri di valutazione dell’arte contemporanea. La novità formale, la trasgressione critica, la decostruzione ironica non costituiscono gli unici criteri di qualità artistica. L’approfondimento paziente di una ricerca, la fedeltà a una visione poetica, la capacità di emozionare ed elevare possiedono una legittimità uguale e forse superiore.
Nicola De Maria ci dimostra che è ancora possibile, anche nel contesto disincantato della postmodernità, creare un’arte che riconcilia l’uomo con le sue aspirazioni più alte. Le sue installazioni ci offrono momenti di grazia che compensano la brutalità della quotidianità e nutrono questa “fame di bellezza” che la maggior parte dei nostri contemporanei sente segretamente.
Di fronte alle sue opere, comprendiamo che l’arte vera non si limita a rappresentare il mondo: lo trasforma rivelandone le potenzialità nascoste. Gli “universi senza bombe” di De Maria non sono evasioni ma prefigurazioni di un mondo possibile dove la bellezza avrebbe la meglio sulla violenza. In questo senso, quest’arte compie la sua funzione profetica più alta: mantiene la speranza di un futuro migliore e ci dona i mezzi spirituali per costruirlo.
L’opera di Nicola De Maria ci ricorda che l’arte rimane, nonostante tutte le vicissitudini storiche, una via privilegiata d’accesso al sacro. In un mondo che ha perso i suoi riferimenti spirituali tradizionali, le sue installazioni offrono spazi di raccoglimento in cui ciascuno può ritrovare il contatto con quella dimensione trascendente che costituisce la peculiarità dell’umanità. Questa funzione antropologica dell’arte, che le avanguardie del XX secolo avevano creduto definitivamente abolita, ritrova in De Maria un’attualità inquietante che ci interroga sui nostri bisogni spirituali.
Così, ben al di là delle querelle estetiche della sua epoca, Nicola De Maria ha compiuto il prodigio di riconciliare l’arte contemporanea con la sua vocazione eterna: rivelare la bellezza nascosta del mondo e offrire agli uomini ragioni di sperare. Quest’opera, che attraversa ormai cinque decadi, ci accompagnerà ancora a lungo nella nostra comune ricerca di un’arte che sia allo stesso tempo contemporanea e senza tempo, sofisticata e accessibile, locale e universale.
- Galerie Lelong & Co., “Nicola De Maria – Regno dei Fiori”, catalogo della mostra, Parigi, 1988
- Carl Gustav Jung, L’uomo e i suoi simboli, Robert Laffont, Parigi, 1964
- ABC-Arte, intervista a Nicola De Maria, Torino, 2018
- Laura Cherubini, Flaminio Gualdoni, Lea Vergine (a cura di), Biennale di Venezia – Padiglione Italia, catalogo ufficiale, Venezia, 1990