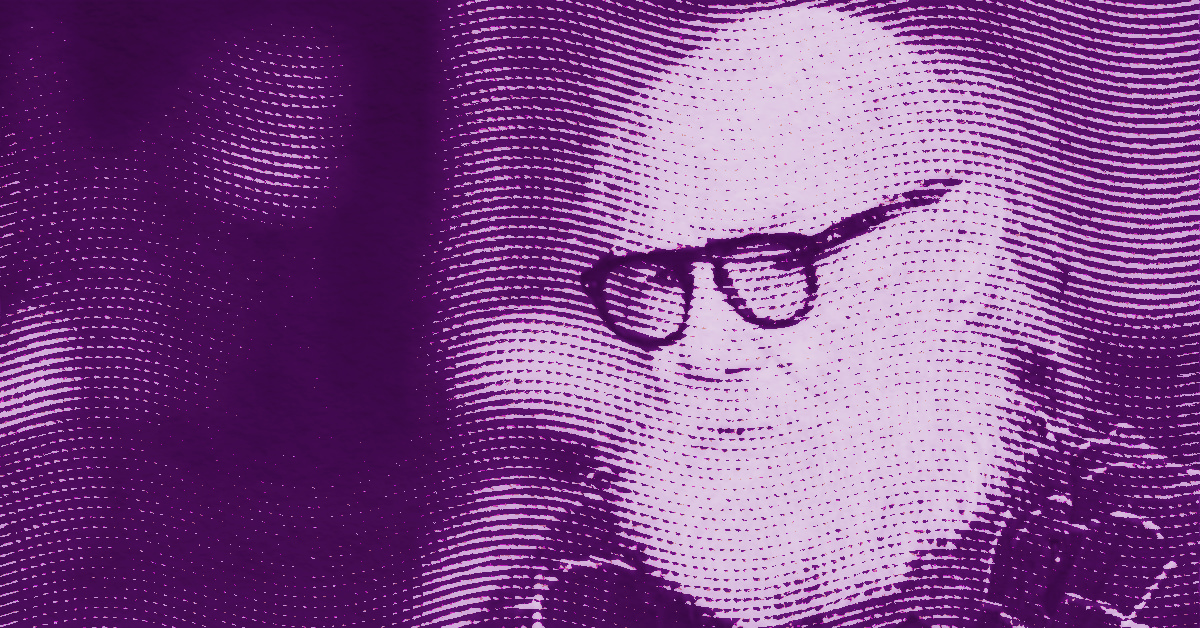Ascoltatemi bene, banda di snob : Paul McCarthy rimane l’artista americano più necessario del nostro tempo, colui che osa confrontare le menzogne fondanti della società di consumo con una brutalità poetica che persino i più cinici tra noi faticano a sostenere. Nato nel 1945 a Salt Lake City in una famiglia mormone, quest’uomo di ottant’anni continua a produrre opere di violenza catartica che rivelano i traumi nascosti dietro la facciata idilliaca del sogno americano. Il suo lavoro, che si estende dalle performance trasgressive degli anni 1970 alle installazioni monumentali contemporanee, costituisce un’archeologia spietata della psiche collettiva americana. McCarthy non è semplicemente un provocatore : è un diagnostico geniale che esamina le patologie del suo tempo con la precisione di un chirurgo e la rabbia di un profeta. Le sue ultime opere, in particolare la serie “A&E” iniziata nel 2019, dimostrano che all’età in cui altri artisti sprofondano nell’auto-parodia, lui continua ad approfondire la sua critica radicale delle strutture del potere contemporaneo.
L’abiezione come rivelatore dell’inconscio culturale
L’opera di Paul McCarthy trova il suo ancoraggio teorico più profondo nella concezione di Julia Kristeva dell’abiezione, quella zona ambigua in cui si dissolvono i confini tra il pulito e lo sporco, l’accettabile e l’innominabile. Julia Kristeva, in “Poteri dell’orrore”, definisce l’abbietto come ciò che “perturba un’identità, un sistema, un ordine” e “non rispetta i confini, i posti, le regole” [1]. McCarthy incarna questa definizione con una radicalità che supera persino le intenzioni teoriche della psicoanalista francese. Fin dalle sue prime performance come “Sauce” nel 1974, in cui si imbrattava il volto di ketchup, maionese e carne cruda, l’artista californiano esplorava già questa liminalità fondamentale. Il ketchup non è esattamente sangue, la maionese non è esattamente sperma, ma questa approssimazione disturbante attiva precisamente i meccanismi psichici che Kristeva descrive: lo spettatore si trova confrontato a sostituti che rivelano le proprie repressioni. Questa strategia raggiunge il suo apice in “Class Fool” (1976), performance in cui McCarthy si gettava violentemente in una classe macchiata di condimenti fino all’esaurimento e all’infortunio. Lo stesso artista riconosce questa dimensione: “Sospetto che questa sospensione dell’incredulità esista negli spettatori, anche se si aggrappano all’interpretazione conscia che il ketchup è ketchup. Sospetto che siano turbati quando il ketchup diventa sangue” [2].
La mostra “Abject Art: Repulsion and Desire in American Art” organizzata dal Whitney Museum nel 1993 consacrava infatti McCarthy come uno dei maestri di questa estetica dell’abiezione, accanto a Mike Kelley e Kiki Smith. Ma là dove i suoi contemporanei si attaccavano spesso a strategie formali, McCarthy spinge l’abiezione verso le sue implicazioni sociali e politiche più esplosive. La sua serie “White Snow” (2009-2016) trasforma la fiaba di Biancaneve in un incubo scatologico dove i sette nani diventano figure falliche minacciose che si muovono in un ambiente sporco di fluidi corporei finti. L’innocenza infantile, fondamento mitologico della cultura Disney, viene letteralmente violata dall’intrusione dell’abietto. Questa profanazione non è gratuita: rivela la violenza repressa che struttura i racconti fondativi dell’America. McCarthy non distrugge l’innocenza, ne svela la natura costruita e le funzioni ideologiche. Il bianco immacolato di Biancaneve diventa il teatro di un’orgia grottesca che mette a nudo i fantasmi pedofili e le pulsioni sadiche nascoste sotto la superficie liscia delle produzioni Walt Disney.
L’installazione “WS White Snow” presentata al Park Avenue Armory nel 2013, di una superficie di quasi 1.600 metri quadrati, rappresentava l’apice di questo percorso. In questa foresta artificiale disseminata di rifiuti e secrezioni, i visitatori erano costretti a muoversi in un labirinto abietto che trasformava la loro passeggiata in un’esperienza di contaminazione. L’architettura stessa diventava abietta, costringendo i corpi a una prossimità scomoda con le materie ripugnanti. Questa spazializzazione dell’abiezione rivela la dimensione politica del progetto di McCarthy: non si tratta più solo di scioccare, ma di trasformare fisicamente l’esperienza dello spettatore per rivelare le nostre complicità inconsce con le strutture oppressive. Purtroppo, quest’opera maggiore è stata distrutta nel 2024 per mancanza di sostegno istituzionale, confermando la resistenza del sistema artistico alle sue critiche più radicali. Come deplorava suo figlio Damon: “Siamo stati pronti a negoziare con chiunque per mantenere l’opera in vita” [3].
L’artista prosegue oggi questa esplorazione con “A&E”, progetto multimediale iniziato nel 2019 con l’attrice tedesca Lilith Stangenberg, dove le figure di Adolf Hitler ed Eva Braun si mescolano agli archetipi biblici di Adamo ed Eva. Questa sovrapposizione audace rivela i meccanismi profondi dell’abiezione politica: come le pulsioni più distruttive dell’umanità si articolano ai miti originari. McCarthy non si limita più a profanare l’innocenza americana, ma attacca le fondamenta stesse della civiltà occidentale. L’abiezione diventa qui uno strumento di analisi storica che rivela la continuità tra le violenze primordiali e le loro attualizzazioni contemporanee. Attraverso questo percorso, l’artista compie ciò che Kristeva identificava come la funzione catartica dell’abietto: “rendere possibile la purificazione, la redenzione, il riscatto”, non attraverso l’evitamento ma tramite la confrontazione diretta con ciò che ci disgusta più profondamente.
La decostruzione spietata dell’ideologia consumista
Oltre alla sua dimensione psicoanalitica, l’opera di McCarthy costituisce una critica sociologica implacabile della società di consumo americana e dei suoi meccanismi di alienazione. Fin da “Hot Dog” (1974), performance in cui l’artista introduceva il suo pene in un panino per hot dog prima di spalmarsi la senape e bere ketchup, McCarthy rivelava le dimensioni sessuali e cannibali che sottendono l’atto alimentare nella cultura americana. L’hot dog, simbolo per eccellenza della ristorazione veloce e dell’American way of life, diventa sotto la sua azione un oggetto di perversione che svela le pulsioni represse del consumismo. Questa strategia di detournement raggiunge la sua maturità con “Bossy Burger” (1991), performance realizzata in scenografie televisive riciclate dove McCarthy, truccato con la maschera di Alfred E. Neuman, parodia i programmi culinari. L’artista trasforma l’atto di cucinare in un’orgia scatologica, rivelando la violenza simbolica che presiede alla preparazione e al consumo degli alimenti nella società dello spettacolo. Come analizza il critico Cary Levine, queste “frenesie alimentari” di McCarthy espongono “le meccaniche del consumo americano” rivelandone il substrato pulsionale [4].
L’evoluzione verso installazioni monumentali negli anni 2000 permette a McCarthy di amplificare questa critica sociologica. “Pig Island” (2003-2010) trasforma lo spazio espositivo in un parco divertimenti distopico dove enormi maiali di fibra di vetro si muovono in un’ambientazione di desolazione consumistica. L’opera funziona come una metafora diretta dell’asservimento delle masse da parte dell’industria dell’intrattenimento: i visitatori diventano letteralmente maiali in un sistema progettato per il loro sfruttamento. Questa dimensione allegorica rivela la sofisticazione teorica di McCarthy, che supera ampiamente il registro della provocazione gratuita per proporre un’analisi sistemica dei meccanismi di dominazione. La sua appropriazione corrosiva delle figure Disney segue la stessa logica: trasformando Topolino in uno stupratore e Biancaneve in una prostituta, l’artista svela le strutture patriarcali e mercantili che organizzano l’industria dell’intrattenimento.
L’installazione “Tree” (2014), scultura gonfiabile di 24 metri installata in place Vendôme a Parigi, illustra perfettamente questa strategia di sovversione. Ufficialmente presentata come un “albero di Natale”, l’opera somigliava in modo evidente a un plug anale gigante, provocando uno scandalo internazionale e la sua distruzione da parte di vandali dopo due giorni di esposizione. McCarthy assumeva pienamente questa ambiguità formale, dichiarando al quotidiano Le Monde che si trattava di uno “scherzo” deliberato. Oltre l’aneddoto, “Tree” rivela la funzione critica dell’arte di McCarthy: introdurre la sessualità repressa nel cuore degli spazi di consumo più prestigiosi. Place Vendôme, tempio del lusso francese, era contaminata dalla presenza oscena di questa scultura che rivelava le pulsioni scopiche e feticistiche che motivano l’acquisto di oggetti di prestigio. L’opera funzionava come uno specchio deformante che rifletteva ai passanti la loro stessa partecipazione a un sistema economico fondato sulla sublimazione delle pulsioni sessuali.
Questa critica dell’ideologia consumista trova oggi una attualità bruciante nelle collaborazioni di McCarthy con suo figlio Damon, in particolare nella serie “Rebel Dabble Rabble”. Questi progetti intergenerazionali rivelano la trasmissione dei traumi culturali e la perpetuazione delle strutture alienanti attraverso le generazioni. L’artista ottuagenario non si limita più a denunciare la società di consumo: esplora le sue mutazioni contemporanee, in particolare l’economia dell’attenzione e la mercificazione degli affetti nell’universo digitale. Le sue installazioni recenti, che generano più di 150.000 immagini e terabyte di registrazioni video, costituiscono esse stesse una metafora di questa sovrapproduzione contemporanea. McCarthy trasforma la sua stessa pratica artistica in critica dell’accumulazione compulsiva che caratterizza l’epoca neoliberale. “L’accumulazione sopra l’accumulazione”, come la descrive lui stesso, diventa il sintomo di una società incapace di gestire la propria produttività. Questa riflessività critica colloca McCarthy al livello dei più grandi analisti della modernità tardiva, in competizione con i sociologi più perspicaci del suo tempo.
La spietata lucidità di un visionario
Paul McCarthy si impone oggi come uno dei pochi artisti contemporanei capaci di mantenere una critica radicale senza cedere alle facilità del mercato dell’arte o alle seduzioni del recupero istituzionale. A ottant’anni continua a produrre opere di una violenza poetica che rivelano l’ipocrisia fondamentale della società americana. Il suo lavoro anticipa con una precisione inquietante le derive autoritarie, le manipolazioni mediatiche e le patologie consumiste che definiscono la nostra epoca. La mostra “Outside is Inside, Inside is Outside. God is Dog, Dog is Dog” attualmente presentata da Hauser & Wirth a Londra dimostra che la sua capacità di rinnovamento resta intatta. McCarthy non è solo un testimone del suo tempo: è un rivelatore chimico che permette di vedere ciò che preferiamo ignorare. In un’epoca in cui l’arte contemporanea scivola troppo spesso nella compiacenza decorativa, egli mantiene viva la funzione critica dell’arte con una intransigenza che impone rispetto. La sua opera costituisce un antidoto necessario contro l’amnesia collettiva e le menzogne consolatorie. Ci ricorda che l’arte vera non deve solo piacere o divertire, ma rivelare le verità scomode che le nostre società si sforzano di rimuovere.
L’arte di McCarthy ci insegna che la vera trasgressione non consiste nel violare i divieti morali, ma nel rivelare i meccanismi con cui questi divieti si costituiscono e si mantengono. In questo modo realizza pienamente quella che Lacan chiamava la “funzione rivelatrice” dell’arte e ciò che Foucault identificava come la necessità di un “ontologia critica di noi stessi”. La sua opera conserva quindi un’attualità bruciante in un mondo in cui le forme di controllo e soggezione non cessano di sofisticarsi e nascondersi.
- Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris, Éditions du Seuil, 1980.
- Paul McCarthy, intervista con Kristine Stiles, in Paul McCarthy, Londra, Phaidon Press, 2016.
- Damon McCarthy citato in The Art Newspaper, 11 settembre 2024.
- Cary Levine, “You Are What (and How) You Eat: Paul McCarthy’s Food-Flinging Frenzies”, InVisible Culture, Università di Rochester, 2003.