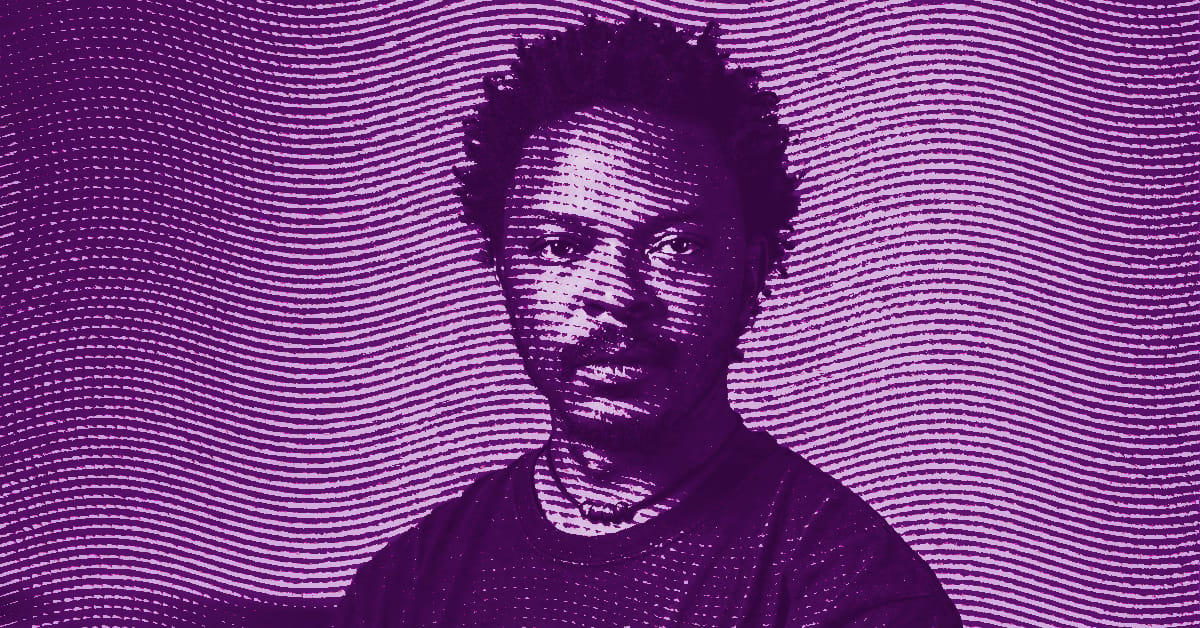Ascoltatemi bene, banda di snob : mentre vi estasiate davanti alle ultime installazioni di arte contemporanea, un uomo nato a Lubumbashi realizza da due decenni un lavoro di intelligenza feroce che dovrebbe farvi tacere. Sammy Baloji non è tra quegli artisti che accarezzano l’occhio nel senso del pelo. È tra coloro che disturbano, che riesumano, che costringono a guardare ciò che si preferirebbe dimenticare. Fotografo di formazione, laureato in lettere e scienze umane prima di specializzarsi in video e fotografia presso l’École Supérieure des Arts Décoratifs di Strasburgo, quest’uomo ha fatto dell’archivio coloniale il suo campo di battaglia e della memoria del Katanga la sua ossessione salutare.
Il suo lavoro non si limita ad estetizzare la rovina o a documentare la desolazione. Opera un gesto molto più violento : sovrappone i tempi, confronta le immagini, mette a confronto il presente congolese e il suo passato coloniale, come si costringerebbero due avversari a guardarsi negli occhi. La sua serie Mémoire (2004-2006) inaugura questo metodo radicale : fotografie d’archivio coloniali infestano i suoi stessi scatti dei siti industriali abbandonati del Katanga. Il risultato è di una brutalità poetica che lascia sbalorditi. Ma non illudiamoci… o meglio, illudiamoci insieme sulla natura del suo gesto, perché non si tratta né di nostalgia né di semplice denuncia. Si tratta di un’archeologia visiva che porta alla luce le stratificazioni di violenza inscritte nel paesaggio stesso.
L’architettura come strumento di dominazione
Cominciamo da ciò che salta agli occhi ma che nessuno vuole vedere : l’architettura. In Baloji, l’architettura coloniale non è mai un semplice decor pittoresco o un residuo da contemplare con quella distanza condiscendente che si riserva alle rovine esotiche. È lo strumento primario della dominazione, il linguaggio di pietra e cemento attraverso cui si è scritto il progetto coloniale belga. Quando Baloji filma gli edifici decrepiti di Yangambi in Aequare. The Future that Never Was (2023), non si limita a mostrare muri che si sgretolano. Mostra come queste strutture continuino a condizionare la vita dei congolesi, come i lavoratori contemporanei occupino ancora gli stessi spazi dei loro predecessori dell’epoca coloniale, compiendo gli stessi gesti negli stessi luoghi, prigionieri di una geometria spaziale ereditata dalla violenza.
L’urbanistica coloniale belga nel Congo, e particolarmente a Lubumbashi dove Baloji è cresciuto, seguiva una logica di apartheid spaziale ben documentata dagli storici dell’architettura [1]. La città fu creata ex novo nel 1910, organizzata attorno al principio della segregazione razziale con il celebre “cordone sanitario” di 500 metri che separava i quartieri europei dalle città africane. Questa distanza, presumibilmente giustificata da considerazioni sanitarie legate alla malaria, tracciava in realtà una carta della gerarchia coloniale iscritta nel terreno stesso. Baloji ha dichiarato di aver vissuto la sua “infanzia in una città interamente organizzata attorno alla realtà industriale e allo sfruttamento delle risorse minerarie”. Questa città è Lubumbashi, precedentemente Élisabethville, cattedrale del rame e monumento alla gloria dell’Unione Mineraria dell’Alto Katanga.
In Still Kongo I-V (2024), Baloji sviluppa una strategia di sottigliezza notevole. Incornicia fotografie aeree d’archivio che mostrano la foresta congolese nel 1958-1959 in cornici di legno di afzelia decorate con motivi ispirati all’Art nouveau belga. Questo gesto apparentemente decorativo cela una violenza concettuale considerevole. L’Art nouveau, quello stile che rese famosa Bruxelles, portava inizialmente il nome di “Style Congo” in riferimento ai materiali e ai motivi congolesi che lo ispirarono. Ecco quindi il circuito completo dell’estrazione: le risorse lasciano il Congo, arricchiscono l’Europa, generano movimenti estetici celebrati come l’apice del raffinamento occidentale, prima di tornare sotto forma di cornici che racchiudono le stesse immagini della distruzione che hanno causato.
Gli edifici coloniali fotografati e filmati da Baloji non sono semplici testimoni passivi della storia. Sono agenti attivi della perpetuazione delle strutture coloniali. La cattedrale di Lubumbashi in stile neoromanico, costruita nel 1921, bloccava volontariamente la vista sul parco e sulla residenza del governatore dal centro città, marcando fisicamente il potere coloniale nello spazio urbano. Le città operaie costruite dall’Unione Mineraria dell’Alto Katanga formavano entità autonome con alloggi, scuole e ambulatori, micro-universi totalitari dove la compagnia controllava ogni aspetto della vita dei lavoratori. Questa architettura paternalista, che si voleva benefica, non era altro che una forma raffinata di controllo sociale.
Baloji comprende che l’architettura coloniale non è mai neutrale. Incarnano una filosofia della dominazione che si perpetua ben oltre l’indipendenza formale. I piani urbani, il tracciato delle strade, la disposizione degli edifici pubblici, tutto ciò continua a strutturare l’esistenza quotidiana dei congolesi secondo logiche ereditate dall’oppressione. Quando affianca nelle sue installazioni piante congolesi e involucri di munizioni in rame trasformati in vasi da fiori da famiglie belghe, rivela come anche la domesticità europea partecipi alla catena estrattivista. Il rame estratto dal Katanga, forgiato in proiettili durante la Prima Guerra Mondiale, poi riciclato in oggetti decorativi presso borghesi belgi: ecco il ciclo di vita osceno di un materiale che porta in sé la memoria di molteplici violenze.
La filosofia dell’invenzione e della distruzione
Se l’architettura è per Baloji il linguaggio visibile della dominazione, bisogna rivolgersi alla filosofia per comprendere i meccanismi epistemologici che hanno reso possibile questa dominazione. L’artista non cita la filosofia a caso nelle sue opere. In Tales of the Copper Cross Garden, Episode I (2017), intreccia le immagini di una fonderia di rame con estratti degli scritti autobiografici di Valentin-Yves Mudimbe, filosofo e poeta congolese la cui monumentale opera L’Invention de l’Afrique (1988) ha rivoluzionato la comprensione delle conoscenze sull’Africa [2].
Mudimbe ha dimostrato che l’Africa così come esiste nell’immaginario occidentale è una costruzione, un’invenzione prodotta da un apparato discorsivo coloniale che includeva l’antropologia, la cartografia, la missione civilizzatrice e le scienze naturali. Ciò che Mudimbe chiama la “biblioteca coloniale”, quell’insieme di testi, classificazioni, cartografie che hanno definito l’Africa dall’esterno, trova il suo equivalente visivo nel lavoro di Baloji. Gli archivi fotografici che l’artista riesuma e riattiva sono proprio gli strumenti di questa “invenzione”: sono stati usati per catalogare, classificare, essentializzare i congolesi, ridurli a esemplari etnografici.
Il gesto artistico di Baloji è profondamente nello spirito di Mudimbe nel suo approccio. Non cerca di opporre una “vera” Africa a un’Africa inventata, ma di rivelare i meccanismi stessi di questa invenzione, di mostrare come gli strumenti della conoscenza coloniale, la fotografia, la cartografia geologica e i piani urbanistici, abbiano partecipato alla costruzione di un’Africa disponibile per lo sfruttamento. Le carte geologiche colorate che presenta in Extractive Landscapes (2019) non sono semplici documenti tecnici. Sono strumenti di potere che segmentano il territorio congolese in zone di estrazione, che lo riducono alle sue risorse minerarie, che cancellano ogni profondità storica e culturale per trattenere solo il valore commerciale del sottosuolo.
Mudimbe ha anche sottolineato il ruolo della Chiesa cattolica nell’impresa coloniale. I missionari non venivano solo a “salvare le anime”; partecipavano attivamente al progetto di rimodellamento delle soggettività africane. Baloji coglie questa dimensione con un’acuità notevole. In Tales of the Copper Cross Garden, i canti corali che punteggiano le immagini della fonderia non sono un semplice controcanto musicale. Richiamano i piccoli cantori congolesi che tengono croci di rame davanti al petto, simbolo di una doppia estrazione: quella del metallo e quella dell’anima. Come Baloji ha formulato con una chiarezza tagliente: “Niente di meno che le croci di rame tenute davanti al cuore dei chierichetti suggerisce come i missionari abbiano tentato di rubare le loro anime sfruttando nel contempo le risorse locali di rame a vantaggio degli Europei”.
Il filosofo congolese era cresciuto in un seminario coloniale, un’esperienza che nutre tutta la sua opera. Baloji, invece, è cresciuto in una città-fabbrica interamente dedicata all’estrazione mineraria. Entrambi comprendono visceralmente come il colonialismo non si limitasse a sfruttare le risorse: cercava di rimodellare le coscienze, imporre nuove categorie di pensiero, distruggere i sistemi di conoscenza locali per sostituirli con le tassonomie occidentali. Le croci di rame del Katanga che Baloji espone, quegli oggetti che servivano da moneta tra il XIII e il XX secolo, testimoniano un sistema economico e simbolico sofisticato precedente alla colonizzazione. L’arrivo della Union Minière du Haut-Katanga ha reso queste croci obsolete, riducendole a semplici curiosità etnografiche.
Questa distruzione dei sistemi di valore locali a favore delle logiche mercantili occidentali è al centro del lavoro di Baloji. Quando presenta tessuti preziosi del Regno Kongo trasformati in “negativi” di bronzo e rame nella sua serie Copper Negative of Luxury Cloth Kongo Peoples (2017), compie un gesto di riappropriazione simbolica. Questi tessuti in fibre di palma rafia, di una finezza paragonabile al velluto, circolavano nelle wunderkammer europee prima di essere relegati allo status di manufatti etnografici. Baloji li rifonde letteralmente nel metallo congolese, come per invertire il processo di decontestualizzazione e di reificazione che hanno subito.
La dimensione filosofica del lavoro di Baloji risiede anche nel suo rifiuto di ogni nostalgia. Non cerca di restaurare un passato precoloniale mitico, cosa che sarebbe cadere nella trappola dell’essenzialismo denunciato da Mudimbe. Al contrario, lavora negli interstizi, nelle zone grigie dove si mescolano passato e presente, archivi e creazione contemporanea. La sua installazione Gnosis (2022), presentata al Palazzo Pitti di Firenze, comprendeva un globo gigante in fibra di vetro nera circondato da riproduzioni di carte storiche dell’Africa. Il titolo stesso, “Gnosis”, rimanda direttamente al sottotitolo dell’opera di Mudimbe: Gnose, philosophie et ordre de la connaissance. Baloji sa che la questione non è produrre una rappresentazione “vera” dell’Africa che correggerebbe le false rappresentazioni coloniali. La questione è comprendere come si producono i regimi di verità, come si stabiliscono gli ordini della conoscenza che rendono certi saperi legittimi e altri inascoltabili.
Verso un’etica della memoria
Cosa fa dunque Sammy Baloji, in fondo? Pratica quello che si potrebbe chiamare un’archeologia critica del presente. Ciascuna delle sue opere è uno scavo che mette in luce le stratificazioni di violenza, estrazione e distruzione che costituiscono il terreno stesso della modernità congolese. Ma diversamente dall’archeologo classico che esume per museificare meglio, Baloji esume per riattivare, per rendere queste storie sepolte attive nel presente. Le sue immagini non sono documenti inerme: sono dispositivi che forzano lo sguardo, che obbligano a riconoscere la continuità tra il passato coloniale e le forme contemporanee di sfruttamento neocoloniale.
Il cobalto e il litio che alimentano oggi i nostri telefoni cellulari e le nostre auto elettriche provengono dalle stesse miniere del Katanga che producevano ieri il rame per l’elettrificazione dell’Europa e l’uranio per le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Questa continuità oscena, Baloji la rende visibile in Shinkolobwe’s Abstraction (2022), serie di serigrafie che sovrappongono campioni di uranio congolese e immagini di esplosioni nucleari. Il messaggio è di una brutalietà chiara: l’atomo che rase Hiroshima veniva dal Katanga. L’energia che alimenta la “transizione ecologica” occidentale si basa sulla stessa logica estrattivista che ha distrutto il Congo per oltre un secolo.
Baloji non offre alcun conforto, nessuna soluzione facile. Il suo lavoro è scomodo perché rifiuta le narrazioni redentrici. Non celebra la “resilienza” africana, quel concetto contenitore che gli occidentali amano tanto per evitare di parlare di responsabilità storica. Mostra invece come le strutture coloniali si perpetuano, come l’architettura continua a limitare, come le logiche estrattiviste si rinnovano sotto nuove vesti. I lavoratori di Yangambi occupano ancora gli stessi edifici, svolgono le stesse attività di classificazione botanica secondo gli stessi protocolli dell’epoca coloniale. Il Congo cosiddetto indipendente rimane intrappolato nelle maglie di una dipendenza strutturale che non si nomina più.
Tuttavia, sarebbe sbagliato vedere in questo lavoro un semplice esercizio di denuncia. Ciò che Baloji costruisce, opera dopo opera, è un’etica della memoria che rifiuta tanto l’oblio quanto la fossilizzazione mnemonica. I suoi archivi non sono lì per alimentare il risentimento o per nutrire una vittimizzazione compiacente. Sono lì per illuminare il presente, per permettere una comprensione senza concessioni dei meccanismi che continuano a operare. Come ha affermato lui stesso: “Ciò che mi interessa come artista è come creiamo un discorso alternativo, come affrontiamo questi modi di pensare stabiliti dall’epoca coloniale e identifichiamo i loro limiti, le loro debolezze.”
Ecco forse il gesto più radicale di Baloji: non accontentarsi di denunciare i discorsi coloniali, ma cercarne le falle, i punti di fragilità, gli interstizi tramite cui possono emergere altri racconti, altri ordini di conoscenza. Il suo lavoro di cofondatore della Biennale di Lubumbashi dal 2008 partecipa a questa stessa logica. Non si tratta semplicemente di esporre artisti congolesi, ma di creare le infrastrutture intellettuali e istituzionali che permetteranno a questi artisti di produrre e diffondere le loro opere secondo i propri termini, senza passare dai filtri e dalle validazioni del mercato dell’arte occidentale.
La radicalità di Sammy Baloji risiede in quella pazienza metodica, quella rigore da ricercatore messo al servizio di una visione artistica che non transige mai sulla complessità. Non semplifica, non spettacolarizza, non trasforma l’orrore coloniale in un prodotto di consumo estetico. Le sue opere richiedono tempo, attenzione, uno sforzo intellettuale che molti spettatori non sono disposti a fornire. Pazienza per loro. Baloji non lavora per il comfort del pubblico occidentale. Lavora per riesumare una memoria, per dare corpo a una storia che si vorrebbe vedere sepolta sotto le macerie degli edifici coloniali. E in questo lavoro di riesumazione, compie forse uno dei compiti più necessari dell’arte contemporanea: costringerci a guardare in faccia ciò che la nostra modernità deve alla barbarie, e ciò che la nostra prosperità continua a costare ad altri.
- Lagae, Johan, “Rewriting Congo’s Colonial Past: History, Memory, and Colonial Built Heritage in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo”, in Repenser les limites : l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2017
- Mudimbe, Valentin-Yves, L’Invention de l’Afrique : Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, Présence africaine, 2021 (édition originale en anglais : Indiana University Press, 1988)